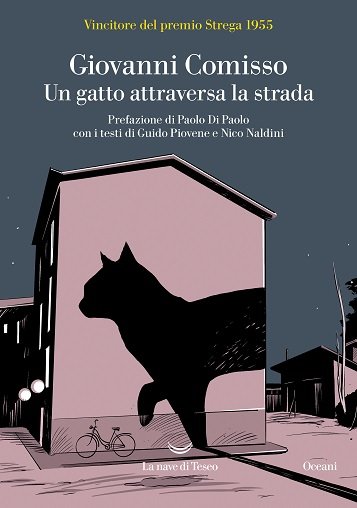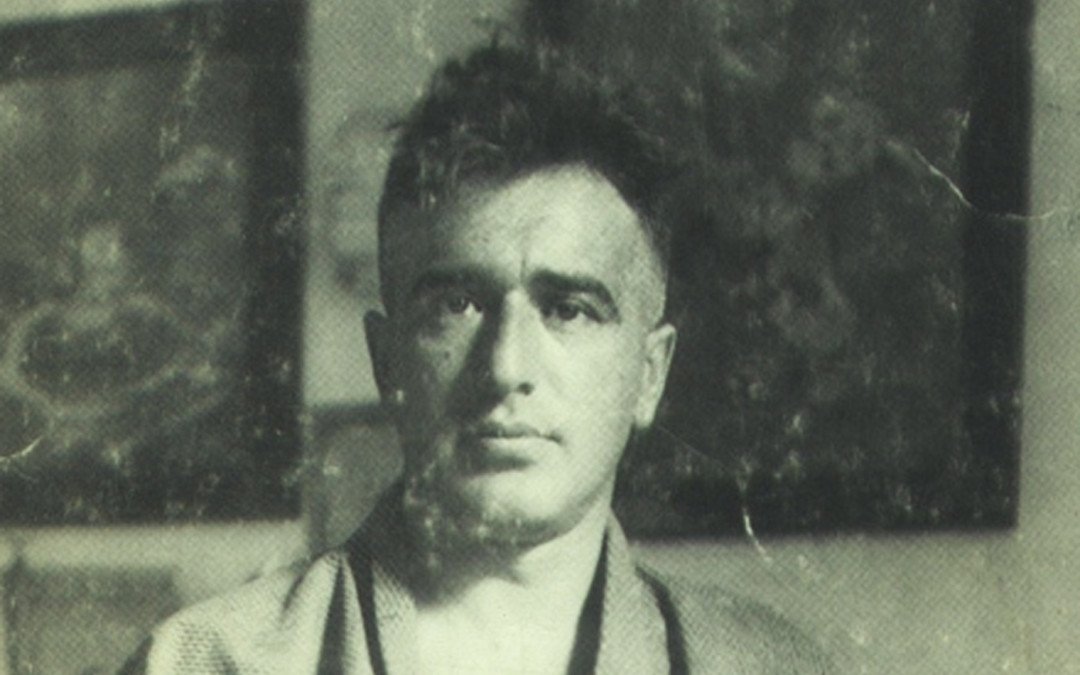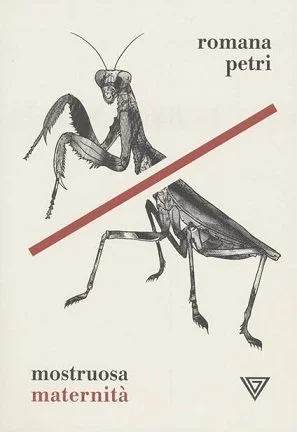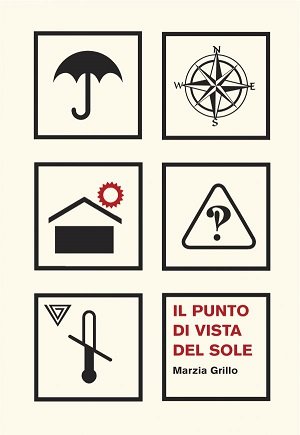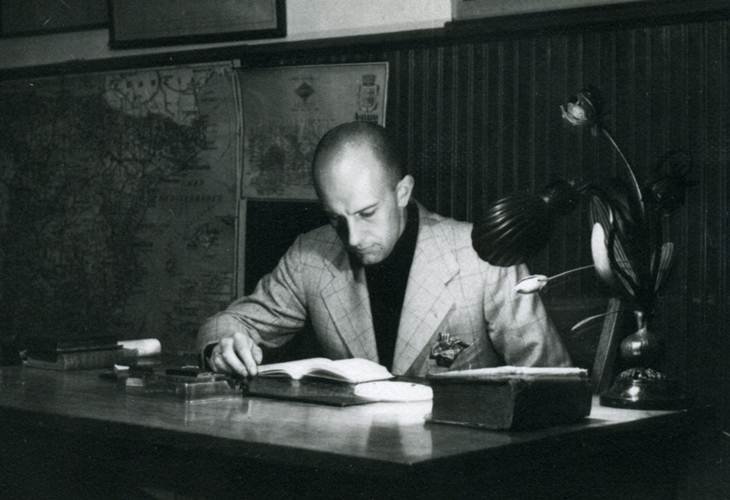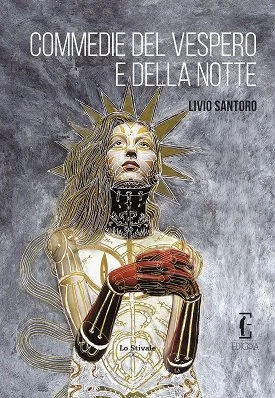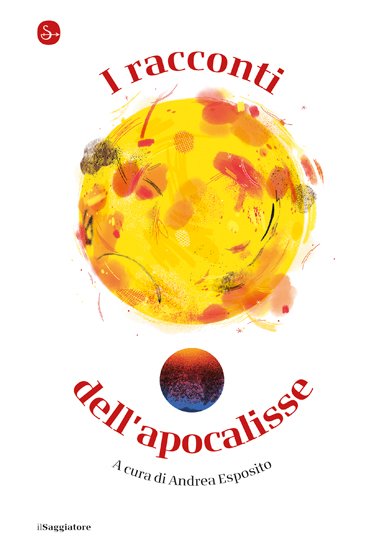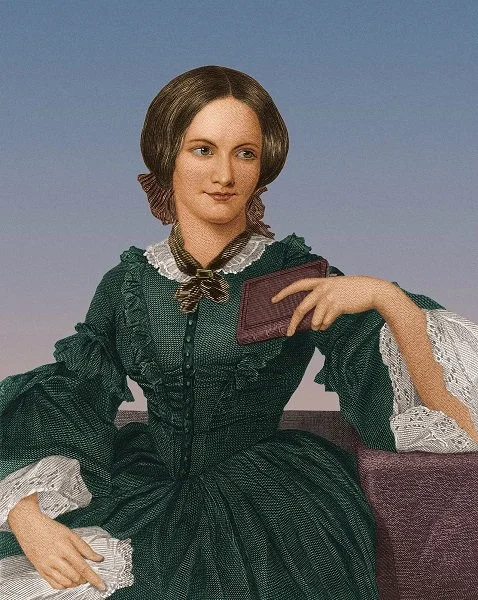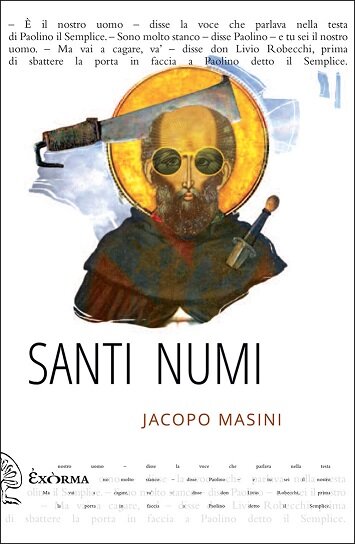Autore: Pauline Melville
Titolo: Uno di questi due paesi è immaginario
Editore: Tamu Edizioni
Traduzione: Pietro Deandrea
pp. 270 Euro 16,00
La casa editrice Tamu, nata a Napoli nel 2020, esordisce con la narrativa portando in Italia i racconti di Pauline Melville, contenuti nel libro ‘Uno di questi due paesi è immaginario’.
Tra Londra e i Caraibi vanno in scena le metamorfosi di questa raccolta di racconti di Pauline Melville. Tra negozi di spezie africane nella metropoli inglese e caseggiati popolari in desolate città dell'America centrale si muovono i personaggi di queste storie, dove emarginati della working class incontrano carismatiche figure dai poteri soprannaturali e il confine tra sogno e realtà si fa labile tanto quanto la distanza tra le due sponde dell'oceano. Nei racconti, la pura cattiveria della vita quotidiana è compensata da un'immaginazione comica, componendo trame inquietanti e allo stesso tempo divertenti, che giocano con il "caleidoscopio genetico" offerto dalla storia delle migrazioni e del colonialismo.
Cattedrale vi propone uno dei racconti contenuti nella raccolta, per gentile concessione dell’editore.
LA RADIO E IL FERRO DA STIRO SONO SPARITI
di Pauline Melville
«Sono una naufraga, Molly!»
In piedi sulla veranda, Donella Saunders contemplava l’arida macchia di giardino fino alla casa dei vicini. Una casa che, come la sua, aveva bisogno di una mano di vernice. La bianca costruzione in legno aveva ceduto in vari punti, con la ruggine insinuatasi fin sul tetto di zinco della rimessa. Tra le due proprietà, la recinzione zigzagava coi paletti tutti storti sotto il peso degli ibischi che, non potati, la percorrevano dall’inizio alla fine. Seduta sulla sedia di vimini, la grassoccia donna bianca, con una catenina di punture di zanzara attorno al collo, non diceva nulla.
«Non riesco proprio a spiegarmi perché tu sia venuta», proseguì Donella. «Siamo in una situazione critica, qui. Estremamente critica».
Oltre la cinquantina, la pelle bruna, era una donna alta e incredibilmente magra, con la fronte spaziosa e l’aria di un’eleganza devastata. Si era tirata via dal volto i capelli castani ondulati, appuntandoli alla buona con dei pettini. Faceva cadere la cenere nel giardino con colpetti nervosi, imbronciata, gli occhi fissi di fronte a sé, senza guardare nulla in particolare.
Molly Summers si crogiolava nella soddisfazione di conoscere il motivo preciso per cui lei era lì, nell’assolata capitale della Guyana. Il fine era quello di arricchire la vita dei suoi scolari in Inghilterra. Consapevole solo in parte del malumore dell’altra donna, stava gustando una tazza di caffè freddo e si esaminava i sandali nuovi. Provò a immaginarsi il negozio di scarpe di Finsbury Park dove li aveva comprati, là a continuare la sua solita attività mentre lei era seduta migliaia di chilometri lontano, sull’altra sponda dell’Atlantico. Dal primo momento in cui, già un po’ di anni prima, aveva mormorato «Oh sì, Signore» nel silenzio e nella quiete della Friends’ Meeting House di Muswell Hill, aveva individuato la propria missione: comprendere, promuovere e sostenere la cultura delle razze oppresse in Inghilterra; garantire parità di trattamento almeno per quanto riguardava la scuola elementare Moseley Road – aveva persino proposto (senza successo) di cambiare il nome alla scuola. Ritrosa di natura, vinceva spesso la propria timidezza per fare interventi alle riunioni collegiali. Frequentava tutti i corsi contro il razzismo organizzati dalle autorità scolastiche locali e lanciava occhiate di rimprovero ai colleghi che facevano osservazioni razzialmente ambigue. Studiava la storia delle Indie Occidentali preemancipazione, provando un sommesso piacere per il ruolo del movimento quacchero nella lotta contro la schiavitù. La fede quacchera faceva per lei, con quel suo unico dio così pallido e semplice e quieto che a malapena pareva esistere. Una grande autostima era un’idea ripugnante per Molly, da sempre in bilico sulla corda tra il cercare di fare del bene e il cercare di non compiacersi per averlo fatto. Ma sulla questione razziale si gloriava di stare proprio dalla parte della ragione. L’opportunità di visitare le Indie Occidentali era giunta grazie a una proposta buttata lì dall’unica insegnante nera della scuola, la quale non avrebbe mai immaginato venisse accolta e messa in pratica: volendo visitare i Caraibi, Molly avrebbe potuto stare da suo fratello. E Molly l’aveva colta al volo: andarci era suo dovere. Soffocando decisa ogni timore, si era consultata con la collega sull’abbigliamento appropriato. Ed eccola qui.
Erano le dieci del mattino. Il sole si stava mettendo in posizione per i colpi di mezzogiorno e Molly avvertì un formicolio lungo gli avambracci, come se minuscoli aghi di cristallo le si infilassero sotto la pelle. Levò una mano paffuta per darsi lievi pacche sul capo. Se solo le avessero ricordato di portarsi un cappello qualsiasi. Il volto gentile e insignificante era incorniciato da un casco curato di capelli grigioferro, con un taglio a scodella con la frangia. Quando sorrideva, l’espressione trepidante unita al taglio infantile la faceva sembrare una di quelle foto sfocate sui giornali, tipo di una bimba di dieci anni assassinata. In realtà aveva cinquantanove anni.
Donella si strinse il kimono giallo attorno a un corpo tutto spigoli, come un insetto stecco, e guardò Molly dicendo: «Scusami il déshabillé, mi devi perdonare. Anche la mia testa è in disordine, stamattina». L’accento era bizzarramente da inglese snob, senza quasi traccia di guyanese, risultato di anni trascorsi in Inghilterra come figlia di un diplomatico d’alto livello. Se ne stava in piedi davanti a Molly, dando boccate di sigaretta brevi e nervose.
«La radio e il ferro da stiro sono spariti», annunciò. «Qualcuno è entrato dalla finestra. Sono decisamente sconvolta. Assolutamente, decisamente sconvolta. Pensi che la domestica non abbia chiuso a chiave la parte superiore della porta? ...O sono entrati dalla finestra? Oltre tutto, questa è l’ultima goccia. Della radio posso fare a meno, ma non del ferro da stiro. Mi è costato trecento dollari. Non abbiamo niente, qui. Sono affranta». Aleggiò dalla veranda verso il salotto, in cerca di un posacenere. Un minuto dopo ritornò: «Scusami tesoro. Ecco alcune riviste da sfogliare». Lasciò cadere sul tavolo qualche copia datata di «Harper’s» e una di «Tatler»: «Temo che il telefono esiga la mia costante attenzione».
Molly la sentì comporre un numero e poi raccontare con voce lamentosa la storia della radio e del ferro da stiro. Era stata scaricata a casa di Donella dal suo riluttante padrone di casa, Ralph Rawlings, che aveva delle faccende da sbrigare in città. Una volta tornato, Molly voleva convincerlo a darle un passaggio in una libreria dove avrebbe potuto trovare del materiale didattico da portarsi a casa. Aveva iniziato a collezionare piccoli oggetti come una calabassa, cartoline, manufatti amerindi, quel tipo di cose che potevano diventare uno stimolo durante le lezioni. Adesso le servivano libri, libri di racconti e storie illustrate.
Prese svogliatamente una rivista e la rimise subito giù. Una nera grassa e vecchia uscì sulla veranda della casa di fronte e rovesciò in giardino il contenuto di una pentola. Il caldo teneva Molly incollata alla sedia. Le venne in mente la notte in cui era arrivata all’aeroporto di Timehri. Nulla l’aveva preparata alla bellezza di Georgetown. Le strade erano le più ampie che avesse mai visto. Verso il cielo si assottigliavano palme reali alte e slanciate, il fogliame stagliato contro le nubi notturne come un ragno danzante sulla punta di un bastoncino. Il taxi costeggiava palazzi coloniali antichi ed eleganti, in cui tramezzi e verande parevano bianchi merletti lignei, e proseguiva lungo ponticelli per attraversare reticoli di canali. Ma il mattino seguente, al suo risveglio, la città le sorrideva con denti putridi. Molly si trovava su una fogna a cielo aperto. Un’esitante passeggiata le aveva rivelato che la città era costruita su un sistema di scarichi e canali stagnanti, odorosi di liquirizia e ostruiti da spazzatura. In uno di questi, un enorme ratto rigonfio galleggiava a pancia in su. Molly era scioccata. Più tardi, col suo passo regolare da maestrina, aveva raggiunto l’argine marino, gettando lo sguardo oltre il mare rosa metallico, dove immaginava si trovasse l’Inghilterra. Uno di questi due paesi è immaginario, aveva pensato. E credo che sia questo.
Donella era ferma sull’uscio. Dietro di lei, la domestica dall’incarnato d’ebano teneva lo sguardo basso, intenta a spolverare con scrupolo e a spostare oggetti attorno al tavolo.
«Mia cara, saresti così gentile da porgermi le sigarette? Ti prego di comprendere che mi hai colta in un tremendo stato confusionale, a causa dell’effrazione. Maxine! Portami dei fiammiferi, per cortesia». La domestica le portò i fiammiferi. «Sarà il caso di recarmi al mio guardaroba per trovare qualche abito da gettarmi addosso dopo la doccia. Sai, in Inghilterra facevo la doccia con qualunque freddo ci fosse, incurante di quali mie parti si stessero congelando fino a staccarsi. Se ben ricordo, gli inglesi non si detergono troppo frequentemente». Poi se ne andò in un’altra stanza della casa.
Il legno della veranda scricchiolò, dando per un momento a Molly l’impressione di trovarsi sul ponte di un’enorme nave bianca che veleggiava senza meta sulla terraferma. Scosse la testa per scacciare quella sensazione d’irrealtà e si alzò dalla sedia per spostarsi in fondo alla veranda, dove Maxine stava spazzando. L’acqua sporca e maleodorante del canale di cemento lungo la strada le rivoltò lo stomaco. Molly fece per incrociare lo sguardo di Maxine con un sorriso. La domestica la ignorò risoluta.
Qualcosa si avvicinava giù dalla strada. Molly sgranò gli occhi: a prima vista sembrava un albero errante. Guardò di nuovo: era un uomo, nero e magro, interamente rivestito di stracci e brandelli d’indumenti che tempo, sudore e calura avevano reso neri come la sua pelle. I capelli raggrumati e selvaggi, l’andatura maniacalmente regolare, le gambe rigide come rami ricoperti da pezze svolazzanti di tessuto. A piedi nudi, procedeva con velocità stupefacente, gli occhi fissi davanti a sé.
«Chi è questo, Maxine?»
«Il Re degli Stracci», rispose, masticando uno stecchino.
«Che fa?»
«E che ne so? Cammina e basta».
Maxine teneva ancora il broncio perché Donella l’aveva accusata di non aver chiuso a chiave la porta. Continuò a spazzare in modo sistematico, poi aggiunse con un ghigno: «Forse cammina per qualcuno». «Che intendi dire?» Molly si chiese se voleva dire che aveva qualche commissione da sbrigare.
«Forse cammina per far fuori qualcuno». Controsole, strizzò gli occhi guardando Molly. «Noi la possiamo fare, ’sta cosa qui, sai? Camminerò io per te». Le puntò il dito contro come a fingere una minaccia, poi si mise a ridere.
Donella ricomparve vestita con pantaloni grigio chiaro e una costosa camicetta fatta su misura. Maxine le servì la colazione in veranda: «Perdonami, cara, se consumo la mia colazione. Suppongo tu l’abbia già fatta».
«Non preoccuparti», disse Molly con una sopportazione da martire, mentre la guardava rimpinzarsi di uova strapazzate e pomodoro. Dalla bocca le cadde del cibo sul tavolo: «Sai, quand’ero in Inghilterra ero in ottimi rapporti con la famiglia del Duca di Blenheim. Sua cugina era una mia carissima amica. Li conosci, per caso?»
«Temo di no. Sono un po’ fuori dalla mia portata», rispose Molly con aria compiaciuta.
Donella continuava a cianciare: «Sì, venne a farmi visita in clinica quando nacque mio figlio – così ubriaca, mia cara, che continuava a cadermi attorno al letto, pregandomi di farle tenere in braccio il bambino e io che le dicevo: ‘Ehm… no… per favore no’. Mi viene quasi da dire che, se tornassi là adesso, si aspetterebbe le spazzassi i pavimenti». Si pulì la bocca con uno di quei tovagliolini di carta strappati in quattro per farli durare più a lungo: «Lasci quel paese e a nessuno importa un cappero!» aggiunse con amarezza.
Suonarono alla porta. Dopo un paio di secondi, Ralph Rawlings attraversava l’ampio pavimento verniciato per venire a salutarle. Era un mulatto robusto e quasi calvo, di circa quarantacinque anni, con una camicia sgargiante e le scarpe che cigolavano. Si aggiustava di continuo gli occhiali dalla montatura nera sul naso: «C’è una specie di rivolta di polli, in centro».
Ralph sembrava sempre esasperato, impaziente. Ora si sentiva particolarmente oppresso da questa straniera bianca che la lontanissima sorella gli aveva affibbiato, a cui doveva fare gli onori di casa.
«Che tipo di rivolta?» Donella accentuò un leggero panico.
«Stamattina dovrei svolgere una sorta di supervisione per una persona in città».
«A quanto pare è arrivato un po’ di pollo dagli Stati Uniti a metà prezzo. La gente ci si scanna. Il problema è la distribuzione, in ’sto cacchio di paese. La distribuzione, come sempre».
«Chiamerò immediatamente il negozio, devo avvisarli che sono troppo affranta per svolgere supervisioni oggi. La perdita della radio e del ferro insieme è una catastrofe. Coglierò l’occasione per volare nel Rupununi. È da giorni che tento di organizzare un volo per andarci. Quindi, Ralph, come potrei persuaderti ad accompagnarmi in aeroporto? La mia auto è fuori servizio, finché non giunge la nuova frizione in volo da Miami. Ho la valigia bell’e pronta». Batté le mani con un entusiasmo da ragazzina.
Ralph guardò l’orologio: aveva un paio d’ore libere e Donella gli era utile, con quei suoi contatti nel ramo trasporti e le conoscenze per il commercio di legname.
«Che ne dici di venirtene in aeroporto con noi?» domandò a Molly.
«Beh, per stamattina avevo in programma di andare in centro a comprare un po’ di libri e materiali per i miei studenti…»
Donella la interruppe: «Che sciocchina che sei, mia cara. Tutti quei libri vengono dall’Inghilterra, puoi comprarteli al ritorno. Oltretutto ne abbiamo già così pochi qui, ci manca solo che tu te ne parta con metà della letteratura del paese».
Molly non provò neanche a discutere. La strada per l’aeroporto era lunga e dritta. Molly rimbalzava su e giù tra le molle rotte del sedile posteriore. Di tanto in tanto spuntava tra la boscaglia il marrone del fiume Demerara. Donella si rivolse a lei dal sedile anteriore: «Vedi Molly, ho una cara amica, la mia alter ego, che è rimasta bloccata nella sua fattoria nel Rupununi. Non ha nulla da mangiare, letteralmente nulla, se non farina. Lei conta su di me. Il gregge le si è ammalato di rabbia. Ora è stato vaccinato, ma non potrà vendere animali per tre mesi. La situazione è decisamente critica».
Si rivolse a Ralph: «Ho a mia disposizione una quarantina di litri di lattice. A quanto me li compreresti?»
I due si misero a contrattare accaniti sul prezzo.
Molly si aggrappò al finestrino per guardare fuori. Lungo il ciglio erboso a lato della strada sfrecciava verso di loro un uomo scuro, basso e mingherlino, con un piede sul pedale della bicicletta. All’avvicinarsi dell’auto, Molly lo sentì tirare su il catarro dal fondo della gola. Lo sputo la colpì dritto in fronte. Si ritirò svelta contro il sedile e prese dalla borsetta un fazzoletto per ripulirsi, che poi gettò di soppiatto fuori dall’auto. Non c’è da stupirsi, pensò, vista la storia del luogo, che qualcuno debba sputare su una faccia bianca. Si sentì rincuorata dall’essere così magnanima e comprensiva riguardo all’accaduto. Sempre impegnati a trattare sui litri di lattice, gli altri non si erano accorti di nulla. Dopo un po’ Ralph accostò per comprare lungo la strada tre fette di ananas fresco tagliate per lungo, da una donna indiana con lo sguardo penetrante. Molly rimase sul sedile posteriore, sorridente. Mi dà sui nervi, pensò Ralph nel rimettersi alla guida.
Attraversarono un aeroporto in preda al caos. L’aria condizionata era rotta e una moltitudine di gente assediava il solo uomo dietro al banco del check-in, con mani che sventolavano biglietti e permessi di soggiorno per attirare la sua attenzione. Seduti sulle valigie accanto al banco, altri passeggeri si rifiutavano di andarsene, anche se il loro volo era stato cancellato. Ralph sospinse Molly verso uno spazietto libero in mezzo alla folla. Attorno al telefono, un gruppetto sconsolato guardava un uomo sbattere su e giù la cornetta per cercare di farla funzionare. Donella se ne andò a cercare di organizzarsi il volo. Molly soffocava il proprio disgusto di fronte a quella baraonda.
«Scusami Ralph», disse, «devo andare alla toilette».
Si fece strada per l’atrio pieno di gente, col rimpianto di non aver fatto un salto in libreria come programmato. Quella confusione la turbava. Raggiunto il bagno delle signore, venne colpita da un tanfo di marcio. Trattenendo il respiro, entrò in uno dei servizi: il water era stracolmo di merda. E così l’altro, e l’altro ancora. Uscì di corsa e riprese fiato: «Non è molto bello lì dentro», disse in tono di scuse.
«Dovrebbero fare qualcosa per questo posto», rispose Ralph, cupo in volto.
Andarono al bar al piano di sopra. Era buio, ma non così affollato come all’esterno. Una nera con il grembiule a quadretti bianchi e verdi ciondolava indolente dietro al bancone: «C’abbiamo un blackout… Niente bevande fresche, solo aranciata frizzante o amarena», disse mentre passava un pezzo di carta su e giù per il bancone.
Ralph ordinò vodka e amarena, Molly finì per ritrovarsi con un’aranciata che non voleva. Le era venuta la nausea. «Vedi quell’uomo laggiù», le fece Ralph. «È il ministro per lo Sport, a quanto pare soffre di cuore e dovrebbe dimagrire».
Molly si voltò a guardare un gruppo di uomini afroguyanesi che bevevano e ridacchiavano nell’angolo della sala. Rideva anche il ministro, ma pareva inquieto allo stesso tempo, gli occhi che guizzavano a destra e sinistra come se nel bar potesse esserci un nemico. «Ralph Rawlings!»
Spalancò le braccia verso Ralph un’elegante donna malese, con i capelli neri in una permanente ben curata e una boccuccia a bottone. Il suo completo di lino rosso dava uno spruzzo di colore all’oscurità del bar. Molly si sforzò di sorridere, mentre attendeva di essere presentata.
«Signora Chan, come va? Questa è Molly Summers, in visita dall’Inghilterra».
Una rapida stretta di mano e la signora Chan si rivolse di nuovo a Ralph: «Beh», sospirò, «sono dovuta tornare. Pensavo di essermi sistemata a Miami per sempre, ma poi mi sono risposata con un guyanese e sono dovuta tornare».
Si diede un’occhiata intorno e un velo di disgusto le passò sul volto. Si accorse che Molly la stava fissando: «I miei figli sono rimasti, però», aggiunse con orgoglio, «ora sto proprio andando a trovarli».
Abbassò la voce in modo da essere appena percepibile nel baccano del bar: «Anche Joan Robson è tornata», disse con malevola soddisfazione.
«Guardala là. Te la ricordi com’era sempre brillante? È successo qualcosa. Stava alla Columbia University. Qualche storia, razzismo… è successo qualcosa di orribile. Un suicidio… qualcosa. C’è stato anche un incidente stradale, guarda che cicatrici ha in faccia».
Molly esaminò l’esile donna dall’incarnato color miele che sedeva al tavolo accanto. La pelle del volto delicato era a chiazze più chiare. Innesti cutanei. «Era così bella!» continuava la signora Chan, mascherando a stento la propria esultanza. «Ha un corpo che sembra vecchio, adesso. C’è stato una specie di esaurimento nervoso. Anche cocaina, ho sentito… Pare una appena uscita dalla riabilitazione, non credi?»
Un truce compiacimento le brillava dagli occhi neri: «In ogni caso… è tornata anche lei. Commercia in peperoncino. Il che mi ricorda… Ralph, vuoi comprare del cemento? Posso vedermela io con il carico, ma non con i dazi, con quelli proprio no. Ti chiamo quando rientro, tu pensaci. Beh, suppongo sia ora di andare a dimenare un po’ il didietro per quelli dell’immigrazione».
Ralph scosse la testa, nel guardarla sgusciare via tra i passeggeri in attesa: «Sono le donne, oggi, a fare tutti gli affari», disse, come se anche lui sentisse l’indefinibile subbuglio che colpiva Molly.
All’arrivo di un volo da Trinidad a lungo atteso, si levò un urlo di gioia. Sulla camicia di Ralph, sotto le braccia, erano comparse due chiazze scure di sudore, e ora stava litigando con quella del bar, che per sbaglio gli aveva servito acqua naturale al posto della vodka. La ragazza si stava sbellicando dalle risate per il proprio errore.
Una nera in avanzato stato di gravidanza e i capelli molto corti, che aveva tenuto d’occhio Molly, colse subito l’occasione per scivolarle proprio di fronte. Molly dovette piegare il capo per sentire cosa le diceva: «Ce l’hai un dollaro per me, per favore?» Il pancione le sollevava il vestito sul davanti e lo faceva lungo di dietro, come una bambina.
Parlava sottovoce. Molly frugò nella borsetta e le diede volentieri tre dollari. Lei li prese e sparì. La sala buia brulicava di conversazioni: Molly aveva la sensazione di trovarsi sott’acqua. Incapace di respirare liberamente. Chiuse gli occhi per cercare di concentrarsi sullo scopo del proprio viaggio. La voce squillante di Donella penetrò il rumore diffuso: «Che disperazione».
Stava giusto di fronte a loro, le mani sui fianchi. «Niente voli! Freddie deve aspettare la consegna di un qualcosa bloccato alla dogana. È devastante. La mia alter ego morirà di fame».
I tre si trascinarono per il parcheggio dell’aeroporto: Donella a lamentarsi torcendosi le mani, Ralph in un bagno di sudore, e dietro Molly che camminava sulle punte per via dell’asfalto, che le stava bruciando la pianta dei piedi perfino attraverso i sandali. Un calore disumano e incessante sostituì la confusione vorticosa dell’aeroporto. Molly sentiva di essersi trasformata in un miraggio, luccicante e irreale. Il suolo irradiava calore. Prima di salire in auto, si sollevò dal petto il vestito blu di cotone, ormai fradicio. Il sedile le ustionava le cosce. Si sentiva girare la testa.
«La macchina c’ha ancora tutt’e quattro le ruote, signore… L’ho tenuta d’occhio io per te».
Ralph diede al monello un po’ di spiccioli e si infilò alla guida. Molly si appoggiò sfinita allo schienale non appena ripartiti. I pensieri le si facevano sconnessi, non riusciva a concentrarsi su nulla. Chiuse per un istante gli occhi, ma poi di colpo li riaprì e vide una distesa infinita di cielo azzurro e due nuvole bianche come meringhe. In lontananza una macchiolina nera, un avvoltoio, volteggiava sulla boscaglia. Chiuse di nuovo gli occhi: troppo cielo, pensò. Nel viaggio di ritorno, dietro le palpebre le fluttuavano diverse immagini: la mendicante incinta che teneva una lezione nella sua scuola di Londra; Maxine, la domestica, che guardava un espositore di scarpe al negozio di Finsbury Park mentre con noncuranza masticava uno stecchino. Arrivati in città, Ralph passò davanti allo Stabroek Market, verso la banca Chase Manhattan. Molly intravide il Re degli Stracci, stavolta immobile accanto a una pila di gusci di cocco secchi, mentre parlava a un uomo che teneva in mano un vassoio con degli orologi in vendita. Accostarono davanti alla banca, e dal marciapiede la gente si riversò attorno all’auto. Molly cercò di sopprimere una sensazione di ripugnanza verso quell’ammasso di facce sconosciute: facce color mogano, facce cannella, facce ebano, facce agata. Anelava alla fresca quiete della Meeting House.
La sagoma si avvicinò al suo lato dell’auto con una tale rapidità che lei ebbe appena il tempo di accorgersene. Per qualche secondo il sole accecante le impedì di vedere che si trattava di un bianco, di venticinque anni al massimo. La barbetta grezza, corta e ispida gli luccicò rossiccia sulla parte inferiore del viso, mentre si sporgeva dentro il finestrino. Aveva i capelli corti tagliati a spazzola, come un soldato o un detenuto. Il viso arrossato dal sole dava intensità a quegli occhi azzurri. Nel chinarsi verso Molly, sbatté le palpebre: «Sei inglese?» Aveva un accento londinese cockney.
«Sì».
Per lo stupore, Molly corrugò la pallida fronte.
«Dammi dei soldi», piagnucolò in tono minaccioso.
Lei lo fissava incredula. «Dammi dei soldi, voglio mangiare».
Molly tentò debolmente di alzare il finestrino, ma la manovella era rotta.
Lui insisteva: «Ero nella prigione di Pentonville, la conosci? Vicino a Kings Cross».
Lei annuì senza dire una parola. Quello spingeva la testa sempre più dentro l’auto, mentre Molly si ritraeva nel suo nido di doppi menti.
«Vivevo a Streatham Hill. Le conosci quelle zone?»
Annuì di nuovo, ammutolita, la bocca secca. L’immondizia nel canale di scolo lo fece scivolare indietro di un passo: gli vide le scarpe da ginnastica sudice e senza lacci, i jeans stracciati al fondo, la canotta blu scuro strappata e macchiata.
Alzando gli occhi, lui le sembrò enorme. Un’aureola fiammeggiante gli danzava attorno alla testa, che eclissava il sole, mentre il cielo si estendeva alle sue spalle.
«Mia moglie m’ha lasciato, ho avuto un esaurimento nervoso, è stato lì che m’hanno messo a Pentonville. M’ha spedito qui il dottor Rhodes, di sicuro avrai sentito parlare del dottor Rhodes. È lui che m’ha spedito qui. Lui m’ha spedito qui».
La voce riecheggiava nelle orecchie di Molly. «Aiutami, devo tornare a casa. Sto cercando di tirare su i soldi del biglietto».
«Ma… ma», balbettò Molly, «ma tu sei inglese, non dovresti fare così».
Le stava accadendo qualcosa. Sembrava che il sole avesse rotto gli ormeggi e girasse in tondo nel cielo. Sentì di nuovo quella voce, che ora pareva lontana: «Dai, dammi almeno i soldi per mangiare. Sto morendo di fame».
Ralph uscì dalla banca, spinse via l’uomo e salì in auto. Sul sedile posteriore, Molly emetteva piccoli gemiti. «Tutto bene ragazza?» le domandò preoccupato.
«È inglese… quel mendicante… un bianco».
Si rese conto che Donella e Ralph si erano voltati indietro e la osservavano in modo strano. Di colpo si sentì consumare tutta da una rabbia enorme, come se in un certo senso fosse stata ingannata. Provò a parlare, ma non le venne neanche una parola. Ralph si accorse che le mancava l’aria, e che le stavano spuntando sul viso delle chiazzette viola. Molly provò a correggere il proprio errore: ciò che voleva dire le era perfettamente chiaro in testa e avrebbe rimesso tutto a posto. Avrebbe messo fine agli sguardi dubbiosi e accusatori sulle facce di quei due che la fissavano dai sedili davanti. Ma le labbra si muovevano senza produrre suono, come un pesce fuori dall’acqua. Accasciata sul sedile posteriore, cominciò a farfugliare. Aveva i capelli grigi zuppi di sudore. Un bimbo la punzecchiò attraverso il finestrino per cercare di venderle delle noccioline.
«Che diamine!» pensò Ralph. «Non mi dire che ’sta donna s’è fatta tutto il viaggio fin qui per morirmi sul sedile di dietro». Mise in moto e si diresse verso l’ospedale pubblico.