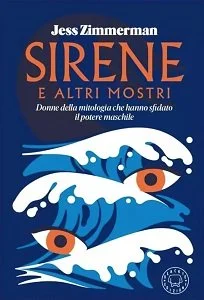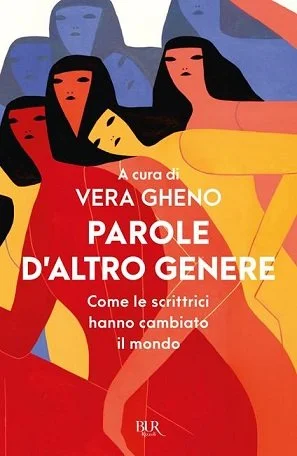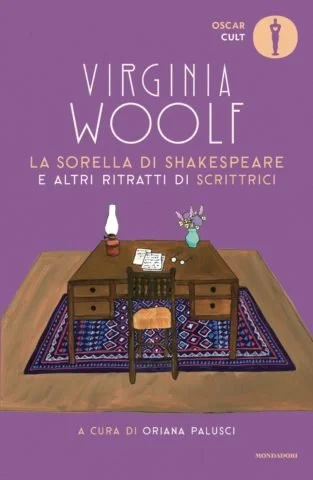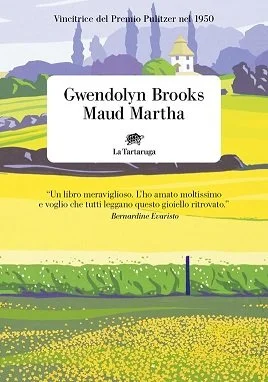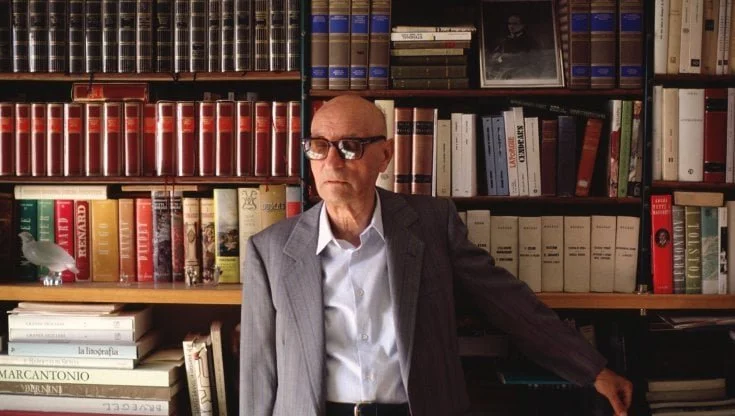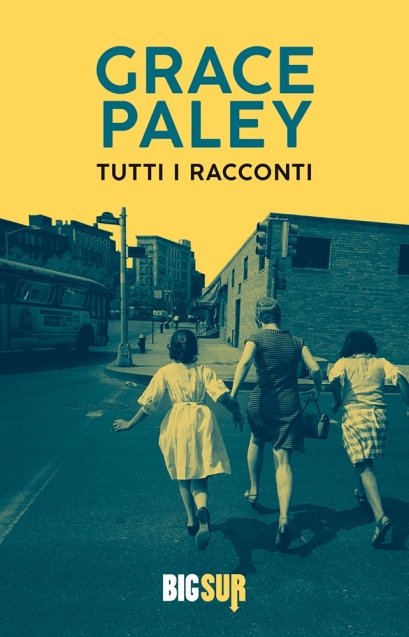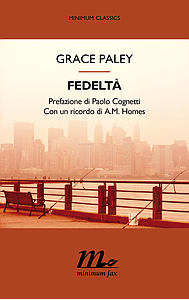di Giordana Restifo
Un anno fa usciva un approfondimento su un testo intitolato Le figlie di Saffo (Garzanti, 2024), in cui l’autrice, Selby Wynn Schwartz, racconta le vite di donne straordinarie che hanno spezzato le catene delle convenzioni sociali e del patriarcato ricercando la libertà. Queste figure discendevano, ognuna a proprio modo, dalla poetessa greca Saffo.
Quest’anno inizia, forse non a caso, con Sirene e altri mostri. Donne della mitologia che hanno sfidato il potere maschile di Jess Zimmerman, pubblicato da Blackie Edizioni e tradotto da Sabrina Bottari. Un testo ibrido, il cui titolo originale è Women and other monsters. Building a new mythology (Beacon Press, 2021), che l’autrice ha composto unendo diversi saggi scritti in precedenza, amalgamando abilmente critica storica, letteraria e politica, racconti mitologici e memoir.
Zimmerman non è estranea a tematiche socio-politiche e culturali, di cui scrive su giornali cartacei e online, riviste, blog e siti specializzati; in rete si trovano alcuni dei suoi scritti sui diritti delle donne, sul linguaggio del corpo, sulla misoginia, ma anche sulla politica americana (vive a Philadelphia, in Pennsylvania). Prima di Sirene e altri mostri è stata co-autrice, insieme a Jaya Saxena, di un ironico manuale di stregoneria moderna, Basic Witches (Quirk Books, 2017).
Con questo secondo lavoro ci consegna un’opera impregnata di storia personale e collettiva, quella storia greca delle origini del mito a cui spesso facciamo riferimento, a cui guardiamo con ammirazione, quella contemporanea in cui ci barcameniamo, e la sua personale, in cui ci si può ritrovare. Prima di immergersi nella lettura, ritrovandosi a cambiare idea su alcune cose che si davano per scontate e a modificare il proprio punto di vista, l’autrice ci tiene a una breve premessa: il termine donne (anche il Women del titolo originale) è utilizzato nel senso più ampio, includendo sia chi si identifica come donna (a prescindere da quale sesso le sia stato assegnato alla nascita) sia chi a un certo punto della propria vita è stato visto e trattato come una donna (prescindendo dal genere al quale appartiene). Si tratta di un libro scritto per “noi”, un pronome che può sembrare altisonante ma molto importante per Zimmerman in quanto «aiuta a riconoscere che, in un’accezione più ampia, un libro è un lavoro di gruppo» perché «non c’è scrittura senza un lettore, quindi voi e io siamo automaticamente un ‘noi’ – e a livello personale io ho sempre cercato di scrivere con il fine di capire meglio cosa significhi essere un umano in questa cultura e in questo periodo storico».
L’intera opera ruota intorno al significato del termine “mostri”, non si ragiona sul ruolo che questi ricoprivano nella società dell’antica Grecia, non essendo l’autrice una classicista, ma viene usata la loro immagine come modello di riferimento per discutere del ruolo culturale delle donne oggi. L’argomento a cui mira Zimmerman non è tanto cosa voglia dire sentirsi donna o conoscere sé stesse in quanto donne, ma affrontare i preconcetti, le aspettative e i limiti imposti alle donne dalla società contemporanea.
Negli ultimi anni c’è stata una riscoperta della mitologia greca, gli scaffali delle librerie si sono riempiti di saggi e romanzi che analizzano a fondo e in chiave moderna le vite degli dei e delle dee, dei mortali e dei semidei, facendoli conoscere da un’altra angolatura. L’ira di Atena. Le dee nel mito greco (Haynes N., Sonzogno, 2024), Olympos. Vizi, amori e avventure degli antichi dèi (Ieranò G., Feltrinelli, 2020), La canzone di Achille (Miller M., Feltrinelli, 2020), sono solo alcuni esempi di testi in cui i protagonisti ci appaiono per come sono: capricciosi, maliziosi, vendicativi, irascibili, impassibili. Non solo gli dei e le dee ma anche gli eroi sono leggermente diversi da come li abbiamo conosciuti nell’infanzia o ai tempi della scuola. Come la rappresentazione delle tragedie greche ha ancora così tanta presa oggi perché «l’unità di misura della tragedia è l’essere umano» (L’ira di Atena, p. 241), così anche queste riletture attecchiscono e, alle volte, diventano bestseller, perché hanno qualità metaforiche universali che si possono utilizzare per parlare di tutti gli aspetti della vita: amore, morte, bellezza e bruttezza, dolore, violenza, famiglia.
E le donne vengono riabilitate da quei ruoli marginali o accessori, che le vedevano solo in attesa o dedicate alla cura di sé e degli altri? Alcune sì, se non altro per mostrarci il loro punto di vista, come in L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre (Oliva M., Solferino, 2020) e ancor più in Circe (Miller M., Feltrinelli, 2021), un romanzo divenuto fenomeno internazionale che riscatta la maga, la “pharmakis”, da sempre denigrata e messa in disparte, liberandola dalle parole degli uomini e dandole una voce tutta sua.
Zimmerman propone una nuova prospettiva ancora, quella delle donne-mostro, considerate da tutti orride, raccapriccianti, fameliche, pericolose. La parola “mostro” viene dal latino “monstrum” che significa presagio o portento. L’autrice, mediante alcune delle caratteristiche che definiscono un mostro delineate dal docente Jeffrey Jerome Cohen, «Il mostro vive alle porte della differenza» e «Il mostro sorveglia i confini del possibile», ci introduce alla mostruosità: è relativa e nasce nel divario tra aspettative e realtà. Inoltre, «più un individuo è costretto, più è facile che devii dalla norma, e più si devia dalla norma più si sembra strampalati o addirittura pericolosi».
Gli eroi erano terrorizzati da Medusa, una delle Gorgoni, l’unica non immortale, famosa per avere un aspetto talmente grottesco che chiunque la guardasse negli occhi rimaneva pietrificato, letteralmente. Forse non tutti sanno, però, che Medusa un tempo era bellissima, con dei capelli meravigliosi e seducenti, talmente tanto da essere desiderata dal dio del mare, Poseidone. Come spesso accade nella mitologia greca, più di quanto ricordiamo, il dio aggredisce la ragazza e la violenta nel tempio di Atena; la dea della sapienza e allo stesso tempo una dea guerriera, non una grande amica delle donne, adirata per la profanazione dello spazio sacro, non punisce suo zio, come si potrebbe immaginare, perché gli dei difficilmente se la prendono con i loro simili, ma trasforma la chioma di Medusa in serpenti, cancellando in un istante la sua bellezza. Diventa una semidea, «una leggenda, un mostro e una madre di mostri. La bellezza non l’aveva protetta; era la bruttezza a essere diventata la sua armatura e la sua spada», finché non arriva un uomo, Perseo, a sconfiggerla con uno sforzo congiunto degli dèi della morte, del fuoco, del volo e della saggezza, «inganni, tempra, furtività e velocità, tutti insieme contro un’unica arma: la bruttezza». E, guarda caso, proprio Atena, prende la testa della Gorgone e la incastona nel suo scudo così da pietrificare in combattimento i propri nemici. Attraverso la sua storia e altri esempi più attuali, Zimmerman conduce il lettore a riflettere sui parametri e sui canoni di riferimento odierni della bellezza, sull’invisibilità femminile, sul concetto di bruttezza legato a quello di razza, classe sociale, disabilità e a qualsiasi altra cosa che devii da ciò che si definisce “mainstream” (menzionando anche le “Ugly Laws” – leggi sui brutti del XX secolo negli Stati Uniti).
Ogni capitolo è dedicato a un mostro e quindi a un argomento diverso che, in maniera stringente, riguarda tutte e tutti, una storia potrebbe non interessare chi la sta leggendo, facendolo sentire escluso, e in quella successiva, invece, ci si potrebbe riconoscere appieno.
Narrando le vicende di Scilla e Cariddi si affrontano le tematiche dei disturbi alimentari, del rapporto tra corpo e malattia, del digiuno e dell’automutilazione. Cariddi era una donna vorace punita da Zeus per aver rubato, e presumibilmente mangiato, i buoi di Eracle; viene relegata in mare dove mantiene la sua natura famelica ingoiando di tutto. Scilla era una ninfa molto bella e molto desiderata, anche dal dio marino Glauco, di cui era innamorata Circe. Quest’ultima, per invidia, trasforma la ninfa in una creatura mostruosa, con dodici gambe e sei teste, che mangia gli uomini, anche se in quantità ben definite.
«Se un uomo mangia tanto si dice che ha un sano appetito, ma se è una donna a essere affamata è solo vorace: la sua fame è sempre troppa, perché in teoria non dovrebbe neanche esistere. Se vuole del cibo, è un’ingorda. Se vuole del sesso, è una ragazza facile. Se vuole attenzioni dal punto di vista emotivo, è una stronza rompipalle – o ancora peggio, un’attention whore[1]».
Chi si è mai soffermato a pensare come si potessero sentire Scilla e Cariddi, una davanti all’altra a far tremare di paura chiunque attraversasse lo Stretto di Messina, mentre cercavano di accettare il loro corpo mutato, di affrontare le proprie punizioni, il proprio rancore e il proprio problema/malessere, che, alle volte oggi, viene superficialmente etichettato e interpretato come “una richiesta di attenzioni”? Non bisogna, tra l’altro, sottovalutare i due mostri, perché è vero che i migliori tra gli eroi, Odisseo, Enea, Giasone, sono riusciti a sfuggire loro, ma non li hanno mai sconfitti: «Questo in sé è qualcosa su cui riflettere: la voracità femminile è così spaventosa che può essere solo evitata, mai sconfitta».
In ogni storia, l’autrice sottolinea come lo sconfinare, l’essere arrabbiate, ambiziose, seduttrici o non abbastanza sexy, tratti che hanno sempre contraddistinto le donne come mostruose, pericolose, innaturali, siano in realtà i loro più grandi punti di forza. Non solo, invita anche a mettersi nei panni di questi undici mostri, a chiedersi come sarebbe andata la storia se l’avessero raccontata loro e non degli uomini; tutte le versioni di questi miti, infatti, o perlomeno le più note, sono stata tramandate da Omero, Ovidio, Esiodo, Virgilio, Sofocle.
Come pericolose seduttrici si incontrano le Sirene, esseri metà donna metà uccello, che intonano canti solitari in isole antiche vicino all’Italia e aspettano che passi qualche navigante per poterlo ammaliare con la promessa di “qualcosa” e, dopo che questi avrà ceduto alla tentazione, potersene nutrire. Il capitolo “Le ladre” è dedicato all’ambizione e alle Arpie, uccelli con il volto di donna, particolarmente ripugnanti e perfide:
«Dare a una donna dell’arpia è come farsi beffe della sua ambizione e rafforzare il concetto che non si merita niente, che tutto quello che si è guadagnata l’ha rubato dalla bocca degli uomini, ai quali apparteneva di diritto. Arpia è un termine che viene usato come arma soprattutto contro donne che cercano di avanzare in ambiti tipicamente maschili»
A tal proposito Zimmerman riporta alcuni esempi calzanti nello sport, in politica, in letteratura e nella scena musicale. Insieme alle Arpie ci sono le Furie, personificazioni della vendetta, guardiane e giudici delle anime ritenute troppo malvagie per il paradiso, hanno un compito ben preciso: punire chi ha spergiurato, chi ha commesso crimini in famiglia, chi ha tradito un giuramento e ha offeso gli dèi. La storia di queste «guerriere della giustizia sociale», fa conoscere l’insulto nato sul web “Social Justice Warrior” e approfondire le esperienze del #metoo, ma soprattutto scoperchia la minaccia e la pericolosità delle donne arrabbiate.
C’è una vicenda personale dell’autrice, in cui racconta di una relazione malsana e manipolatoria, che si interseca con la storia della Sfinge, rappresentata con il corpo di leone, la testa e il volto umani e un seno femminile. La sua è la storia di «una donna che pone domande a cui gli uomini non sanno rispondere. E gli uomini questa cosa non l’hanno mai presa bene, né nel V secolo a.C. né adesso». Non è solo questo che spaventa, è anche arrivata in Grecia dal lontano Egitto e quindi le questioni che destano preoccupazione sono due: l’intelligenza delle donne e gli stranieri, gli altri, i diversi.
L’intensità e la profondità degli argomenti non scemano andando avanti nella lettura, anzi, se possibile, si intensificano. Nel capitolo “Case profonde”, si incontra una creatura caratterizzata dalla complessità, la Chimera, un mostro a tre teste di diversi animali, serpente, leone e capra; il suo nome è diventato sinonimo di mescolanza. La complessità viene utilizzata da Zimmerman per parlare del matrimonio, del carico di lavoro emozionale e mentale che le donne si assumono o viene scaricato (perché da sempre funziona così) sulle loro spalle.
Non meno destabilizzante è il capitolo successivo su Lamia, ladra e assassina di bambini, spauracchio dei piccoli greci e delle loro madri, vittima anche lei di una dea, la gelosissima moglie di Zeus Era, che le aveva ucciso tutti i figli perché avuti proprio con il re degli dèi. Il dolore l’aveva trasformata in un mostro. I molteplici modi in cui una madre può essere mostruosa sono il tema principale del racconto ma anche
«la non-maternità, la maternità rimandata, la maternità precoce, la maternità invidiosa, la maternità a lungo sognata, la maternità di cui ci si pente, la maternità appaltata, la maternità clinicamente disastrosa, la maternità psicologicamente disastrosa, i disastri della maternità di ogni forma e colore».
Infine c’è l’Idra, un gigantesco serpente acquatico con nove teste, o più (a seconda delle versioni), mandata da Era a uccidere l’ennesimo figlio illegittimo di Zeus, Eracle, ma più l’eroe cerca di combatterla più lei diventa forte, non appena le recide una testa ne ricrescono due. Qui viene ripreso il discorso della violenza sessuale e delle molestie, e introdotto il concetto di “intersezionalità”. Oltretutto la metafora dell’Idra funge come appello alla collettività perché la sua vera forza non è il suo corpo condiviso ma la capacità di incassare un colpo e restituirlo due volte più forte: «collettivamente magari non saremo mai l’Idra, un singolo animale con multiple teste. Ma possiamo emulare l’Idra, o quel particolare tipo di eroismo mostruoso che deriva dall’essere letteralmente irriducibili. Riconoscere che le nostre vite sono ben lontane dall’essere identiche è parte del progetto; ci consente di farci avanti dove altre vengono mozzate, tramortite, o sono troppo deboli».
Nell’epilogo viene presentata la madre di tutti questi mostri, Echidna, donna fino alla vita, serpente sotto, che protegge i propri figli sapendo già che sono destinati a perire per mano di qualche eroe, o a vivere una vita da emarginati, che eroi loro non lo saranno mai e che non sempre si sentiranno potenti, nonostante il proprio potere.
Intensamente e con una leggera ironia che contraddistingue tutti i racconti, Zimmerman mostra come queste storie possano essere d’ispirazione, che l’abnegazione e la dignità, la forza d’animo, l’autodeterminazione, non sono solo qualità appannaggio esclusivo degli uomini. Esorta le donne a utilizzare la conoscenza, l’astuzia e l’intelligenza per sé e non per il bene di un uomo, come, invece, fece per vent’anni la triste e sofferente Penelope, ad esempio; a reclamare potere, autonomia del proprio corpo, soldi, riconoscimento; a non reprimere e soffocare le proprie contraddizioni, le proprie qualità, le proprie mostruosità:
«La loro eruzione può distruggerti. Ma non è la consapevolezza di essere una chimera a disorientarti, molte di noi sono nate così. Sono gli anni passati a cercare di semplificarsi, a cercare di presentare al mondo una facciata addomesticata e affidabile, di assumersi la responsabilità di portare la calma e il benessere in casa e mantenerli sempre a un livello alto. Se ti avessero sempre permesso di essere arrabbiata, triste, strana, contraddittoria – un leone, una capra e un serpente, veleno, latte e fuoco – immagina quanto saresti stata forte».
[1] Una donna che si «prostituirebbe», anche se non letteralmente, pur di ricevere attenzioni.