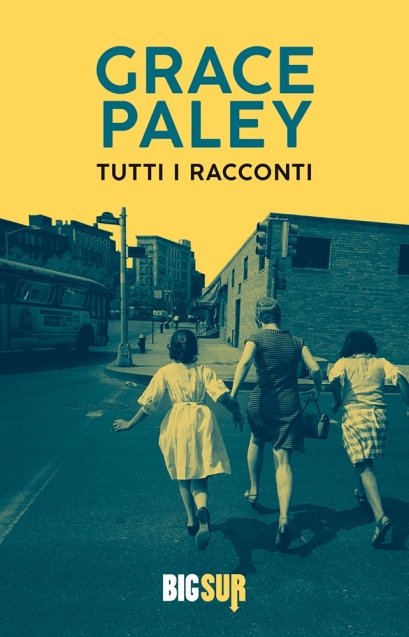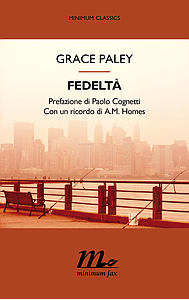di Fabrizia Gagliardi
Si fa un gran parlare dell’eredità letteraria di un autore, alla rabdomantica ricerca di tracce stilistiche che fanno ben sperare nella letteratura contemporanea o, al contrario, che demoliscono, copiano o dimenticano il passato nel modo spavaldo che il nuovo ha di imporsi sul vecchio.
Ma chi santifica il passato con sentite ricorrenze, anniversari di vecchie morti e profili sentimentali, deve avere lucidità e lungimiranza tali da non sbordare in un mito post-mortem. Mi riferisco al modo con cui alcuni interpreti, lettori appassionati esperti e non, amplificano una vita a predestinazione, il cui placido andamento è scandito dal ritmo di incombenze nel momento opportuno, come se non fosse il risultato della trama impazzita di una vita e dei tentativi di farcela, come qualunque essere umano.
Si tratta di un trappola critica che non ha coinvolto Grace Paley, probabilmente per la capacità della sua voce di rimanere illibata e singolare. Considerata una delle grandi scrittrici di racconti del secolo scorso è spesso affiancata a Raymond Carver, Lucia Berlin, più recentemente a Amy Hempel, in modo più lontano a Joy Williams, per la vena realista che attraversa i suoi racconti. Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta si ritrovò a domare un presente magmatico per creare un’àncora quotidiana senza mai intaccare l’ironia, senza mai tradire un anticonformismo radicato nel sangue, un ripudio dell’autorità prevaricatrice, e preservando i luoghi inviolabili, reali e sentimentali, della libertà.
Senza cadere nella trappola di critici fanatici è inevitabile riconoscere ora, in Grace Paley, un merito che, nel bene e nel male, ci fa dialogare con un passato che non avremmo mai voluto riconoscere ora, nel presente, oppure, in alternativa, che avremmo voluto leggere meglio.
Figlia di immigrati ucraini nasce a New York, vivrà la sua infanzia nel Bronx in un crogiolo di cultura tra immigrati dell’Europa dell’Est, afroamericani, italiani, portoricani, un coro di voci che sarebbe diventato protagonista delle sue storie e che spesso affiora nell’impegno politico e nella vita comunitaria caotica e intima, immersa in una città in continua evoluzione.
È proprio il senso di una collettività, mai indistinta, sempre emblematica nella sua diversità che fa emergere uno stile unico, in grado di cogliere indizi di vividezza lì dove l’opacità del quotidiano rende ciechi.
Sono soprattutto le donne a uscire dall’invisibilità, con alle spalle l’eco di un mondo di conflitti, tradimenti e prevaricazioni maschili, fino a diventare il soggetto prediletto visitato in tutte le fasi della vita. Piccoli contrattempi del vivere, raccolta di racconti del 1959, contenuta in Tutti i racconti (edito da Edizioni Sur con la traduzione di Isabella Zani), coglie le figure femminili nello sbocciare dell’esistenza. Che siano bambine già consapevoli di sentimenti amorosi profondi – come la ragazzina che s’innamora del marine in Una donna, giovane e vecchia – o madri, donne che si allontanano dalla giovinezza e dallo sbocciare del ventre per lavorare, crescere i figli, tutte si trovano al crocevia di ironia, dolore e determinazione che le allontana da figure maschili inconsistenti. Un minimo d’interesse, per esempio, è il racconto che si apre con un humor scettico e malinconico. In poche righe intuiamo la forza nascosta della protagonista:
Mio marito mi regalò una scopa per Natale. Non era giusto. Nessuno può convincermi che fosse un pensiero gentile. «Mi sto arruolando nell’esercito e non voglio che tu non abbia niente per Natale», disse. Gran bel regalo da dare a una donna che progettavi di non vedere più per un pezzo, con cui avevi dei figli e nel cui corpo entravi e uscivi quando ti pareva, ubriaco o sobrio, perfino prima di alzarti presto al mattino. Gli chiesi di aspettare una mezz’ora ad arruolarsi nell’esercito, così potevo fare la spesa.
Ci troviamo davanti personalità indomabili ma nessuna di queste reclama una vita fuori dall’ordinario. I personaggi sono colti nei momenti più banali dell’esistenza: fanno la spesa, accudiscono bambini, intrattengono discussioni irritate con i vicini, protestano e affrontano il poliziotto di quartiere. Per ritrarre sfaccettature così variopinte Grace Paley ha sfruttato il potere della forma breve e la capacità instancabile di saper osservare. «Abbiamo bisogno di immaginare la realtà. È su questo che crollano i nostri leader e noi stessi: dobbiamo riuscire a immaginare la vita di altre persone» dirà l’autrice in un discorso appassionato e non a caso la sua ricerca si concentra sull’incontro tra il verosimile e il reale. Grace Paley non aveva la pretesa di cambiare il mondo imponendo un moralismo tra le maglie della narrazione, ma credeva nel non dare per scontato il potere rivoluzionario di aprire gli occhi e rivolgerli al mondo. La cura di quello che si conosce è un concetto antitetico al desiderio di conoscenza stesso, di spingersi sempre oltre, di volere di più. La scrittrice indica continuamente la coscienza della cura ricordando che le cose che abbiamo accanto ogni giorno spariscono senza la capacità di stupirci, quando lo stupore dovrebbe essere una responsabilità.
Nei racconti delle raccolte successive come Enormi cambiamenti all’ultimo minuto e Quello stesso giorno virano gradualmente verso la riflessione della crescita, l’impegno politico, la responsabilità di ogni racconto e il susseguirsi della perdita.
Eppure è una lunga e incolmabile nostalgia di casa, questo sentire la mancanza di tempi giovanili. Mi sembrano un luogo mio da cui sono partita per sempre.
(tratto da Distanza)
Faceva bene a richiamare la mia attenzione sui suoi pericoli e sofferenze. Faceva bene a punzecchiare la mia natura responsabile. Ma anch’io avevo fatto bene a inventare per le mie amiche e i nostri figli un resoconto di queste morti private e della situazione dei nostri affetti più eterni.
(tratto da Amiche)
forse avevo la responsabilità di raccontare la storia nel modo più semplice, possibile, in modo, per così dire, da salvare qualche vita
(tratto da Debiti)
La scrittura funziona come una sfilza ininterrotta di fatti, intervallati da piccoli eventi fino a quando la disposizione della parole si trasforma in un suono singolare, un carattere, un significato affrontato nella musicalità contratta di una frase rivelatrice. L’essere tristemente umano avvolge i personaggi di un libero arbitrio che fa sparire una vera e propria struttura del racconto. La naturalezza del susseguirsi di tali epifanie quasi elimina l’autrice e la sensazione è di vivere in balia della convinzione che i luoghi comuni non possono esistere in un mondo così variegato.
«Tutti, veri o inventati, meritiamo una vita dal destino aperto» ammette la protagonista in Una conversazione con mio padre, una dichiarazione d’intenti, una teoria letteraria sostenuta dal paradosso di un personaggio di finzione. In effetti, nei racconti si respira una realtà mai avvertita prima, perché è difficile immaginare la fine di una sua storia, più semplice è pensare di intrecciarle tutte, su binari paralleli che seguono un corso mai predeterminato. Così come i finali aperti anche i protagonisti restano estranei, affascinanti nella loro complessità: possono essere irritati e felici allo stesso tempo, possono desiderare qualcosa che in futuro farà male, possono odiare e provare empatia.
Sullo sfondo New York rimpicciolisce, diventa i suoi quartieri, piccola e familiare. Qui Grace Paley distribuirà volantini agli angoli delle strade fino alla vecchiaia, di pari passo con un’esistenza che contemporaneamente prende vita su carta. Con la stessa disposizione d’animo con cui si lasciava trasportare dalle storie senza sapere dove portassero, così affronterà molti inizi e altrettanti adii. Faith Darwin, il suo alter-ego letterario, la seguirà per circa trent’anni, da quando perderà la madre molto presto a moglie che dovrà prendersi cura dei figli dopo essersi separata dal marito.
Attraversò gli anni Sessanta insegnando scrittura in college come la Columbia e la Syracuse University, a cinquant’anni si innamorò del poeta Robert Nichols e con lui conoscerà una realtà molto diversa da quella a cui era abituata: inizierà a frequentare la casa in campagna nel Vermont.
Spostarsi dalla velocità in continuo movimento della metropoli al tempo dei ritmi naturali non le fa pensare di colmare quel silenzio con parole o, come molti speravano, con un romanzo. La scrittura di Grace Paley si contrae ulteriormente tornando al suo primo amore: la poesia.
Le raccolte di Fedeltà (minimum fax, traduzione di Paolo Cognetti , Livia Brambilla, 2011) e Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta, da poco pubblicata da Edizioni Sur (con la traduzione di Paolo Cognetti e Isabella Zani), raccolgono componimenti di una consapevolezza nuova, uno sguardo dall’alto dell’esperienza sullo scorrere del tempo, la morte, la memoria, l’amore, l’amicizia e le visioni politiche.
Anche in pochi versi contratti permane uno sguardo narrativo, poche righe delineano una vicenda fulminea non lontana dalla percezione di un racconto compiuto, come leggiamo in È vero:
Tutti vogliono bene ai figli
anche il padre alla stazione ferroviaria
di Windsor Connecticut
che domattina starà sul giornale
nel rimorso alcolico di aver picchiato la sua bimba
fin sull’orlo rantolante della vita
in questo primo pomeriggio sta lì
con la figlioletta tra le braccia dicendole
tra i baci eccolo il treno che arriva
senti che fischio e ora guarda guarda
quella signora nel finestrino ha visto quanto sei
bella ci fa ciao con la mano
In Casa, qualche avvertenza, la cronaca cadenzata della manutenzione di una dimora nasconde il trascorrere di una vita intera con la cura degli affetti, lo sconvolgimento delle difficoltà, l’indifferenza della stanchezza. Le voci anonime di alcune storie in versi non sono poi così distanti dai protagonisti in prima persona che animavano i racconti. La poesia ha in fondo eliminato parti della narrazione che andavano in ogni caso non dette, come se rimozione di asperità avesse chiarito un’avvedutezza prima tagliente e ora più contemplativa.
In Come raccontare una storia (il mio metodo) (quasi sempre) la frustrazione di una poetessa si trasforma in una veloce lezione di scrittura che ci insegna per esempio come creare un personaggio, come indagare un’intimità straniera: «la narratrice aspetta/ la voce la gola/ è ancora chiusa aiuto/ aiuto griderebbe se potesse/ forse è terrorizzata da/ quelle arti l’invenzione e la/ memoria il calore della solitudine/ qual è la sua lingua? provare a/ radunare i bisbigli di sua madre? il modo che ha/ suo padre di innalzare una frase/ e poi tacitarla?»
Non è stanchezza quella che si avverte tra i versi che danno il titolo alla raccolta perché ne La sporadica alternativa della poetessa c’è la domanda senza risposta, il dubbio di ogni vita artistica di rimanere inascoltata: non era meglio fare una torta invece di «aspettare una settimana/ un anno una/ generazione perché si presenti/ il cliente giusto».
Ci sono molte domande nelle poesie di Grace Paley («esiste una letteratura che canti la scomparsa delle lingue madri?», «c’è differenza tra uomini e donne?», «non li hanno forse portati con e senza dignità i nostri padri e madri?») soprattutto in prospettiva di un mondo sconvolto da violenze. E se questa settimana, Volantino, Ora sono alcune poesie che travalicano i confini domestici e rivelano il potere di contenere complessità, piccole sfere di energia cinetica tenute nel palmo di chi è in grado di guardare oltre. Nell’impotenza di essere ascoltata da tutti Grace Paley ha infuso speranza in canti che oggi non sono mai stati così necessari.
E se questo secolo non finisse
e se i serbi insistessero nella loro stizzosa egoistica collera
e i kosovari nel loro disperato riarmo
e gli hutu nella loro vendicativa rabbia massacratrice
e i mullah afghani armati dagli americani nella loro
devota
esclusione della vita gioiosa delle donne
e i possidenti del mondo nel loro terrificante e infinito
ritorno a ciò che non è legittimamente loro
e i più scuri nel bruciare di sdegno e orgoglio
di popolo
e gli americani nel loro intenzionale impoverimento del
Vietnam in modo da vincere la guerra persa
e i russi insistessero nel duro lavoro di rinuncia all’antica
cattiveria solo per essere cattivi come gli altri
e gli irlandesi si scordassero sulle arpe della storia
e i somali facessero e sfacessero clan
e i turchi nei loro soliti attacchi ai curdi
e gli iracheni nei loro soliti attacchi ai curdi
E se la mia amica non smettesse di dire avessi sei figli
li darei tutti
e se io urlassi orrore
e lei mi spiegasse l’idealistica spinta a sacrificare i figli
E se i trentasei giusti che anno dopo anno riparano
il mondo si sentissero venir meno
e implorassero quell’Uno di aumentarli di numero
e se dal cielo creatore del tempo non venisse risposta
né suono né interesse non un rifiuto d’un tratto
assenza
e se sparissero i bambini maschi e femmine bianchi e neri
nessuna madre nessun figlio.
E SE (QUESTA SETTIMANA)