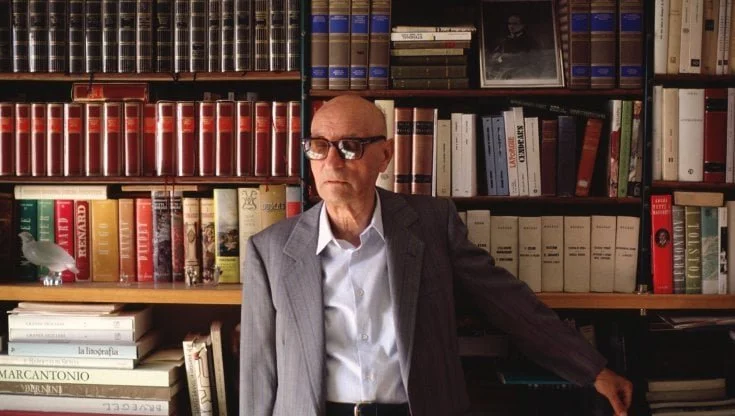di Roberto Galofaro
Dentro la raccolta di articoli Cere perse, e fin dal titolo, con la sua allusione al fuggevole passaggio della cera destinata a sciogliersi per lasciare posto nello stampo al ben più duraturo bronzo, si percepisce netto l’affascinante paradosso della scrittura barocca e senza tempo di Gesualdo Bufalino nel cimento con il fuggevole e il quotidiano. Qui sta buona parte della bellezza di questa antologia: nel corto circuito che si crea tra una lingua che aspira all’eterno e l’effimero dell’elzeviro.
Originariamente pubblicata da Sellerio, la raccolta è stata recentemente riportata in libreria da Bompiani, con una introduzione di Piero Melati. Tutti i pezzi erano stati pubblicati su giornali e riviste (il Giornale, L’Espresso, Tuttolibri, Corriere della Sera, Il Giornale di Sicilia) tra il 1982 e il 1985. Per collocarli rapidamente nella cronologia dell’autore, sono gli anni immediatamente successivi al clamoroso esordio con la Diceria dell’untore, uscito nel 1981 per Sellerio, dietro le insistenze dell’editrice Elvira e dell’amico Leonardo Sciascia, che lo avevano “scoperto” grazie a una forbita introduzione per libro di fotografie di fine Ottocento Comiso ieri. Dopo la consacrazione del Campiello, attingendo verosimilmente a carte accumulate nel tempo, nel 1982 Bufalino dà alle stampe anche la raccolta di poesie L’amaro miele, i bozzetti di paese di Museo d’ombre, un Dizionario dei personaggi di romanzo: basta questo a sottolineare la molteplicità di temi e di interessi che animavano lo scrittore di Comiso, una molteplicità che si ritrova anche in Cere perse.
Il sapore della prosa bufaliniana, qui come nelle sue opere narrative, è nel costante movimento tra il piano del minuscolo dettaglio e quello dell’astrazione filosofica, è dunque intimamente barocca, ancor prima che per le colte ricercatezze dello stile, perché gemmata sopra il sublime dell’infinitamente piccolo. Molte sono le recensioni, c’è molto Sciascia, c’è la Sicilia dei proverbi: si scopre che il barocco non è solo marmi e stucchi, vien da dire, ma carne e intelletto e commercio con gli esseri umani.
Come scopriamo, ad esempio, leggendo ne Il Monocolo e Santa Lucia, a proposito del “Monocolo di Racalmuto” (ovvero il pittore manierista Pietro d’Asaro) che: «fosse la prudenza o l’orgoglio a impedirglielo, [d’Asaro] non accolse molte altre delle provocazioni della lezione del suo modello [Caravaggio]: non lo spaccarsi dell’oscurità alle urgenze della morte; non l’impaginazione dell’evento secondo tagli di slogata terribilezza; non gli stravolgimenti della gerarchia dei valori, per cui sul telone del gran cinema caravaggesco cavalli e beccamorti invadono l’occhio, usurpando la scena all’eroe o eroina protagonisti». Dove non si può fare a meno di provare stupore di fronte a quella spiegazione della potenza caravaggesca con un temerario e inedito accostamento di parole («slogata terribilezza»), così inaspettatamente nitido!
E proseguendo oltre in questo bel saggio del corposo stile bufaliniano, ne vediamo le ragioni: «Pietro d’Asaro era un eccellente pittore, ma abitava in una provincia profonda, e aveva famiglia, e cercava di cavare dalla sua fatica il sereno della vita; e, a parte il congenito difetto di umori tragici e sublimi, non avrebbe mai rischiato di farsi rifiutare, come al Merisi tante volte era successo, un’opera che signori o prelati gli avessero commissionata».
Uno dei pilastri della poetica di Bufalino è proprio la provincia. Lui stesso non si mosse praticamente mai da Comiso, se non per la breve avventura militare in Friuli e lo sbandato rientro e il ricovero per tisi che ne seguì. E anche nel leggere i suoi articoli non si dimentica, anzi: Bufalino stesso non dimentica, la dimensione circoscritta del paese da cui scrive, il fatto che la sua voce e la sua lettura provengano da un ambito ristretto e laterale del mondo letterario e culturale. A volte questo è solo un espediente per amplificare l’importanza della memoria, di quella memoria che nelle periferie dell’impero tenta disperatamente di conservarsi e di sopravvivere all’egemonia del progresso omologante.
Ed eccoci al tema della memoria, una costante in tutte le opere di Bufalino: «Memini ergo sum, mi piace ripetere. Cioè io sono perché ricordo, io sono quel che ricordo. […] è nel passato che io mi certifico e mi battezzo, identità e memoria fanno tutt’uno». Così leggiamo in Lanterna cieca. Dalla memoria, intendo proprio dalla sua memoria individuale prima che da un orizzonte collettivo, provengono molti degli spunti degli elzeviri raccolti in Cere perse. Come quando Bufalino racconta della sua rilettura di Manzoni o della vicenda oscura di Paul Morphy giocatore di scacchi (gioco di cui Bufalino era stato campione in gioventù); o quando elenca i suoi «privati cult-movies» (era anche un cinefilo indefesso e conservava, così confessa, un’agenda in cui appuntava ogni pellicola vista dandole un voto); o quando ricostruisce la ragnatela tessuta da Proust nella Recherche (che lui lesse in sanatorio, pescando i tomi alla rinfusa, in ordine rocambolesco). Che da un ricordo o da una riflessione personale nasca un articolo è certamente nella natura dell’elzeviro stesso, ma Bufalino non risparmia di pronunciare la parola “io”.
Ma c’è un altro dato, connesso a questo, che emerge con forza e in più di un articolo. Ed è la particolare postura di Bufalino: non quella di un critico giudicante ma quella di un lettore interessato a valutare e rapinare. Il recensore-scrittore diventa (e si racconta come) una sorta di ricettatore, impegnato a mostrare i diamanti che ha ricavato dai testi.
In Ostaggio dello spavento, Bufalino lo dichiara esplicitamente: «io sono tutt’altro che un critico, sono un lettore dilettante e febbrile, ai miei autori impongo e pago pedaggi, dichiaro guerre amorose». Dove, al netto della dichiarazione di modestia, si riconosce l’intenzione genuina che muove la sua penna: non il rigore clinico di una ricostruzione critica ma un’esplorazione razionale del dominio sentimentale (laddove lingua o figura suscitano un sentimento).
Parlando del rapporto tra Gide e Dostoevskij (in Gide lettore di Dostoevskij) emerge un’altra spigolatura della sua intenzione di lettore: «[…] uno scrittore, nell’atto in cui legge, dichiara, più o meno, una guerra d’amore e di rapina al libro che sta leggendo, e non smette di chiedersi sottovoce quanto in esso c’è da sottrarre e da restituire, e se alla fine egli dovrà sentirsene creditore, debitore, usurpatore».
C’è in questa influenza dell’io una non piccola porzione dell’interesse che suscitano ancora queste note. Non sono mai terze, non sono mai redazionali e fredde. Sempre vi si coglie la prospettiva dello scrittore appassionato, coinvolto, tutt’altro che distaccato.