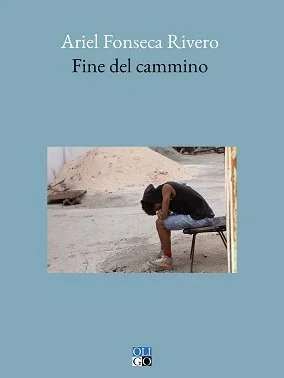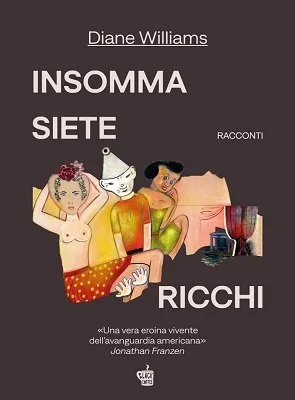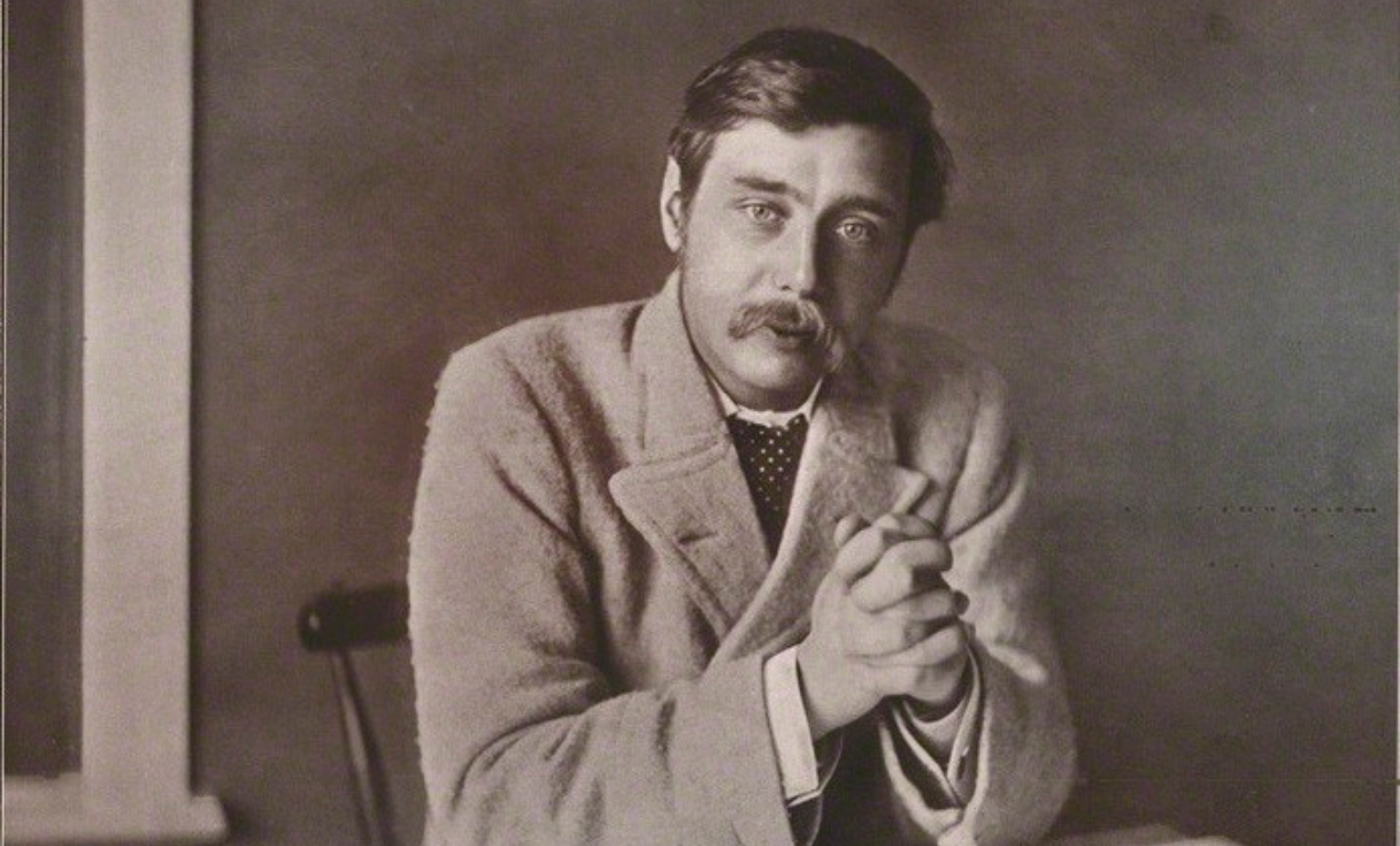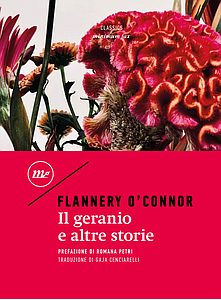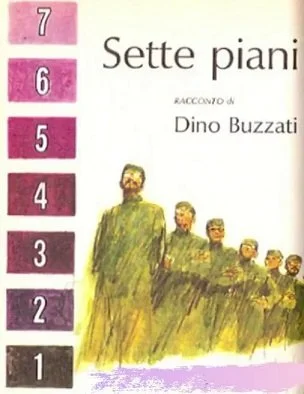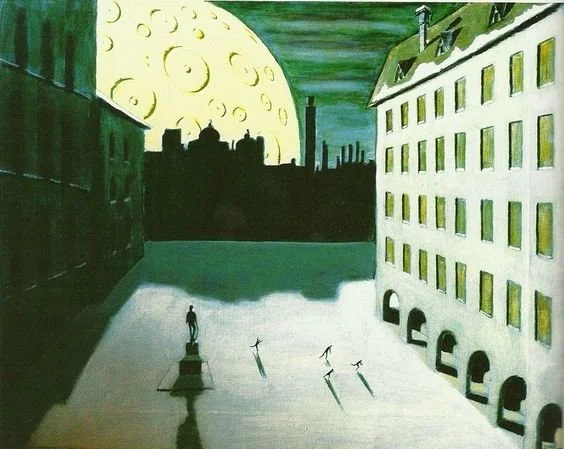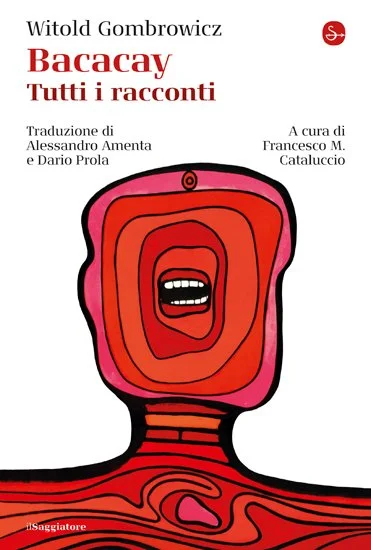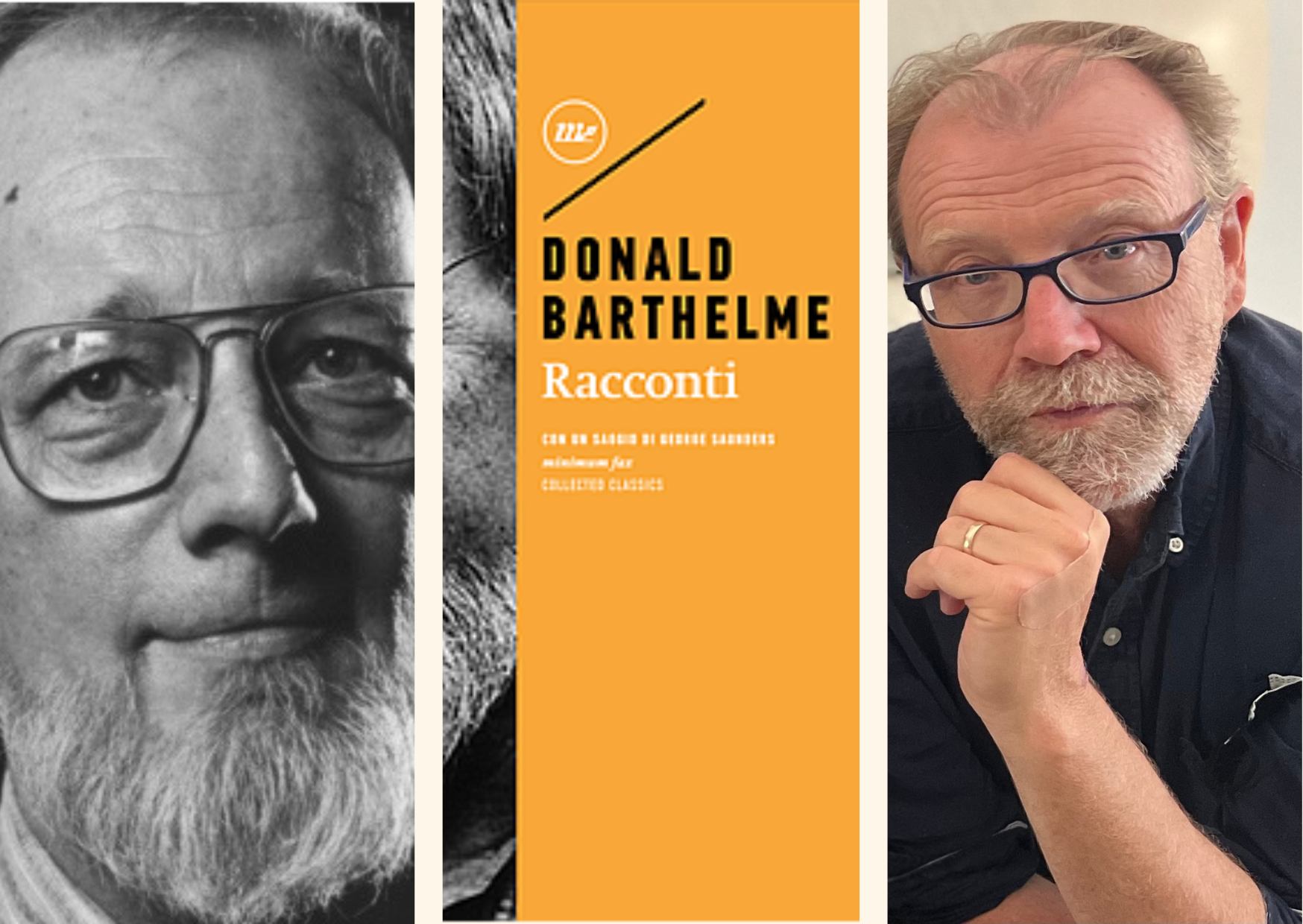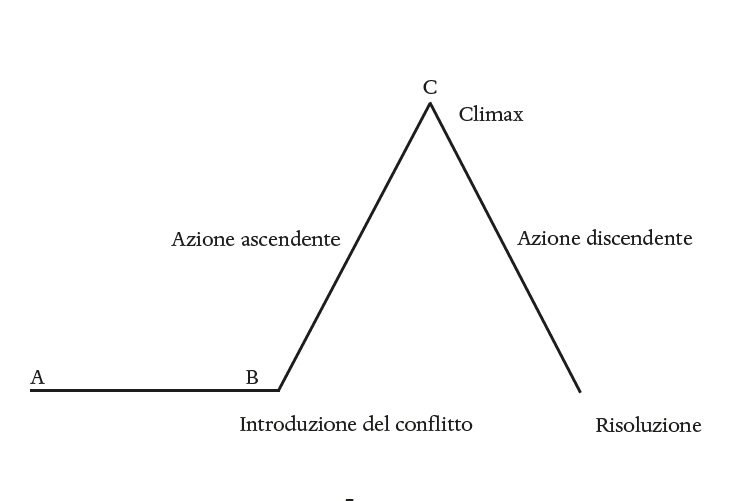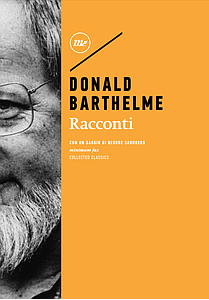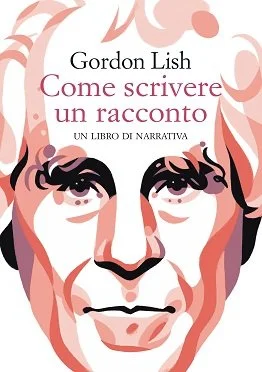Effequ ha dato vita a Elettra, una collana di narrativa breve che viene presentata dalla casa editrice così: una collana in cui le figlie raccontano i padri.
Per dare rilievo a questa operazione attenta alla forma breve ma anche al tipo di contenuto così importante di questi tempi, abbiamo deciso di presentarvi i titoli della collana proponendo i commenti delle autrici stesse con un piccolo estratto dei loro testi.
Prima, però, concediamo la parola alle curatrici e alle ideatrici di questo progetto.
Di seguito la seconda puntata con le autrici Alessandra Sarchi, Giusi Marchetta e Francesca Scotti.
La prima puntata, con Marta Zura-Puntaroni e Francesca Manfredi, la trovate qui.
Olga Campofreda, Eloisa Morra
Curatrici della serie Elettra
Perché Elettra? L’idea di una serie diffusa è nata da un nostro dialogo iniziato a distanza tre anni fa e risponde a una serie di letture, spunti e riflessioni comuni.
La necessità di riportare l’attenzione sul rapporto col paterno — in senso ampio, non a caso la radice linguistica è plurale: padre, padrone, padrino, santo padre, padre spirituale…— è nato sia riflettendo sugli effetti del #metoo, in cui le ragazze sembravano aver acquisito una nuova consapevolezza del loro ruolo di genere, sia dai tanti testi in cui da lettrici ci era capitato di imbatterci. Tra il 2017 e il 2021 sono stati parecchi i romanzi in cui autrici più o meno della nostra generazione iniziavano un’indagine sulla figura paterna, di solito misteriosa e imprendibile, o costruivano narrazioni in cui i padri apparivano solo in quanto portatori di potenzialità narrative inespresse. Un testo importante a livello teorico è stato Bella di papà di Katherine Angel (uscito in italiano per Blackie), che analizzava il mito di Elettra rovesciandone il punto di vista: non erano tanto le figlie a essere innamorate dei padri, quanto i padri contemporanei a sentirsi messi da parte, ‘innamorati delusi’ intimoriti dalla rinnovata indipendenza delle figlie.
Quale che sia il rapporto specifico, lo spieghiamo nella prefazione, “scrivere del proprio genitore è un’operazione ambigua: significa da un lato ritrovarlo, dall’altro individuare un nodo che spesso viene sciolto con dolore e consapevolezza”. Una doppia valenza che è ben riflessa nell’immagine di copertina ideata dall’illustratrice Carla Indipendente, un’Elettra che scioglie la treccia liberandosi e al contempo liberando i padri stessi dalle armature imposte dal patriarcato (immagine identica in tutti i racconti, declinata in sfumature diverse). I cinque racconti che compongono la serie di Elettra attraversano il mito, e finiscono per metterlo in discussione. Leggerli uno dopo l’altro spinge a confrontarsi con una costellazione di padri molto diversi tra loro (padri distanti e silenziosi, dominanti o timidi), e anche ad affrontare diversi modi attraverso cui i figli cercano di affrancarsi dal loro giudizio.
La nostra scelta per le voci che avrebbero dato forma a questo progetto è stata guidata prima di tutto dal desiderio di investigare non uno, ma una molteplicità di punti di vista sull’argomento. Abbiamo scelto scrittrici che appartenessero alla generazione successiva a quella delle lotte femministe degli anni Settanta, ma all’interno di questo gruppo ciascuna ha affrontato il tema centrale secondo la propria sensibilità, influenzata da esperienze di vita diverse e da diverse influenze culturali. Lavorare con loro a stretto contatto nella fase di editing e di ideazione dei racconti, ci ha anche rivelato quanto doloroso e complesso sia portare avanti un ragionamento sul patriarcato associando ad esso dei volti, che fossero questi di impronta autobiografica o meno. Con il primo volumetto firmato da Marta Zura-Puntaroni, L’olivastro, la riflessione sul padre rompe il primo sigillo sfociando nei toni della letteratura weird e uscendo dallo stereotipo che associa le donne/madri alla natura e gli uomini/padri alla razionalità. Ci è parsa questa una dichiarazione importante con cui cominciare: volevamo fosse chiaro che le nostre Elettre, più che combattere i padri, avrebbero continuato ad amarli liberandoli dagli stereotipi di genere. Con Bestiario parentale di Francesca Manfredi siamo entrate nel territorio del personal essay, con l’autrice che riflette sul ruolo del padre-amico e della sua posizione in una famiglia di stampo fortemente matriarcale; con Scintille di Francesca Scotti, un esempio di realismo magico, la presenza dei padri si fa quasi fantasmatica, ma torna come un’ombra attraverso e gesti e le parole dei ragazzini; il quarto episodio, Quella è la porta di Giusi Marchetta, offre l’affresco realistico di una famiglia con tre sorelle, tutte legate al padre da un rapporto diverso, mentre questo vede evolvere la propria identità attraverso grandi eventi della vita, come la malattia della moglie e l’esperienza di essere nonno. Il racconto conclusivo, Ragazza senza nome di Alessandra Sarchi, con i toni della parabola filosofica ci porta addirittura riflettere su come un paterno ‘sufficientemente buono’ debba non per forza essere cercato in un padre biologico, aprendo a nuove forme di possibilità. Visti i diversi punti di vista espressi dai racconti, volti a comporre un ritratto multiforme del volto del paterno, non ci ha sorpreso vedere i librini passare di mano in mano, amati da lettori di età e gusti molto diversi tra loro.
L’esperienza Elettra è stata per noi gioiosa e dolorosa insieme. Gioiosa perché ci ha permesso di lavorare con storie e voci straordinarie, dolorosa perché questo lavoro ha fatto vibrare corde molto profonde del vissuto di ciascuna. Liberare i padri ha significato anche liberare noi stesse da demoni personali e politici. Allo stesso modo, leggere le cinque Elettre, una dopo l’altra, è un percorso che non lascerà inalterati gli animi e le coscienze di coloro che decideranno di addentrarsi in queste storie.
Alessandra Sarchi
Ragazza senza nome
Ragazza senza nome nasce da un ripensamento del personaggio di Elettra come figura della ribellione. L’Elettra antica si si rivolta infatti tanto quanto il padre quanto contro la madre. È l’istituzione familiare stessa a venire messa in discussione. La protagonista del mio racconto ha in apparenza come avversario alla propria crescita e all’acquisizione della propria identità un padre castrante e anaffettivo, ma in realtà anche la madre è un’alleata del padre nel conservare un ordine che garantisce solo a quest’ultimo autorevolezza e possibilità di decisione. La mia protagonista vuole sovvertire quest’ordine, ma non ne ha gli strumenti e per tutta l’adolescenza interiorizza rabbia e impotenza. Solo l’incontro con un’altra donna più grande che le farà da guida professionale consentirà alla ragazza senza nome di liberarsi dalla rabbia e trovare uno spazio di affermazione positiva. Volutamente l’ho lasciata senza nome, perché la sua vicenda è abbastanza paradigmatica di quello che può accadere a qualunque ragazza all’interno di un sistema familiare imbevuto di valori patriarcali.
La messa in discussione della figura del padre da parte della ragazza senza nome è radicale in quanto non si limita solo al proprio genitore, ma critica il principio stesso delle religioni monoteiste che identificano la divinità con un principio maschile. La ragazza senza nome contesta Dio padre, quanto contesta il proprio dispotico padre.
Su quella Ragazza non avrei scommesso nemmeno mille delle vecchie lire – buone appena per comprarci un gelato, ma piccolo, a metà degli anni Ottanta – perché si vedeva da lontano che era rovinata, nel senso che le mancava qualcosa, ma terribilmente, o qualcosa le era stato tolto e chissà se mai ce l’avrebbe fatta a riempire quel vuoto. Precipitata come molte delle sue coetanee nell’equivoco che le femmine potessero fare quello che volevano e potessero divertirsi in una grande festa danzante che iniziava dai poster dei cantanti appesi in camera e proseguiva nelle sale di ricreazioni dei circoli Arci, dei circoli parrocchiali, delle discoteche autorizzate e di quelle abusive, dei primi rave e delle spiagge, sempre fischiettando lo stesso motivetto che si avvolgeva su sé stesso – Girls just wanna have fun – la Ragazza si era accorta di divenire tale, cioè un essere con desideri che uscivano dal perimetro del giardino di casa e fastidi che coinvolgevano in maniera incresciosa il suo corpo – tette, mestruazioni, una irrazionale e costante fame – quando il Padre le aveva impedito di andare alla sala giochi appena aperta nel cuore di un paese di ottomila anime della bassa padana.
Giusi Marchetta
Quella è la porta
L’idea è nata dalla voglia di raccontare una dinamica familiare che si manifesta tutta in una sola giornata, in una data importante. Natale è passato da qualche giorno e tre sorelle tornano a casa del padre (o almeno dovrebbero perché la più piccola pare non avere intenzione di farsi viva) per onorare un impegno. In realtà inseguono tutte l’approvazione paterna: Vera, la più grande, cerca di guadagnarsela conducendo una vita inappuntabile anche se questo le costa una grande fatica e la continua rinuncia ad ascoltare la propria voce; (Com’è buona, dicevano le maestre. Non sapevano che in casa c’era una corda sospesa su cui camminare, Vera per prima, io dietro, con le mani appoggiate sulle sue spalle). Aver dato la luce al piccolo di casa sembra aver completato l’impresa con l’unico svantaggio di essere vista dal padre solo in quanto madre del nipote. La sorella più piccola, Iole, gioca da tempo a nascondersi e ad allontanarsi, in attesa se decidere di tagliare tutti i ponti con chi ha sempre dichiarato che se le regole di casa non vengono seguite, “quella è la porta”. Inadatta a seguire leggi che impongono anche chi amare, lei che è sempre stata la preferita di lui è forse pronta a disobbedire e ad essere tagliata fuori per sempre dalla famiglia. (Iole mi ha lasciato la mano e ha cominciato a fissarlo cercando nel suo viso il segno di una crepa, qualcosa in grado di cedere con gli anni o con l’amore. Adesso so che non l’ha trovata).
Sarebbe tutto abbastanza in linea con il lento disgregarsi di una famiglia contemporanea se non fosse per Gaia, protagonista e voce narrante, che per motivi personali e che nulla hanno a che vedere con l’amore filiale, ha bisogno che prima della fine dell’anno i rapporti col padre e le sorelle trovino una felice forma di convivenza. La posta in gioco non è più l’approvazione e paterna ma la sua stessa sopravvivenza.
Mi sorprendo, nel rileggere il racconto, di quanto al centro di questa storia ci sia solo in apparenza un padre desideroso di un maschio e incastrato con tre figlie femmine che non capisce e non vuole capire, un terno al lotto che ha trovato nel nipotino l’unico, tardo, rimedio. Il senso forse di raccontare questa storia è nella casa e in chi la abitava prima, la madre che col suo amore ha costruito questa prigione familiare, l’ha resa accogliente in attesa di un futuro migliore. (La verità è che c’è qualcosa in questa stanza, in tutte le stanze di questa casa e che quello che c’è non riesce ad andare oltre la porta. Qui pregavamo insieme per un fratellino prima che nascesse Iole, qui dormivamo le notti che papà era al lavoro; qui guardavamo la tv io e lei mentre Vera dormiva e Iole borbottava nella culla. Sotto queste coperte, mi ascoltava, poi mi prendeva la mano e rispondeva: quando voi ve ne andate, me ne vengo anch’io”). Le gabbie sono sempre terribili anche quelle costruite con amore.
Ma se Elettra avesse amato la madre quanto il padre, forse, le sarebbe stato più facile trovare una via d’uscita e un modo per essere felice.
Quando sono nata io, l’obbiettivo in famiglia era avere un maschio per equilibrare le cose. Avere un fratello per Vera, un erede per il cognome, un figlio per far pensare a mio padre che tutto sommato qualcosa era andato per il verso giusto. Vera e la mamma pregavano tutte le sere per un ‘bimbo sano’ e la vecchia stanza della nonna venne svuotata in fretta per fare spazio a un armadio, a un fasciatoio e a una culla che doveva sostituire la carrozzina rosa in cui mia sorella aveva dormito per quasi un anno prima di passare al lettino.
Francesca Scotti
Scintille
Gennaio è arrivato di domenica, con il cielo limpido e un’aria poco invernale. Lea, Rebecca e Giulia sono sulla spiaggia, mani nelle tasche, occhi all’orizzonte. La pelle liscia della fronte è appena increspata dal cruccio della luce. Con loro ci sono anche Bebè, la sorellina di Giulia, e Stefano. Lui però non ha le mani nelle tasche perché l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale si è rotto un braccio. È caduto dal faggio del giardino dove si era arrampicato durante l’intervallo, e il tappeto di foglie secche ormai scure di terra non è bastato ad attutire l’impatto.