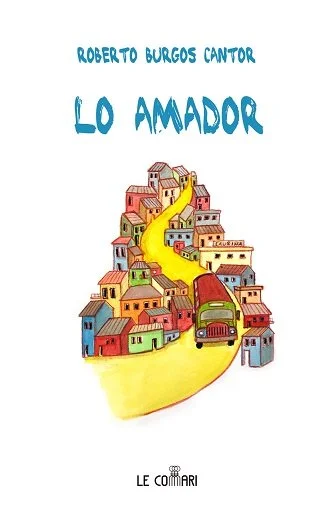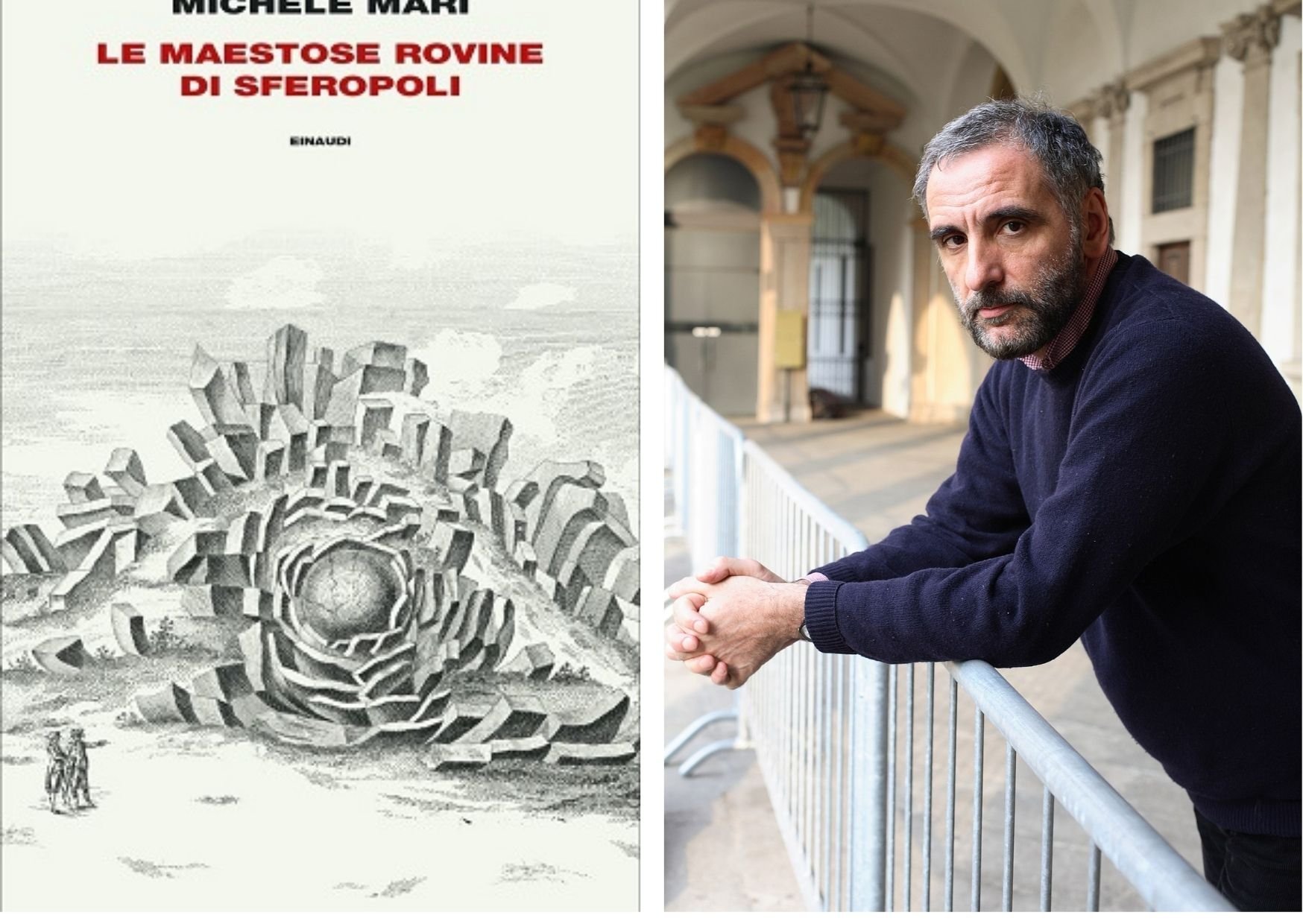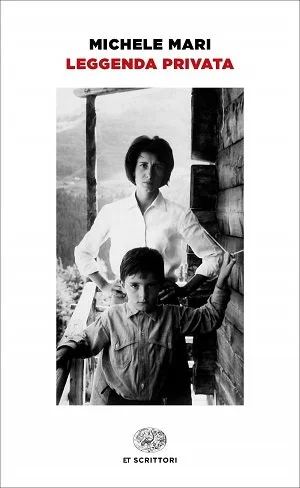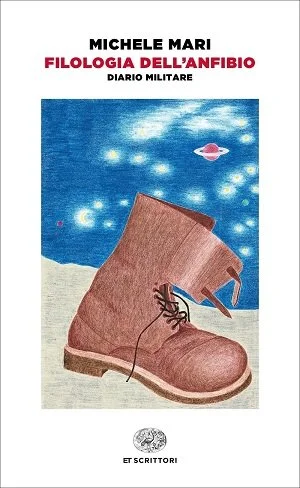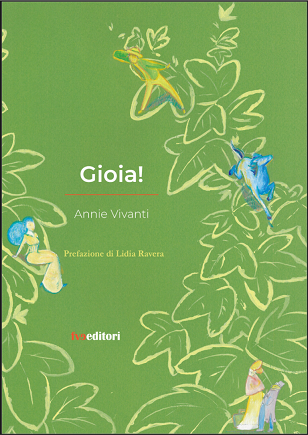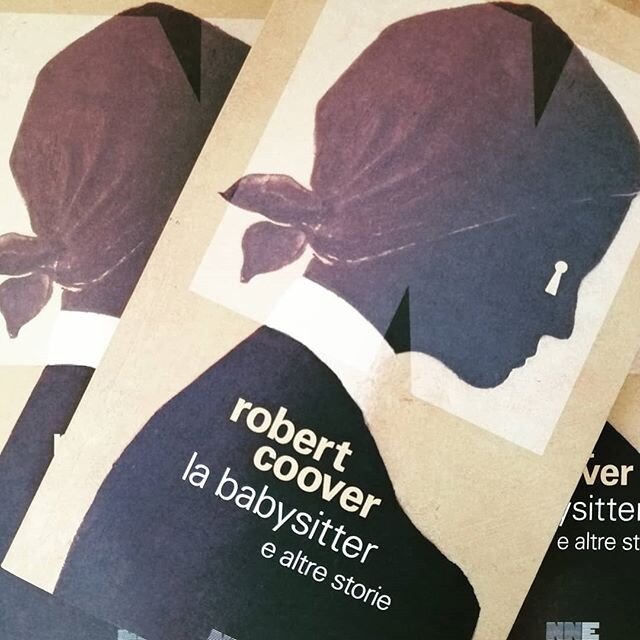Corrimano porta in libreria tre magistrali racconti di Henry James, raccolti in Vite private, con la postfazione di Fabrizio Coscia, che Cattedrale vi propone per gentile concessione dell’editore.
Cronaca del fuggiasco Henry James
di Fabrizio Coscia
Ogni volta che ci si accinge a scrivere su Henry James si ha la frustrante impressione, come disse Ezra Pound, di stilare “un Baedeker per un continente”. Da dove cominciare, allora? Comincerei dalla banale constatazione che nessuno studio, nessun saggio sul grande scrittore americano potrà mai dirsi esaustivo, né tantomeno conclusivo. Al limite, si può concepire una parziale proposta di lettura, una tra le tante possibili, nell’auspicio che abbia bastante forza sineddotica da dirci qualcosa di illuminante sull’opera in generale di James. Proprio i tre racconti qui riuniti appaiono idonei a un tentativo del genere, in quanto dalla loro posizione piuttosto marginale (non sono, infatti, tra i più celebri e celebrati) riescono a descrivere con una certa icasticità il momento in cui, nel passaggio di secolo, la scrittura di James assume forme e intenzioni nuove, segnando un congedo definitivo dall’età del realismo. Tutto ciò che appare evidente nei quattro grandi romanzi sperimentali – Le spoglie di Poynton (1897), Ciò che sapeva Maisie (1897), L’età ingrata (1899) e La fonte sacra (1901) –, quelli cioè che inaugurano la “stagione della crisi” nella letteratura e nella cultura del primo Novecento, insieme a una manciata di magistrali racconti, come L’altare dei morti (1895), La cifra nel tappeto (1896), Il giro di vite (1898), La belva nella giungla (1903), La panchina della desolazione (1909-10), ci viene infatti suggerito e confermato in filigrana nei tre titoli proposti – Brooksmith (1891-92), La vita privata (1892-93) e, inedito in Italia, Il castello di Fordham (1904) – in tono minore, per così dire, e tuttavia particolarmente efficace e pregnante. Di che costa sto parlando? Del fatto che nell’arco di un ventennio, quasi in preda a una sorta di furore creativo, James ha portato la letteratura nel “cuore di tenebra” della contemporaneità, compiendo un radicale processo di ripensamento sullo statuto stesso della “realtà” e della sua percezione, che ne ha svelato la fallacia, l’illusione, l’inafferrabilità. E da dove origina questa evoluzione, o meglio questa faglia, questa frattura, questa crisi della rappresentazione?
Per rispondere a una tale domanda ci può tornare utile riprendere l’abbozzo di un saggio giovanile di Marcel Proust, intitolato La poesia o le leggi misteriose, scritto durante la composizione del Jean Santeuil, tra il 1895 e il 1901, più o meno dunque negli stessi anni in cui James realizzava la sua rivoluzione letteraria. Lo scrittore francese vi analizza la scissione perenne del poeta in due personalità contrastanti, facendo un paragone con lo sdoppiamento tra il dottor Jekyll e Mr Hyde, della celebre novella di Stevenson: a sorprenderlo nella sua stanza, il poeta ha l’aria smarrita, spiega Proust, “in preda a un’inaudita agitazione”, come se avesse appena commesso un delitto e fosse stato scoperto, ma non c’è più nessuna traccia della vittima, quasi scomparisse appena si entra, “come quando si cercava di scoprire che cosa Hyde facesse a Jekyll: quando si vedeva Jekyll, non c’era più nessuna traccia di Hyde, e quando si vedeva Hyde, nessuna traccia di Jekyll”. Il poeta, conclude lo scrittore, “lo trovate sempre solo”. A che cosa voleva alludere Proust con questa immagine del double, se non al fatto che il poeta vive sempre diviso tra un suo côté sociale, mondano, pubblico insomma (il dottor Jekyll), e un altro invece privato, solitario, alieno da tutto e da tutti, nel quale è dedito in modo quasi criminoso alla sua opera, “chiuso nella sua camera”? Il poeta, lo scrittore in generale, ha bisogno cioè di rinchiudersi nel suo mondo personale, per dare vita all’opera e annullarsi come uomo.
Anche nel racconto La vita privata di James c’è una “stanza del delitto”, una camera in cui uno scrittore – l’affermato Clare Vawdrey – si trasforma in una sorta di Mr Hyde, ma non facendo sparire le tracce del dottor Jekyll, piuttosto mandandolo in giro, negli spazi sociali di una pensione svizzera sulle Alpi, o nei suoi dintorni, a intrattenere fatui rapporti con gli ospiti, come una sua proiezione, un suo fantasma, mentre lui scrive da solo, all’insaputa di tutti. Uno sdoppiamento, dunque, che mantiene in vita entrambe le istanze, quella mondana e quella creativa, ma delegando a quest’ultima il ruolo essenziale e riducendo la prima a un vuoto simulacro. Tra gli ospiti della pensione è lui la celebrità, l’attrattiva principale, ma la sua conversazione ha qualcosa di scialbo, che delude le aspettative di chi ammira il suo genio. Al contrario, Lord Mellifont, un altro ospite della pensione, anima le serate mondane dei gitanti con il suo brio, il suo stile da perfetto uomo di mondo, che sa adattarsi anche alle situazioni più complicate. “Rivestiva sempre il ruolo di anfitrione, era il mecenate, il moderatore d’ogni riunione”. Ma dietro entrambi si nasconde un enigma che il narratore – un giovane scrittore che viene definito “un rubacuori”, “un osservatore”, aiutato dalla affascinante attrice Blanche Adney – cerca di svelare. Una sera, infatti, dopo aver lasciato l’attrice a conversare con Vawdrey, il narratore si reca di nascosto nella stanza dello scrittore per recuperare un manoscritto dimenticato, ma quando apre la porta senza bussare scorge inaspettatamente una figura seduta al tavolo vicino a una delle finestre, intenta a scrivere al buio. Il narratore scopre cioè – in un vero e proprio colpo di scena di grande effetto – che Vawdrey, mentre è impegnato a chiacchierare del più e del meno di sotto con gli ospiti della pensione, contemporaneamente è impegnato anche a scrivere nella sua stanza. “Quando uno esce, l’altro rimane a casa” spiega il narratore a Blanche, subito dopo, svelandole la sua scoperta. “Uno è il genio, l’altro è il borghese; e il borghese è il solo che noi conosciamo personalmente. Parla, si mette in mostra, è molto popolare, flirta con voi…”. Questa scoperta fantastica – che apparenta di fatto il racconto al genere delle ghost stories, il cui massimo capolavoro jamesiano è Il giro di vite (1898) – fa il paio con quella in cui si è imbattuta, altrettanto casualmente, la stessa Blanche, e che riguarda Lord Mellifont: l’uomo, per quanto assurdo possa sembrare, vive solo quando è in compagnia degli altri; è una maschera che ricopre un volto disabitato. Per scoprire questa terribile verità – la verità, cioè, di una identità che vive in una dimensione esclusivamente pubblica e che nel privato si dissolve – basta sorprenderlo da solo e verificare che egli, da solo, non esiste. Ci troviamo di fronte, evidentemente, a un paradosso, che coglie però un nodo concettuale essenziale per comprendere la poetica di James, ma anche la sua evoluzione in questi anni di transizione. Lo sdoppiamento di Vawdrey rimanda allo sdoppiamento di cui scriveva Proust nel suo saggio giovanile. Ma non solo. Qualche anno dopo, all’inizio del 1914, Franz Kafka in una lettera alla fidanzata Felice Bauer, quasi a volerla spaventare, o quantomeno scoraggiare da ogni progetto di vita matrimoniale e borghese, evoca un’analoga “stanza” dello scrittore, spiegando che “quando si scrive non si può mai essere abbastanza soli” e bisognosi di silenzio interiore: “Ho già pensato più volte” scrive Kafka “che il mio migliore tenore di vita sarebbe quello di stare con l’occorrente per scrivere e una lampada nel locale più interno di una cantina vasta e chiusa. Mi si porterebbe il cibo, lo si poserebbe sempre lontano dal mio locale, dietro alla più lontana porta della cantina. La strada per andare a prendere il pasto, in veste da camera, passando sotto le volte della cantina, sarebbe la mia unica passeggiata. Poi ritornerei alla mia scrivania, mangerei lento e misurato e riprenderei subito a scrivere. Chissà quali cose scriverei! Da quali profondità le farei sorgere!”. Anche il “tenore di vita” immaginato da Kafka per sé stesso ha qualcosa di criminoso: la stanza in un “locale più interno di una cantina vasta e chiusa”, la sua separatezza e segretezza, il rifiuto di ogni contatto umano (“Mi si porterebbe il cibo, lo si poserebbe sempre lontano dal mio locale, dietro alla più lontana porta della cantina”), tutto sembra alludere a qualche atto da tenere nascosto, a qualche oscura metamorfosi. Insomma, la scrittura è qualcosa che può ottenersi soltanto nella più assoluta solitudine, nella rinuncia ascetica al consorzio umano, nel silenzio e nel vuoto: al polo opposto, c’è la vita, che si esprime, nel caso di Proust, nella mondanità, nei rapporti sociali, e nel caso di Kafka, nel matrimonio e nella vita familiare e borghese (su questo stesso tema del conflitto tra arte e vita borghese anche Thomas Mann, tra gli scrittori più amati e ammirati da Kafka, aveva composto la novella Tonio Kröger, nel 1903). Ma perché lo scrittore, per ritrarre la vita attraverso la letteratura, ha bisogno di allontanarsi dalla vita stessa, di commettere il crimine di negarla in sé, per restituirla nella pagina scritta? E, soprattutto, è davvero certo che questo “crimine” conduca all’obiettivo prefissato? Proust, da quell’ultimo grande scrittore dell’Ottocento che è stato, in fondo, non ha mai avuto dubbi sulla forza della letteratura, sul suo potere rivelatorio, sulla sua capacità di rappresentare “la vita vera, la vita finalmente riscoperta e illuminata, la sola vita, dunque, pienamente vissuta”. Lui è come il monaco che deve ritirarsi dal mondo per poter riflettere su di esso. La camera foderata di sughero del suo appartamento di boulevard Haussmann è la “stanza del delitto” dove si compie quella straordinaria alchimia che sola può salvare l’uomo dall’insensatezza del vivere. Con Kafka, invece, questa fiducia è svanita, caduta sotto i colpi del dubbio, dell’inadeguatezza, della crisi. Con Kafka “la menzogna viene elevata a ordine del mondo” e la letteratura non può che validare questo ordine. Come un rabbino senza Dio, Kafka crea il suo Talmud letterario su una Torah inesistente, o smarrita per sempre. L’ambizione ottocentesca di dominare il reale attraverso la scrittura lascia il posto a un’ammissione di impotenza: la realtà si offre ormai come un rebus, o un puzzle da combinare tassello per tassello, senza però mai poter pervenire alla sua conclusione, poiché ci sarà sempre qualche tessera mancante. La realtà è un enigma su cui ci si interroga invano, un vuoto sul quale ci sporgiamo attratti e spaventati a un tempo. Quel crimine nella stanza solitaria, allora, è stato commesso invano, o al limite solo per demistificare, rinnegare o sconfessare l’illusione di mettere ordine nel caos della vita astraendosene. Rispetto a tutto ciò, dove si situa James con il suo allegorico e paradossale racconto di fantasmi che si aggirano in una mondana pensione alpina? Se il racconto si fosse limitato a rappresentarci lo sdoppiamento dello scrittore non sarebbe difficile apparentarlo alla poetica proustiana. Chiunque scriva sa che la propria vita più autentica coincide con l’atto della scrittura. Del resto, lo stesso James sembra confermarlo quando annota nella Prefazione a Le spoglie di Poynton: “Poiché la vita è tutta inclusione e confusione, e l’arte tutta discriminazione e scelta, quest’ultima, in cerca del duro valore latente di cui solo si preoccupa, ringhia attorno alla massa tanto indistintamente e infallibilmente quanto un cane sospettoso d’un qualche osso sepolto”. Con la differenza che mentre “il cane cerca il suo osso solo per distruggerlo”, l’artista trova “nella sua piccola pepita, lavata dalle incrostazioni e martellata in sacra durezza, la materia stessa per una chiara affermazione, l’occasione più felice per l’indistruttibile”. È uno sforzo di indagine che ha come oggetto la vita stessa e che è concentrato solo sulla ricerca del “duro valore latente” della nostra esistenza. E tuttavia, la presenza dell’altro fantasma, quello di Lord Mellifont, ne La vita privata ci spinge a un’ulteriore riflessione. È lui, infatti, che rappresenta la cifra “inclusiva” della vita, la teatralizzazione della realtà. Lui è l’attore sul palcoscenico che vive solo nello sguardo del pubblico, ma dietro questa apparenza di stile, di charme, di armonia, si nasconde il vuoto. E che cos’è questo vuoto se non la verità che si rivela sotto la pressione euristica della scrittura? In altre parole, con La vita privata James instilla un dubbio allo stesso tempo estetico ed esistenziale, di forma e di contenuto: da un lato c’è lo scrittore che rinuncia a vivere (o meglio che demanda a un doppio, a un falso sé la dissipazione mondana) per carpire nella solitudine e nel buio della sua stanza l’essenza della vita stessa (“Noi lavoriamo nelle tenebre” scrive James in un altro racconto, Gli anni di mezzo); dall’altro c’è la scoperta – attivata dallo stesso meccanismo indagativo del racconto, e che ci porta oltre le soglie del Novecento (nei paraggi dei terrori kafkiani) – che quell’essenza coincide con l’Assenza. Ma la mondanità che James mette in scena ne La vita privata, e che lo scrittore stesso, proprio come Proust, ha vissuto senza risparmiarsi, può davvero rivelare nell’opera letteraria il “duro valore latente”? O non è piuttosto vero il contrario, che cioè la scrittura, più che mettere ordine nella confusione di quel “mondo stupido e volgare”, non può fare a meno di decifrarne il vuoto, la mancanza di significato; non può fare a meno, cioè, di scoprire che il vero enigma è l’assenza di qualsiasi enigma, proprio come capiterà al narratore del romanzo La fonte sacra, che trascorre un fine settimana in una casa di campagna osservando, e cercando invano di capire, le misteriose dinamiche che legano due coppie; o a John Marcer, l’uomo che, ne La belva nella giungla, si ritiene destinato a qualcosa di eccezionale e trascorre tutta la sua vita in attesa del suo accadimento, salvo scoprire che la sorte riservatagli era proprio quella di mancare al suo destino (una parabola sorprendentemente simile, mi pare, al racconto di Kafka Davanti alla legge).
Che questa assenza, questa mancanza di significato possa essere il risultato di una colossale rimozione (la rimozione di una omosessualità che James non ha mai espresso direttamente nella sua opera e nella sua vita) può interessare più i biografi e gli psicoanalisti che la critica letteraria. Quello che conta, credo, è la conseguenza estetica e concettuale di questa rimozione, quella che potremmo definire a tutti gli effetti una “poetica dell’omissione”. Da un lato la reticenza, appunto, l’ellissi nel discorso retorico, di cui James è maestro riconosciuto, e il meccanismo del racconto che gira attorno al non detto; dall’altro la ricerca del significato destinata a essere frustrata (come nel racconto Il carteggio Aspern, del 1888, vero momento di svolta nella produzione jamesiana). Ritroveremo, del resto, questa stessa poetica dell’omissione legata all’omosessualità anche nelle opere della scrittrice americana Willa Cather, la quale nel saggio Il romanzo démeublé, del 1922, parlando del capolavoro di Hawthorne La lettera scarlatta, sottolinea il meccanismo dell’allusione, “qualunque cosa si senta sulla pagina senza essere nominata”, come arte suprema dello scrittore, elevata a legge generale della composizione: “È la presenza inspiegabile della cosa non detta, della sfumatura che l’orecchio indovina ma non sente, l’atmosfera verbale, l’aura emotiva del fatto, della cosa o dell’azione, a conferire una qualità sublime al romanzo, al dramma o alla stessa poesia”. La “cosa non detta”, in quanto repressa, in quanto indicibile (“l’amore che non osa dire il suo nome”, lo definì Oscar Wilde nel suo processo per sodomia), diviene così la metafora della verità inesprimibile perché rimossa, e dunque annullata, resa inesistente o irraggiungibile. Esemplare, in tal senso, è il racconto Brooksmith, pubblicato nel 1891, un piccolo capolavoro di ambiguità e complessità, nella sua apparente semplicità. È la storia di un domestico, un maggiordomo – Brooksmith, appunto – che lavora a Londra al servizio di un ex diplomatico, Mr Offord, amico del narratore. La devozione assoluta dell’uomo nei confronti del suo padrone si esprime soprattutto nella supervisione che egli dedica alla perfetta riuscita degli incontri che avvengono nel salotto di Offord, dove regna un raffinato livello di conversazione intellettuale, un’armonia di rapporti e di gesti, di parole e di argomenti, che si devono appunto alle attente, silenziose e quasi invisibili cure di Brooksmith, sempre presente con discrezione e sempre disponibile a ricavare da quell’atmosfera un’educazione superiore rispetto al suo grado sociale (impara a parlare correntemente il francese, legge Montaigne e Saint-Simon). Ma sono proprio questa devozione e questa educazione a condannare poi l’uomo al fallimento, dopo la morte del padrone. Brooksmith, infatti, nonostante gli sforzi del narratore preoccupato del suo destino, non riesce a trovare un degno sostituto di Mr Offord, e vive una progressiva degradazione di ruolo e di condizione (in principio come domestico, passando di famiglia in famiglia, ma sempre in situazioni e ambienti poco soddisfacenti per lui, fino a diventare “uno dei tanti camerieri” per ricevimenti, assunto a serata), una “volgarizzazione” che lo condurrà a una “inerte malinconia servile” e – probabilmente – al suicidio. Brooksmith può essere letto almeno in tre modi diversi. In primo luogo si può definire, sorprendentemente, un racconto sulle implicazioni classiste della società londinese di fine Ottocento. E dico sorprendentemente, considerato che James è lo scrittore in apparenza più alieno dall’analisi politica e dalla lotta di classe (anche se a smentire questa ipotesi definitivamente ci penserà, qualche anno dopo, Il giro di vite). Brooksmith, “cresciuto in una classe servile”, sembra infatti qui subire una sorta di nemesi ben poco divina e molto materialistica (in senso marxiano), che lo punisce per una hybris tutta sociale, ovvero per quella sua mite tracotanza manifestata nel momento in cui ha preteso di superare le barriere sociali, educandosi alla scuola intellettuale del salotto del suo padrone, e soprattutto per esser stato tentato di sostituirsi a lui nelle funzioni di anfitrione, durante la sua malattia. La degradazione successiva alla morte di Offord è di fatto il prezzo che la società gli fa pagare per aver avuto la presunzione di non voler restare al suo posto (“La sua sensibilità era tale che non avrebbe mai potuto approvarsi come sostituto di Mr Offord, ma, saturato dall’abitudine al punto da ritenerla una sorta di religione, in favore dei nostri amici avrebbe compiuto quel sacrificio necessario per venerare la divinità”). Cruciale, allora, è la visita del narratore a Brooksmith, che – scopriamo per la prima volta – vive in una “sordida stradina”, dentro una camera che odora di umido, “come di biancheria sporca messa a bollire”: il domestico è sorpreso seduto a una finestrella da dove si potevano vedere “bottega di un lattoniere e una piccola e viscida taverna”. Tutto, in questa scena – gli oggetti, i colori, gli odori –, sembra voler denunciare lo status inferiore di Brooksmith, la sua distanza dall’ambiente che ha frequentato durante tutti quegli anni di servizio presso Mr Offord, lo squallore e la miseria in cui è costretto a vivere. Attraverso lo sguardo del narratore assistiamo così alla definitiva sconfitta di Brooksmith, espulso da un Eden sociale al quale si è illuso di poter appartenere.
C’è poi un secondo livello di lettura del racconto, ed è quello che riguarda la natura mimetica del desiderio che esso mette in scena. Che rapporto lega Brooksmith al suo padrone? Il narratore afferma che l’uomo è il maggiordomo di Mr Offord, ma anche il “suo più intimo amico”. E quando Mr Offord muore, in un momento di abbandono Brooksmith confessa la sua disperazione al narratore, il quale giudica quella confessione come “la parola definitiva dell’intera vicenda”: “Oh, signore, per voi è triste, è davvero molto triste, e lo è per moltissime dame e per moltissimi gentiluomini; proprio così, signore. Ma per me, signore, è, se posso dirlo, anche più grave: è semplicemente aver perso qualcosa che era tutto”. E che rapporto lega il narratore a Brooksmith e allo stesso Offord? Che cosa si cela dietro questa sua ossessione per il domestico e per il suo destino, dopo la morte del padrone? Mr Offord ci viene descritto dal narratore come “il più simpatico e affettuoso degli scapoli”, “l’inglese più delizioso che si fosse mai conosciuto”. Appartenere alla sua cerchia ristretta di habitué voleva dire appartenere a un’Arcadia esoterica ed esclusiva. Un’Arcadia felice alla cui realizzazione ha contribuito in maniera decisiva Brooksmith. Ci troviamo così di fronte a un chiaro schema triangolare, una relazione a tre mediata, che rimanda al desiderio imitativo teorizzato da René Girard: il soggetto desidera un oggetto attraverso la mediazione di un modello, cioè dell’altro che si ammira e si desidera imitare. L’interesse del narratore nei confronti di Brooksmith è dunque un desiderio imitativo, un desiderio secondo l’altro, che è sempre desiderio di essere l’altro. Ma questo desiderio di essere l’altro, che passa attraverso una mediazione, come spesso accade nell’opera di James è anche desiderio dell’altro, un desiderio omoerotico mai dichiarato, omesso, censurato, impronunciabile. Mi sembra, a questo proposito, rivelatore soprattutto un passo del racconto, laddove il narratore afferma il desiderio imitativo nei confronti di Mr Offord, ricorrendo non a caso alla parentesi, attraverso la sua stessa negazione, ovvero il desiderio viene dichiarato impronunciabile (la “cosa non detta”), ma allo stesso tempo affermato nell’ordine del discorso: “A quei tempi non avrei potuto permettermelo […] ma anche qualora le mie entrate l’avessero permesso, non avrei osato dire a Brooksmith (emulando Mr Offord): ‘Mio caro amico, vi prenderò io’”
Ma c’è un’ultima lettura del testo, in qualche modo complementare alla precedente, ed è una lettura che sembra preannunciare il tema dello sdoppiamento dell’artista che James avrebbe affrontato, in maniera più esplicita, l’anno successivo con La vita privata. È lo stesso narratore a suggerircela, quando, parlando della gestione del salotto di Mr Offord, del mistero che si nasconde dietro la sua naturalezza e armonia, afferma che quella mondanità così perfetta è il risultato di un’arte dissimulata. E da qui la domanda attorno a cui si arrovella: “Chi era, dunque, quest’artista occulto?”. La risposta giunge poche righe dopo, ed è la scoperta che alla “base di quel mistero” vi è proprio Brooksmith, che “Brooksmith, in poche parole, era l’artista!”. Del resto, lo stesso narratore aveva dato vita, poco prima, a una metafora illuminante, dichiarando che “il salotto di Mr Offord era davvero il giardino di Brooksmith, il suo parterre umano, potato e ben curato”. Una metafora che ci richiama subito alla mente la frase che lo stesso James scrisse nella prefazione al romanzo Gli ambasciatori (1903): “L’arte tratta di ciò che vediamo” scrive James “deve anzitutto offrire a piene mani quell’ingrediente: raccoglie il suo materiale, per dirla altrimenti, nel giardino della vita – il quale materiale, cresciuto altrove, è stantio e immangiabile”. E se il salotto di Mr Offord è il “giardino della vita” da cui, secondo James, l’arte deve raccogliere il suo materiale, chi è Brooksmith se non l’artista, appunto? Il salotto mondano di Offord diviene così la metafora della vita a cui lo scrittore attinge, quel giardino che lo scrittore osserva e di cui seleziona il materiale, per evitare che possa diventare, altrove, “stantio e immangiabile”.
James, dunque, ancora una volta parte da un presupposto proustiano per poi superarlo, negarlo. Da un lato l’antitesi tra la vita – “tutta inclusione e confusione” – e l’arte – “tutta discriminazione e scelta” – laddove quest’ultima va “in cerca del duro valore latente di cui solo si preoccupa” (un’antitesi che esprime una fiducia di partenza nell’arte, nella sua capacità di manifestare un potere rivelatorio, di mettere ordine e dare senso alla realtà, di illuminarla di significato); dall’altro l’approdo a una buia disfatta, a una impasse cognitiva che incrina quella fiducia, crepandola dall’interno. Come scrive Blanchot, la narrativa di James rappresenta “il movimento meraviglioso e terribile che lo scrivere esercita sulla verità, tormento, tortura, violenza che infine conducono a morte, dove tutto sembra che si riveli, e tutto ripiomba nel dubbio e nel vuoto delle tenebre”. La letteratura per James allora non svela più la “vita vera”, come in Proust, ma solo il vuoto di significato che la vita stessa cela. E lo fa ponendosi come inchiesta, come quête esistenziale e narrativa allo stesso tempo, come “critica della vita” (quello stesso “criticism of life” la cui atmosfera Brooksmith vuole, con cento pretesti, respirare nel salotto di Mr Offord attraverso una “partecipazione intensa”). Che cosa succede, infatti, quando questa critica porta fino in fondo la sua ricognizione? Per l’artista-Brooksmith (anche lui, in effetti, un doppio, il doppio di Mr Offord, anche lui dunque un Hyde solitario e criminale che ha bisogno del suo dottor Jekyll) il salotto mondano è la “fonte sacra” da cui egli attinge la sua arte, ma è proprio la rivelazione ultima che quella società nasconde a determinare il fallimento, la perdita, il vuoto a cui essa inevitabilmente conduce. L’epilogo del racconto che cosa ci dimostra? Allo stesso modo in cui, secondo Girard e la sua triangolazione, il desiderio non raggiunge mai il suo vero oggetto e “conduce all’oblio, alla delusione, alla morte”, così anche la scrittura in James non riesce più a cogliere il suo obiettivo, ma è costretta a contemplarne l’assenza. Da quando Mr Offord si ammala, da quando cioè il suo salotto mondano è contagiato dalla malattia, qualcosa nel meccanismo ineccepibile dell’arte del maggiordomo si inceppa, il “giardino della vita” va in rovina finché la morte non espelle Brooksmith dal luogo che lui stesso ha creato. Questa cacciata edenica segna la fine del domestico, poiché la “critica della vita” a cui lui si è votato non può che condurre proprio “all’oblio, alla delusione, alla morte” che la dinamica del desiderio triangolare aveva attivato.
Nel suo seminario sull’Etica della psicoanalisi, Jacques Lacan illustra come il desiderio inconscio ruoti attorno a un vuoto di senso, che chiama la “Cosa”. Questo vuoto centrale attorno a cui, dice Lacan, è organizzata l’arte, è impossibile e reale allo stesso tempo. Se questo vuoto, questo silenzio, questo non-senso, per l’essere umano, è strutturalmente centrale, come può l’arte del Novecento non organizzarsi attorno a esso, che sia per sublimarlo o per smascherarlo? Come può, dunque, anche la narrativa non tenerne conto?