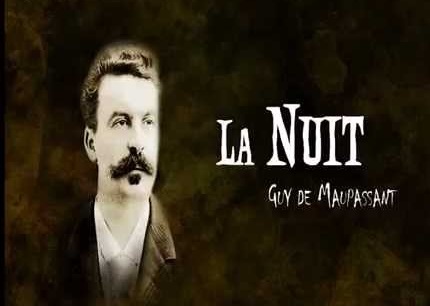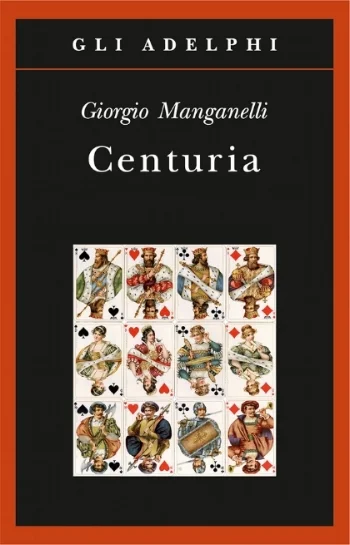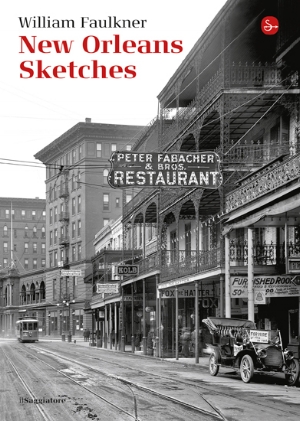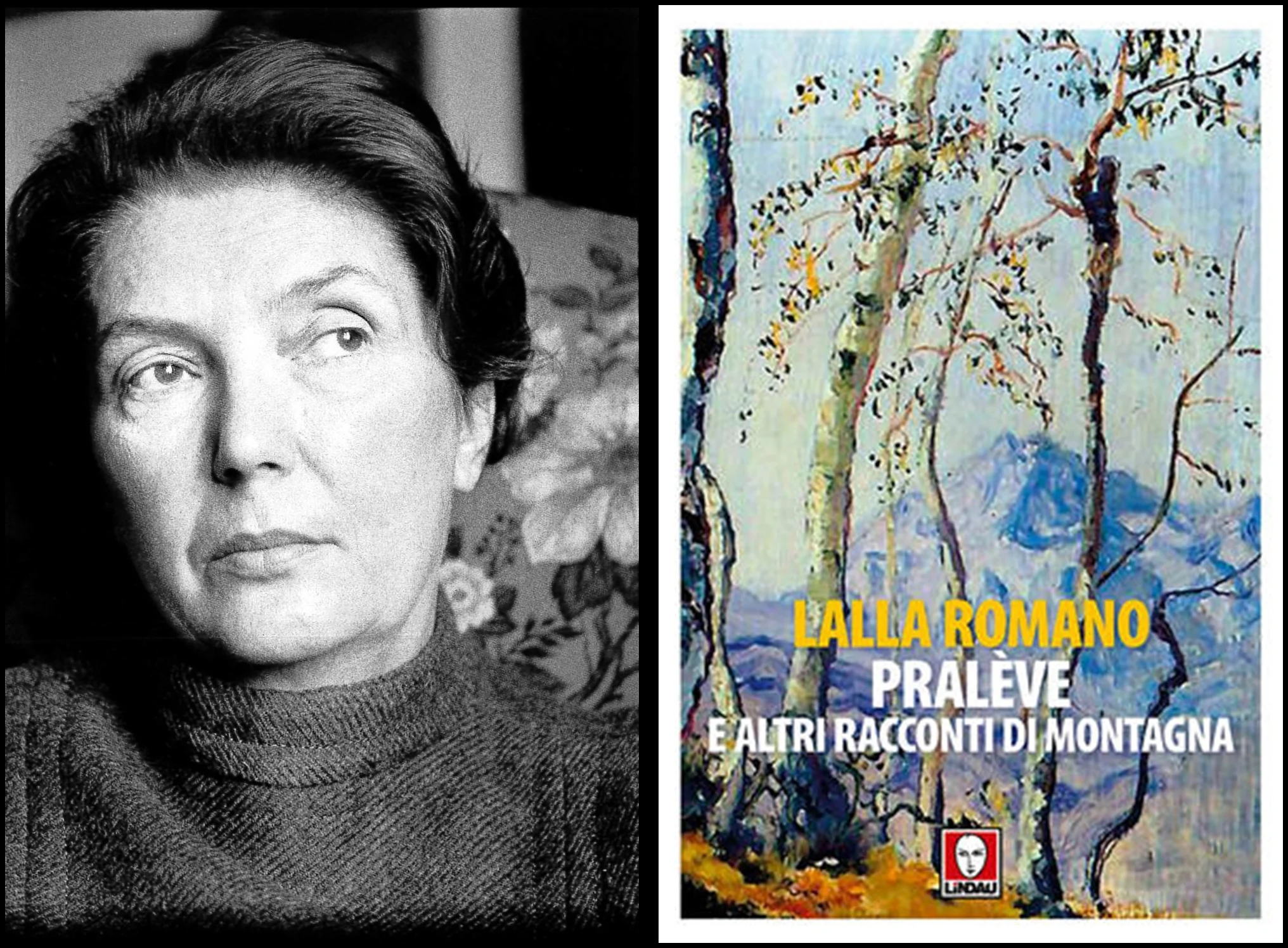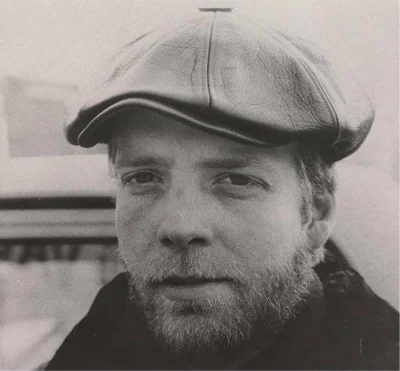Il nuovo numero della rivista "Nuova Corrente" è intitolato Racconti di una vita: la narrazione biografica breve nella tradizione contemporanea. Si tratta della raccolta degli atti della giornata di studi sul racconto del 2018, tenutasi all'Università di Bergamo, a cura di Giacomo Raccis e Damiano Sinfonico.
Per Cattedrale pubblichiamo il saggio di Lorenzo Marchese.
Compimento e deriva.
Una definizione del rapporto fra short story e biografia nella narrativa contemporanea
di Lorenzo Marchese
1.
Esistono dei tratti distintivi del rapporto fra biografia e racconto breve (o short story che dir si voglia)? Partendo dal presupposto che è difficile definire il racconto breve a partire da criteri tematici o strutturali (se si eccettua la categoria largamente arbitraria della “lunghezza”), per rispondere a questa domanda è mia intenzione partire da un possibile inquadramento teorico della biografia. O meglio, vorrei proporre una distinzione di lungo corso fra due tipi di biografia che si avvicendano l’uno all’altro intorno alla fine dell’800, in base a un criterio di contenuto relativo alla modalità di svolgimento della vita dei personaggi biografati. Desidero premettere che questi due tipi non esauriscono, nella mia analisi, ogni ambito della biografia, ma indicano soltanto due linee di tendenza facilmente osservabili e funzionali a isolare dei criteri di contenuto. Da questi criteri di contenuto conseguono, in base alla mia lettura, alcune costanti formali che, spero, aiuteranno a caratterizzare il rapporto predominante fra racconto breve e short story nella letteratura contemporanea.
Per biografia s’intende la forma, già nota nell’età ellenistica e rappresentata successivamente da testi centrali della storia letteraria come le Vite parallele di Plutarco, del racconto della vita di un personaggio più o meno noto, scritta da una terza persona, dalla nascita fino al momento della composizione del libro (o, altrimenti, al momento della stabilizzazione del personaggio – spesso grazie alla sua morte). Sebbene la biografia debba obbedire al criterio storico dell’attendibilità, il che significa che tutto ciò che vi si racconta è da prendere per empiricamente vero e non per frutto della fantasia del biografo, biografia e racconto storiografico non sono sovrapponibili. Anzitutto, perché la biografia può anche essere immaginaria e riguardare soltanto in apparenza un personaggio davvero esistito. A differenza del racconto storiografico-annalistico, inoltre, la biografia antica si occupa principalmente di raccontare la storia di un individuo distintosi per meriti (o per particolari demeriti). Prendiamo, restringendo il campo, una delle opere fondative del genere biografico, le Vite parallele di Plutarco, pubblicate verso la fine del I secolo d.C.
Nella biografia plutarchea l’obiettivo principale è restituire con nettezza e verosimiglianza i tratti notevoli di questa individualità, permettendo al lettore di capire perché essa sia stata ritenuta degna di essere tramandata ai posteri: la grande storia delle battaglie, dei trattati, delle azioni politiche entra di scorcio, solo se funzionale a restituire l’immagine del biografato. Si tratta di una scelta prospettica estremamente netta, che già all’epoca attirò numerose critiche a Plutarco (uno scrittore, per i canoni elastici della storiografia antica, estremamente scrupoloso nel rendere conto delle fonti utilizzate per scrivere le proprie Vite). Un conto è raccontare le vite di personaggi leggendari dal dubbio statuto di esistenza, come Teseo e Romolo; un altro comporre le biografie di vere e proprie celebrità morte da poco tempo, come Alessandro Magno e Caio Giulio Cesare, sulle quali esistevano già al tempo numerosi resoconti storici. Non è un caso che l’unica precisazione sul senso del proprio lavoro, nelle Vite parallele, stia proprio in apertura della biografia di Alessandro Magno. Dato che il pubblico di lettori, verosimilmente, aveva una buona conoscenza dei dati storici su Alessandro Magno e il contesto in cui visse, questo stesso pubblico poteva non apprezzare la scelta di Plutarco di trascurare il racconto dettagliato dei fatti storici (o di raccontarlo in modo impreciso, come spesso fa). L’incipit della Vita di Alessandro serve a chiarire la netta scelta di campo di Plutarco:
Io non scrivo storia, ma biografia; e non è che nei fatti più celebrati ci sia sempre una manifestazione di virtù o di vizio, ma spesso un breve episodio, una parola, un motto di spirito, dà un’idea del carattere molto meglio che non battaglie con migliaia di morti, grandi schieramenti d’eserciti, assedi di città. Come dunque i pittori colgono le somiglianze dei soggetti dal volto e dall’espressione degli occhi, nei quali si avverte il carattere, e pochissimo si curano delle altre parti, così mi si conceda di interessarmi di più di quelli che sono i segni dell’anima, e mediante essi rappresentare la vita di ciascuno, lasciando ad altri la trattazione delle grandi contese [PLUTARCO, Vite parallele. Alessandro, Cesare, introduzioni di Domenico Magnino e Antonio La Penna, traduzione e note di Domenico Magnino, BUR, Milano 2005, Alessandro, 1, 1-3].
Una precisazione, prima di tutto: Plutarco nel testo originale usa i termini “storie” (istorìas) e “vite” (bìous): come spesso accade nella cultura greca antica, il termine “biografia” non esiste, e tanto meno il concetto di “storiografia”. Poi, a un’occhiata approfondita al testo, emerge con chiarezza quello che la biografia vuole essere (e sarà a lungo nella storia letteraria), in contrapposizione alla storiografia che tende al racconto impersonale e oggettivo: biografia è il racconto di una vita individuale, in cui i tratti all’apparenza insignificanti o minori si riscattano dalla loro irrilevanza e finiscono per esprimere l’essenza del biografato meglio dei dati storici più noti. Dettagli in apparenza di scarso peso come gli aneddoti d’infanzia, gli episodi della vita privata, i sogni, i desideri e le idiosincrasie, cioè, esprimono già il carattere complessivo dell’individuo e ne preannunciano il destino. Questa parola esprime un concetto antico e familiare ai lettori di Plutarco, meno a quelli contemporanei. Nella biografia morale, tragica e spiccatamente narrativa di Plutarco (e in misura minore nelle biografie coeve, di taglio antiquario e ordinate per criterio tematico delle Vite Caesarum di Svetonio), ogni episodio raccontato concorre a illustrare il compimento di un destino.
Chiamo questo sviluppo finalistico dell’individuo nel racconto biografico, in cui l’inveramento del destino è centrale e permette un ammaestramento morale del lettore da parte del biografo, con il termine-etichetta di “compimento”. Questo tipo di biografia nel segno del compimento è universale, finalistico e centripeto. Mostra, in questo senso, una coerenza tematica e strutturale che porta il lettore a un’acquisizione conoscitiva certa. Persino le apparenti divergenze incontrollate dei personaggi, alla fine, rientrano nel solco tracciato e obbediscono al rispetto della natura predeterminata del singolo (fysis). Plutarco stesso, d’altronde, precisa, all’inizio della Vita di Nicia:
Perciò i fatti narrati da Tucidide e Filisto, che non è possibile tralasciare in quanto racchiudono soprattutto l’indole e la disposizione spirituale di Nicia, rivelata da molte e grandi sventure, io li ho scorsi rapidamente nei tratti essenziali, per non apparire del tutto trascurato e pigro; invece ho cercato di adunare le notizie sfuggite alla maggior parte degli storici e anche dagli altri riferite incidentalmente, oppure rintracciabili soltanto in antiche iscrizioni votive o decreti, non per compilare una ricerca inutile, ma per offrirne una atta alla comprensione del carattere e del comportamento del personaggio [PLUTARCO, Le vite di Nicia e di Crasso, a cura di Maria Gabriella Angeli Bertinelli, Carlo Carena, Mario Manfredini e Luigi Piccirilli, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1993, Nicia, 1, 5].
La vita individuale ha una sua finalità, e dall’inizio al termine essa non scarta dalla tensione a questa finalità, raggiunta di solito nel culmine della morte o del trionfo personale. Ciò avviene perché la vita raccontata, con i suoi dettagli insignificanti, deve portare con sé un significato morale chiaro e comprensibile, che trascenda la singolarità.
Anche oltre l’epoca d’origine, la biografia è rimasta, a livello teorico, la forma di racconto che usa la vita individuale per comunicare un significato definitivo e universale ai lettori. Nella teoria critica della biografia novecentesca, singolarità e continuità stanno ancora dalla stessa parte. L’individuo ha una sua continuità di senso, la sua parabola è intelligibile a un destinatario generico. Spostandoci velocemente sull’asse temporale, possiamo vedere come il “compimento” contraddistingua le eredi più note della biografia antica nell’Età tardoantica e nel Medioevo, vale a dire le agiografie. Le vite dei Santi raccontano gli individui solo in quanto portatori di un insegnamento di fede che trascende la loro singolarità, guardata con sospetto. Anzi, più spesso nega la singolarità. D’altronde, la vita del Santo deve essere anzitutto una Imitatio Christi e dunque spersonalizzarsi il più possibile. Le agiografie rispettano il criterio della continuità, e soprattutto conservano un forte carattere normativo che mette in risalto l’esemplarità (sovrapersonale) del biografato, più che la sua singolarità irriducibile.
Le vite dei santi sono sicuramente ascetiche per i loro eroi, ma anche perché esse si indirizzano ad asceti o a candidati all’ascesi. In tal modo esse hanno spesso un carattere quasi tecnico, come altre opere ascetiche, e vogliono proporre, così come i meravigliosi santi, modelli imitabili e insegnamenti direttamente utili […] Tuttavia si farà attenzione al fatto che l’autore ha la preoccupazione, più che di scrivere una vita, di fissare una norma, ed egli propone ai suoi lettori, come scopo ultimo da raggiungere, l’immagine purificata delle virtù eroiche.
Le agiografie non mirano tanto a raccontare vite di persone realmente esistite, ma indicano una direzione spirituale esemplificata da una vita, la quale del resto è preordinata da un’entità superiore (Dio) e dunque estranea a svolgimenti casuali. Va ricordato per completezza che la narrazione degli exempla medievali parte sempre dall’aneddoto che diventa chiave di volta del senso dell’intero racconto. L’agiografia, stretta parente degli exempla, muove ugualmente dal dettaglio dell’aneddoto biografico per illuminare di senso trascendente l’intera vita del santo – e, di riflesso, quella dei lettori-fedeli. Si tratta dell’estremizzazione del “compimento” biografico per come l’abbiamo fin qui delineato. Non si danno altri esempi per non appesantire l’intervento, ma chi volesse tracciare una linea storica di biografie nel segno del “compimento” anche molto oltre l’età premoderna (dalle Vite vasariane, alle autobiografie, nella letteratura di consumo contemporanea, dei personaggi famosi, dei politici, dei campioni dello sport, coadiuvati dai ghost-writer) non avrà penuria di esempi.
2.
Il secondo tipo di biografia che ho cercato di isolare – e che, ribadisco, non esaurisce tutto il genere biografico antico e moderno – non nasce parallelamente al primo tipo. Si sviluppa molto più tardi, in aperta contrapposizione alle biografie come racconti teleologici che illustrano il compimento di un destino. A differenza del “compimento”, questo secondo tipo di biografia nasce e prospera esplicitamente con la forma del racconto breve, e ha un atto di nascita preciso: 1896. In questa data Marcel Schwob pubblica la breve raccolta delle Vite immaginarie, in cui sono raccontate, ciascuna nel giro di poche pagine, le vite di uomini e donne dall’Antichità al primo Settecento, complessivamente di secondo piano rispetto a re e imperatori, ma comunque passati alla storia per i più vari motivi. Schwob, tuttavia, non sceglie di raccontare le vite di questi personaggi perché esse siano significative, ma, in aperta polemica con l’idea della biografia come “compimento”, proprio perché non hanno alcun significato al di fuori della particolarità. Nella Prefazione all’opera, Schwob precisa:
L’arte si pone dalla parte opposta delle idee generali, non descrive che l’individuale, non desidera che l’unico. Non classifica; sclassifica. Per quanto ci concerne, le nostre idee generali possono anche essere simili a quelle che hanno corso nel pianeta Marte e tre linee che si intersecano formano un triangolo in tutti i luoghi dell’universo [M. SCHWOB, Prefazione a Vite immaginarie [1896], a cura di Fleur Jaeggy, Adelphi, Milano 2012, p. 13].
Ciò che di generale vi è nella vita individuale (l’esempio che essa può costituire, il significato religioso o politico, l’ammaestramento morale), non esprime nulla dell’individuo in carne e ossa. A restituirci l’individualità, al contrario, sono i tratti personali, irriducibili a idee generali e immaginazioni condivise:
Le idee dei grandi uomini sono il patrimonio comune dell’umanità; ognuno di loro non possedette realmente che le proprie bizzarrie. Il libro che descrivesse un uomo con tutte le sue anomalie sarebbe un’opera d’arte come una stampa giapponese dove si vede eternamente l’immagine di un minuscolo bruco visto una volta in una certa ora del giorno.
Le storie rimangono mute su queste cose. Nella grezza raccolta di materiali che le testimonianze forniscono, non ci sono molti frammenti singolari e inimitabili. Soprattutto i biografi antichi sono avari. Dando valore solamente alla vita pubblica o alla grammatica, essi ci tramandarono, dei grandi uomini, i discorsi e i titoli dei loro libri [p. 14]
Questa dichiarazione di Schwob, portata fino in fondo, indica che ogni vita è irrelata rispetto alle altre, non significa nulla in rapporto a un contesto comune. La cura dei dettagli minori impedisce la creazione di un senso generale che spersonalizzerebbe la singola vita, inglobandola in un sistema di senso che ne tradisce l’unicità. Nelle Vite immaginarie, l’interesse è concentrato sull’individualità dei singoli che, in fondo, si equivalgono nel loro essere uniche e soggette non più al compimento sovrapersonale del destino, ma all’azione incontrollata del caos: « L’arte del biografo consiste appunto nella scelta. Non deve preoccuparsi di essere vero; deve creare entro un caos di tratti umani. Leibniz dice che, per fare il mondo, Dio ha scelto il migliore fra i possibili. Il biografo, come una divinità inferiore, sa scegliere, fra i possibili umani, quello che è unico», p. 20.
Come la biografia del “compimento” è universale, finalistica e centripeta, così questo secondo tipo moderno, che inquadro con l’etichetta (senza inflessioni morali) di “deriva”, è particolare, anti-finalistica e centrifuga. Nel tipo della “deriva”, la biografia non è maestra di nulla che ci riguardi. La caduta di sovrastrutture ideologiche e religiose concorre solo in parte a spiegare questa perdita di finalismo e di universalità nel racconto biografico, se pensiamo all’opera autobiografica di Nietzsche Ecce homo, di soli otto anni prima delle Vite immaginarie ed eloquente fin dal titolo dell’ultimo capitolo Perché io sono un destino. A sua volta, la storia, nel tipo inaugurato da Schwob, è un fondale estraneo e non c’è a priori differenza qualitativa fra Napoleone e il suo domestico: entrambi, con il loro catalogo di tratti irriducibili, appartengono allo stesso gruppo come vi apparterrebbero due numeri primi, e sono soggetti all’arbitrio del caso, impossibili da giudicare.
Secondo una lettura simile, cade la validità dell’“infamia” come criterio distintivo della biografia contemporanea. Tuttavia, a Schwob l’infamia dei suoi personaggi in quanto tale interessa solo parzialmente. Ciò che colpisce, alla lettura delle Vite immaginarie, è l’equiparazione sostanziale di Lucrezio e i signori Burke e Hare (pluriomicidi britannici del primo Settecento), di Paolo Uccello e Pocahontas. Il fatto di essere stati tramandati alla Storia, di essere fissati nella memoria delle generazioni successive come persone illustri, è frutto dello stesso caso che correda ogni singola persona di certi tratti caratteristici irripetibili. Schwob lo rimarca nelle vite di personaggi famosi, dove solo a fatica possiamo riconoscere nei biografati dei personaggi illustri. Nella vita di Clodia vediamo bene che per Schwob la coincidenza di Clodia, matrona romana, e della più nota Lesbia amata e cantata da Catullo è, per rubare un termine a un ambito del tutto diverso come quello dell’autofiction, una «sconcertante omonimia». Il nome di Pocahontas, nell’omonima biografia, è un trucco degli indiani per impedire malefici sulla vera principessa, che si chiama Matoaka. Ciò che conta davvero in Petronio, passato alla Storia suo malgrado come romanziere, è la sua esperienza di girovago e delinquente per le strade dell’Impero (p. 76). I legami che fanno da collante alle singole esistenze sono casuali, non causali. Inoltre, le vite della raccolta sono in rapporto fra di loro per analogia, non secondo rapporti logici: «La notte in cui Erostrato incendiò il tempio di Efeso venne al mondo Alessandro, re di Macedonia» (p. 37).
Cos’altro ci dice questa insistenza sull’unicità? Oltre a richiamarsi esplicitamente alle Vite brevi di uomini eminenti (1680-1696) di John Aubrey, che per prime utilizzano la coesistenza paradossale di tratti caratteristici e l’arguzia barocca per privare le vite di teleologia ed esemplarità e renderle uniche («Se tentassimo l’arte in cui eccelsero Boswell e Aubrey, non dovremmo certo descrivere minuziosamente il più grande uomo del tempo, o annotare la caratteristica dei più celebri del passato, ma raccontare con la stessa cura le esistenze uniche degli uomini, siano essi stati divini, mediocri, o criminali», p. 21),Schwob riprende di fatto un paradigma dell’autobiografia moderna, a partire da Rousseau (come prova la sua riflessione sullo sviluppo moderno del «sentimento dell’individuale»): ogni persona è unica, lo stampo usato per forgiare ciascun individuo viene spezzato dopo un solo impiego. Ma ciò non conferisce alle vite di Schwob la cornice di senso che resiste in Rousseau. Gli eventi che occorrono a Lucrezio e gli altri non sono predeterminati, non aiutano a definire chiaramente il carattere individuale. Le singole sequenze della biografia non si dispongono in una sequenza lineare e comprensibile, ma rimangono spezzoni irrelati, dalla coesistenza contraddittoria. La morte non è un compimento e una consacrazione, bensì una brusca interruzione che spesso smentisce il corso biografico precedente. L’ultima biografia delle Vite immaginarie è esemplare a questo riguardo: raccontare la fine dei signori Burke e Hare implicherebbe rovinare la loro eccezionalità e corredare di un giudizio morale non voluto la loro folgorante carriera di assassini, perciò Schwob fa ironicamente mostra di non voler terminare il racconto (pp. 197-8). Le biografie di Schwob inaugurano così una linea genealogica non più fondata sulla modellizzazione, sulla tipizzazione, sul carattere ideale, ma sul dettaglio anomalo e irriducibile, sulla presenza di tratti bizzarri che impediscono di incasellare gli individui in categorie che li trascendono.
3.
Con la linea aperta da Schwob, possiamo individuare nella scrittura biografica novecentesca, da una parte, tutte quelle biografie che continuano a utilizzare il racconto della vita individuale in quanto rivelatore di un significato storico che oltrepassa l’unicità e ci permette di cogliere un significato generale (“compimento”). In questo filone s’inscrive nel complesso la biografia modernista, come il noto Eminenti vittoriani [1918] di Lytton Strachey (membro di spicco del Bloomsbury Group). Raccontando le storie di quattro personaggi illustri del secondo Ottocento attraverso dettagli biografici meno noti, il fine della scrittura resta comunque trarre un valore storico sovraindividuale dalle gesta degli individui. Anche l’attenzione inedita alla vita interiore, più romanzesca che biografica, va nella stessa direzione. La brevità di alcune di queste biografie, infine, non è perseguita nel segno di un racconto casuale, ma soltanto col fine di eliminare le ridondanze, conservando soltanto i dettagli significativi per un quadro generale.
Dall’altro lato, stanno le biografie che usano il racconto per esprimere la casualità a cui tutte le esistenze soggiacciono: prive di completezza, di ordine, di un’ideologia che le sovradetermini, appartengono alla linea di tendenza esclusivamente contemporanea che abbiamo definito “deriva”. Non si tratta di una distinzione completamente nuova: il problema della biografia come costruzione di senso è già avvertito a cavallo fra Otto e Novecento, come prova, per esempio, una nota riflessione di Paul Valéry, contenuta in un discorso sul metodo di pensiero dedicato (per l’appunto) a Marcel Schwob:
Un autore che componga una biografia – può tentare di vivere il proprio personaggio oppure di costruirlo. Sono scelte opposte. Vivere, equivale a trasformarsi nell’incompleto. La vita in tal senso è tutta aneddoti, dettagli, istanti. La costruzione, al contrario, implica le condizioni a priori di un’esistenza che potrebbe essere – TUTT’ALTRA.
È questo il tipo di logica che, nel susseguirsi delle esperienze sensibili, conduce alla costituzione di un Universo, quale l’ho definito più sopra – e porta, nel nostro caso, a un personaggio.
Si tratta, in conclusione, di un uso del possibile del pensiero, controllato dal maggior grado di coscienza possibile [P. VALÉRY, Introduzione al metodo di Leonardo da Vinci [1895 in rivista «Nouvelle Revue», in volume nel 1919 – nuova edizione con note a margine, nel 1930: il brano citato è una di queste note a margine], in Idem, Opere scelte, a cura e con un saggio introduttivo di Maria Teresa Giaveri, Mondadori, Milano 2014, pp. 290-1].
Quasi quarant’anni dopo, le biografie della “deriva” tornano nei racconti brevi della Storia universale dell’infamia di Jorge Luis Borges. Solo in tarda età Borges ammetterà il suo debito con le Vite immaginarie di Schwob: un debito che appare comunque evidente nella precisa scelta di campo per l’interpretazione delle singole vite. Dal Prologo alla prima edizione:
Gli esercizi di prosa narrativa che compongono questo libro furono eseguiti fra il 1933 e il 1934. Derivano, credo, dalle mie riletture di Stevenson e Chesterton ma anche dai primi film di von Sternberg e forse da una certa biografia di Evaristo Carriego. Abusano di alcuni procedimenti: le enumerazioni caotiche, la brusca soluzione di continuità, la riduzione dell’intera vita di un uomo a due o tre scene. […] Non sono psicologici, né aspirano ad esserlo [J. L. BORGES, Prologo alla prima edizione in Storia universale dell’infamia [1935], traduzione di Vittoria Martinetto e Angelo Morino, Adelphi, Milano 1997, p. 9].
Possiamo anzitutto notare che Borges nomina alcuni procedimenti per rendere le biografie discontinue e incomprensibili al di fuori della loro unicità: tecniche che appaiono già in Schwob e che saranno riprese anche da scrittori biografici della “deriva” nelle epoche successive (Perec, Echenoz, Bolaño). Secondariamente, l’accento non è posto sull’infamia e sulla marginalità dei personaggi. Nella raccolta di Borges non è tanto importante restituire la dimensione infima e immorale di personaggi poco noti, bensì trasformare le vite degli uomini in un puro ricamo intercambiabile, meraviglioso da osservare, ma sul quale è improprio formulare giudizi morali o di valore. A reggere le vicende umane è il Destino, che non è certo un’intelligenza o un apriori di qualche tipo, ma solo «il nome che diamo all’infinita opera incessante di migliaia di cause rimescolate» (p. 3. Borges lo rende esplicito nel nuovo Prologo all’edizione del 1954:
I dottori del Grande Veicolo insegnano che la proprietà essenziale dell’universo è la vacuità. Per quanto riguarda quella minima parte dell’universo che è questo libro, hanno pienamente ragione. Patiboli e pirati lo affollano e la parola «infamia» dirompe nel titolo, ma sotto il clamore non c’è nulla. È solo apparenza, una superficie di immagini; per questo potrà forse piacere [p. 12].
La biografia borgesiana, contrapposta a quella modernista di Strachey (solo in parte diverso il discorso per Virginia Woolf) ritorna a influenzare alcune delle biografie della “deriva” più significative della seconda metà del Novecento, spesso ascritte alla logica della letteratura postmodernista. Prendiamo quello che viene di solito definito, genericamente, un romanzo: La vita, istruzioni per l’uso di Georges Perec, in cui si cerca di fornire una descrizione completa di un condominio parigino e dei suoi abitanti. A corredo della descrizione minuziosa di arredi, locali e persone (che sembrano condividere, nelle pagine del libro, lo stesso statuto ontologico), ci sono numerosissimi racconti biografici (i personaggi sono all’incirca duemila), tanto che La vita, istruzioni per l’uso potrebbe essere definito tanto un romanzo quanto una disordinata silloge di biografie che vanno dalle poche righe alle tre-quattro pagine di lunghezza – e non è un caso che il sottotitolo in lingua originale sia Romans (romanzi). Queste biografie condividono la natura disordinata e particolare di quelle di Schwob e Borges: cosa ancora più interessante, esse appartengono sia a persone “vere” (non realmente esistite, ma che esistono come esseri viventi nel libro: per esempio gli inquilini del condominio) sia a immagini di persone incastonate negli arredi, descritte nei libri e raffigurate nelle incisioni che abbelliscono gli interni degli appartamenti. Che conseguenza ha questa scelta? In sintesi, i personaggi illustrati in documenti, libri e immagini d’arredo non differiscono dalle persone viventi agli occhi dell’autore-biografo. L’equivalenza delle vite illustri e infami nelle biografie della “deriva” non potrebbe avere una controprova più esplicita. Ekphrasis e biografia finiscono così per sovrapporsi nella Vita istruzioni per l’uso. Raccontare le vite non è che restituire dei frammenti, ricomposti in un ordine illusorio da un autore che non sa bene cosa stia facendo e non ha un criterio generale a guidarlo. Le vite hanno una traiettoria incomprensibile e il loro termine non conferisce retrospettivamente un senso: la morte non aiuta a comprendere nulla, è un insieme di «immagini grottesche di una casa crollata». Il compito dell’autore diventa simile a quello di Bartlebooth, uno dei personaggi preminenti dell’opera (“protagonista” è un termine forse eccessivo): usare le biografie dei suoi personaggi come tessere di un puzzle, irrelate se prese a se stanti, capaci di significare qualcosa di compiuto (forse) solo se associate a comporre il quadro completo. Per capire l’intento dell’autore che (ri)compone un mondo narrativo:Immaginiamo un uomo la cui fortuna fosse pari solo all’indifferenza verso quello che generalmente la fortuna permette, e il cui desiderio fosse, con molto più orgoglio, cogliere, descrivere, esaurire, non la totalità del mondo – progetto che il suo stesso enunciato è sufficiente a mandare in rovina – ma un frammento costituito di quest’ultimo: di fronte all’inestricabile incoerenza del mondo, si tratterà allora di portare fino in fondo un programma, ristretto, sì, ma intero, intatto, irriducibile.
Bartlebooth, in altre parole, decise un giorno di organizzare tutta la sua vita intorno a un progetto unico la cui necessità arbitraria non avrebbe avuto uno scopo diverso da sé.
L’idea gli venne quando aveva vent’anni. Fu sulle prime un’idea vaga, una domanda che si poneva: cosa fare?, una risposta che si abbozzava: niente. Il denaro, il potere, l’arte, le donne, non interessavano Bartlebooth. Come neanche la scienza, né il gioco [G. PEREC, La vita istruzioni per l’uso [1978], traduzione di Daniella Selvatico Estense, BUR, Milano 2016, p. 128].
In epoca più recente, altri esempi di biografie della “deriva” (sempre nella forma di racconti brevi) sono la cosiddetta trilogia di racconti lunghi di Jean Echenoz (Ravel, 2006; Correre, 2008; Lampi, 2010) e una cospicua sezione dell’opera di Roberto Bolaño. Concentriamoci sul secondo per alcune veloci considerazioni. Uno dei primi testi di Bolaño a ottenere un grande successo è nel 1996 La letteratura nazista in America, una raccolta di biografie di scrittori nazisti compresi fra la fine dell’Ottocento e il 1996: sono tutte vite completamente inventate, narrate però come se fossero biografie di persone davvero esistite (date di nascita e di morte, ricapitolazione di eventi biografici, dati e testimonianze a corredo). Come per i testi finora menzionati, la dispersione del dettaglio (frequenti le digressioni, dagli arredi alle letture dei testi immaginari composti dagli autori nazisti) e la distanza sottilmente ironica del biografo privano di un senso lineare e di una portata morale le biografie. Le vite dei letterati nazisti risultano così la somma di eventi difformi, che non permettono al lettore di formulare un giudizio conclusivo su di loro.
L’equivalenza delle vite, in questa circostanza, è a dir poco sorprendente se consideriamo di quali persone si stia parlando. Dati i trascorsi di Bolaño e dei cileni della sua generazione con la dittatura di Pinochet, sarebbe logico aspettarsi una qualche interpretazione forte (o comunque ostile all’ideologia nazista). I letterati nazisti sudamericani, dopotutto, potrebbero essere letti come gli ideologi e i mandanti delle dittature sudamericane che hanno oppresso il continente nella seconda metà del Novecento, come persone che in un dato momento hanno fatto qualcosa che li ha condotti consapevolmente a commettere il male. Invece no. Fra le vite dei letterati nazisti e quelle di Arturo Belano, o di Benno von Arcimboldi, non esiste una differenza qualitativa: entrambe sono degne di essere raccontate, entrambe vanno alla deriva incomprensibilmente e sfuggono a un giudizio esplicito del narratore-biografo. Ciò non significa, è chiaro, che i letterati nazisti siano innocenti vittime della Storia. Significa invece, come recita un passaggio dei Detective selvaggi, che «il nocciolo della questione è sapere se il male (o il delitto o il crimine o come lei vuole chiamarlo) è casuale o causale». Se, come sembra suggerire la scrittura di Bolaño, è casuale, il male compiuto e propagandato dai letterati nazisti non ci trasmette alcun insegnamento: i protagonisti della Letteratura nazista in America condividono la nostra biografia, sono soggetti al caso quanto noi. Non siamo diversi da loro, forse non lo saremmo stati.
La trattazione della biografia raggiunge in seguito, nella produzione di Bolaño, risultati memorabili. Tralasciando i grandi romanzi I detective selvaggi e 2666, che contengono ancora delle tracce di scrittura biografica della “deriva” (benché incorporate in una struttura eccentrica decisamente più complessa), possiamo prendere a campione la Vita di Anne Moore, inclusa nella raccolta Chiamate telefoniche. Questo racconto di statuto anomalo (Antonio Coiro ha notato che «“Vita di Anne Moore”, l’ultimo racconto di Chiamate telefoniche, è, nel suo riflesso, un romanzo-fiume di circa seicento pagine») condensa nel giro di un centinaio di pagine un’esistenza condotta da parte di Anne senza una grande consapevolezza. Il motivo delle sue azioni, che la portano da un lavoro all’altro, da una scelta alla successiva senza un nesso logico, rimane oscuro. Così la scelta di prostituirsi occasionalmente, che il biografo spiega (si fa per dire) con le seguenti parole:
Probabilmente accettò [di prostituirsi] per la tenerezza che le ispirava Charles in quei giorni. O forse perché le sembrò eccitante provare. O perché immaginò che questo avrebbe accelerato l’esplosione […] Odiò il vestito rosso, odiò le scarpe rosse, odiò la pistola di Charles, odiò l’esplosione che si annunciava ma che non arrivava mai [R. BOLAÑO, Vita di Anne Moore in Chiamate telefoniche [1997], Adelphi, Milano 2012, p. 249].
Il principio dell’equivalenza di vite soggette a una deriva casuale si fa esplicito nel momento dell’incontro fra il biografo e l’oggetto della biografia:
In genere, le sue avventure assomigliavano alle mie. Anne credeva che fosse dovuto al fatto che una vita, o una gioventù, non importa, assomigliava sempre a un’altra, anche se esistevano differenze obiettive e persino antitetiche [p. 264]
Eventi dolorosi come la morte di una persona cara, che solitamente impongono agli individui dei profondi ripensamenti e la creazione di un nuovo orizzonte di senso per continuare a vivere, portano Anne al silenzio e all’ammissione dell’enigma complessivo che sottostà alle esistenze individuali:
Ma io preferisco tacere, diceva [Anne del suicidio della sorella Susan per overdose di barbiturici], non ha senso aggiungere a questo dolore altro dolore o aggiungere al dolore tre piccoli enigmi. Come se il dolore non fosse un enigma sufficiente o come se il dolore non fosse la risposta (enigmatica) a tutti gli enigmi [p. 270].
Una vita talmente soggetta alla deriva non trova una sua consacrazione di senso nemmeno nella fine. Il testo si conclude con un’enigmatica cartolina di Anne inviata da un posto lontano al narratore-biografo («La seconda cartolina era di Seattle. Una vista aerea del porto. E molto più breve della prima e anche più inintelligibile. Capii che parlava di esilio e di delitti», Ibi, p. 272), ma non sappiamo cosa ne sarà di Anne in futuro – del resto, non sembra essere troppo importante. Si tratta di una scelta inevitabile, presa per negare qualunque ipotesi di compimento e di significazione della vita individuale. In Bolaño, si nota con facilità, i personaggi delle biografie fittizie (La letteratura nazista in America, Vita di Anne Moore o anche i personaggi dei due grandi romanzi) non muoiono praticamente mai, benché la morte sia una dimensione nota e familiare al loro orizzonte conoscitivo, nonostante la morte imperversi nell’universo narrativo. Come dal nulla (o da un passato poco chiaro) provengono, così i personaggi spariscono, se ne perdono le tracce, ma non è dato loro di morire “davanti agli occhi dei lettori”. Non è concesso loro, ponendo un termine definitivo alla loro esistenza, di permetterci di trarre dai racconti biografici qualche parabola dotata di un significato chiaro.
4.
Cosa ci dice questa distinzione abbozzata finora sul rapporto fra biografia e short story nella letteratura contemporanea? Le biografie della “deriva” contemporanee prediligono la forma breve, perché la scelta della short story permette, più della forma lunga, alcuni procedimenti delineati già da Borges («enumerazioni caotiche, la brusca soluzione di continuità, la riduzione dell’intera vita di un uomo a due o tre scene»), senza contarne altri non teorizzati dagli autori, ma evidenziati nel corso di questa breve lettura: sospensione dei nessi logici fra le sequenze degli eventi, con l’uso insistito dell’ellissi narrativa; rimozione di passaggi centrali nella scrittura biografica del “compimento” (nascita, morte); uso rovesciato del dettaglio (nel tipo del compimento, il dettaglio/l’aneddoto è accentratore di significato e compatta la figura del personaggio; nel tipo della deriva, il dettaglio diluisce la fisionomia e ne ostacola la comprensibilità); equivalenza potenziale delle vite raccontate.
Il racconto breve diventa così la forma ideale per una sintesi contraddittoria: condensare la storia di un’intera vita nel giro di poche pagine, senza però conferirle un ordine. Il tipo biografico della “deriva” finisce così per condividere uno degli aspetti più rilevanti del romanzo moderno. Stavolta non per motivi formali, ma per una ragione meno circoscritta: questo tipo di biografia adotta dal romanzo moderno la consapevolezza che le storie individuali sono tutte soggette al caso e non rette da alcuna teleologia. Esse non costituiscono l’inveramento di un’ideologia o di una religione, non rappresentano il compimento di un destino intellegibile, non significano nulla di universale.