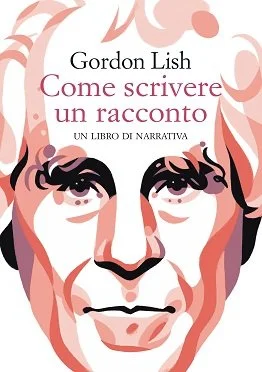di Roberto Serrai
In un’intervista citata (senza fonte, ahimé) dal Guardian lo scorso 7 ottobre, Annie Ernaux ci ricorda che «siamo fatti di parole» e che queste «ci attraversano». Tra le righe dell’articolo (di Rhiannon Cosslett) spunta un’altra riflessione: per il tramite delle parole le cose diventano vere, o più vere, proprio quando si dicono. Come uno scrittore, un traduttore non è solo fatto di parole: vive in loro compagnia, al loro servizio, e non ultimo grazie a loro. Sono così importanti da renderlo un accumulatore seriale: non le butta mai (anche quando vanno a male), le raccoglie ovunque ne trovi per custodirle, e quando occorre le ruba. Proprio come un attore (e torna il noto paragone di Umberto Eco tra il tradurre e l’interpretare un ruolo: recitare, insomma, diventare qualcun altro restando se stessi), obbligato ad avere una visibilità, può – deve? – rubare gesti, camminate, posture.
Quando mi venne proposto questo progetto presi tempo; dettagli da chiarire, ma la realtà è elementare: avevo paura. In trent’anni ho lavorato a quasi cento libri, ma l’inquietudine non se ne va. È anche una cautela: non tutte queste traduzioni sono andate come speravo; a posteriori, e non senza peccato, so che è successo le poche volte che ho creduto di saper fare. Ho preso coraggio, perché non si può fare questo mestiere e dire di no a un progetto così, ma ho intravisto sul serio l’eventualità che la mia carriera finisse. Una telefonata di Lish, furente. Penali superiori ai miei scarni depositi. Unirmi, dopo sei lustri, alla schiera di quelli che Mattia Carratello, editor presso Sellerio, una volta chiamò «traduttori-sòla». Oppure no: ogni atto creativo, del resto – e almeno questo della traduzione lo si può dire: è un atto creativo – scaturisce da un’inquietudine, alla quale (dovrebbe) risponde(re), no?
La mia riserva di parole stavolta mi è servita tutta. È cospicua, ma non se ne conoscono mai abbastanza: questo è un assioma cartesiano. Tengo inoltre, qui, a sfatare uno strano mito che sembra accompagnare la figura del traduttore: che sia una sorta di sciamano (a volte un negromante, ma io non chiedo mai niente nemmeno agli autori vivi: è ammettere di non aver capito, e insinuare che non si sono spiegati), infuso dal tocco di qualche dio di una scienza e di una verità ignote ai più, che gli permettono di rendere un testo come altri mai. Il traduttore in realtà è un operaio, e il suo un lavoro manuale. Fa quello che il suo padrone (l’autore di turno) gli dice. Specializzato, ma operaio. Ho dovuto ricorrere a certi modi di dire di mio nonno, per esempio. Ho dato al padre di Salinger (in «A Jeromè: con amore e baci») la voce – e, nella mia mente, la densa gestualità – del padre di un mio caro amico, un po’ perché era perfetto per quel ruolo, un po’ in omaggio alla comune passione rivoluzionaria per Thomas Hardy. Ho tenuto conto delle altre opere di Lish (soprattutto il secondo romanzo, Peru, del 1986, per tutto un discorso sul colore verde, e per certe atmosfere d’infanzia, diciamo). Ho ricordato tutti i miei amici ebrei americani, il loro argomentare, le loro idiosincrasie. Il rabbino capo di Huntington Woods, Michigan. Ho attinto, come prescrive Stanislavskij, alla mia «memoria emotiva» (quando ero più giovane sceglievo sempre un personaggio da ogni libro a cui lavoravo, non necessariamente il protagonista, e lo diventavo, nel quotidiano: Proprio come gli attori del «metodo» – cercavo di convincermi).
Non è magia: è il pane quotidiano, e comunque non basta. La scrittura di Lish, anche quando mette da parte la metanarrativa, è molto complessa: somiglia davvero alla «stanza piena di specchi» della quale parla (a p. XIII) Francesco Guglieri nell’introduzione al nostro volume, dove non si fa in tempo a cogliere una immagine / verità stabile che questa si scioglie subito, per contraddirsi, nella immagine / verità successiva. È un flusso, a volte, che non si può che assecondare, al quale non rimane che abbandonarsi. Resistere è pericoloso: è forte come una corrente di risacca. In The Big Chill (1983) di Lawrence Kasdan, Nick (il personaggio di William Hurt) rimprovera Sam (Tom Berenger) di essere sempre «…così analitico! A volte devi lasciare che l’arte… fluisca dentro di te». Questo non significa certo che si traduca limitandosi a seguire il flusso; il gioco di specchi, questo seguire / inseguire le immagini / verità, è l’effetto che alcuni di questi testi devono avere sul lettore – la sensazione di avere tra le mani (non vale per tutti i racconti del libro, è ovvio, ma per molti sì), ed ecco di nuovo l’articolo su Ernaux, «una raccolta di momenti e frammenti che formano un tutto»: parole che «ci attraversano» e, alla fine, ci lasciano qualcosa, e dunque tradurre questi racconti significa riprodurre questo effetto, e insieme la sua conseguenza, questo qualcosa.
Senza essere troppo «analitici»: senza dubbio, alcuni di questi testi un po’ autoreferenziali lo sono. Refrattari, forse o, più correttamente al di là delle nostre comunque limitate possibilità ermeneutiche. È qui che entrano in gioco l’esperienza, la sensibilità linguistica (nemmeno questa è infusa: la si apprende, e dopo va allenata, quotidianamente), e l’intuito (l’unica mia vera dote, secondo la mia insegnante di inglese al liceo). E una revisione puntuale, e in questo caso c’è stata, ma non è sempre così. A volte – non spesso, certo, ma perché negarlo? – si traduce ricorrendo a uno strumento che si colloca a metà tra il rasoio di Occam e la spada di Alessandro Magno davanti al nodo di Gordio (ma senza tagliare niente; sarebbe un residuo, e il residuo è il male, posto che non si riesca a compensarlo): esaurite tutte le opzioni a disposizione, che devono essere plurime, esplorato ogni plausibile doppio senso, individuato e gestito ogni eventuale rinvio intertestuale (palese oppure – quelli più divertenti – occulto) e/o elemento culturo-specifico, in buona coscienza quel che resta dev’essere giusto. Come nella stessa scena di prima, in The Big Chill. Sam interroga Nick sul film che sta guardando: «Cos’è?» «Non lo so». «Di cosa parla?» «Non lo so». Però, concludiamo noi, è così che lo dice. Non è un’ammissione di superficialità. Tutt’altro. Saper adoperare questo strumento (un’altra cosa che si impara, e non scende dal cielo come la manna) vuol dire garantire, per quanto possa farlo un essere umano, o forse proprio perché si tratta di un essere umano e non di Google Translate, una traduzione forse non troppo glamour, magari non esteticamente «bella» ma senz’altro corretta. Perché la bellezza è un altro paio di maniche: di solito viene da sé, e quando vuole lei. O meglio, sei sempre tu che l’hai convinta, ma te ne rendi conto dopo. Al momento, ringrazi e basta.
Avevo paura, inoltre, perché in passato mi ero fatto un’idea, di Lish, quanto meno incompiuta. E nulla fa cambiare parere come la lotta corpo a corpo con un testo che implica il tradurlo. Lo immaginavo, Lish, consapevole delle proprie capacità fino alla presunzione (di qui la difficoltà nel rendere uno dei titoli, [entitled], che dizionario alla mano suggerisce proprio questo: una persona convinta che tutto le sia dovuto). Lish però, leggendo come legge solo chi traduce, non mi è sembrato questo. A volte molto pronto a dare giudizi, certo, come nel caso della poeta in «Come scrivere una poesia» (sul quale torneremo a breve). Lish, o la combinazione dei molti narratori in prima persona di queste storie, è veramente (tornando a citare Guglieri, o meglio Perec attraverso Guglieri) un luogo impossibile da «esaurire», ma (secondo me) judgmental senza esserne entitled no. L’ho capito in un attimo, una riga, uno di quei momenti che in Joyce chiameremmo epifanie: in «A cena con Ozick e Lentricchia» il lettore, per apprezzare il racconto, non ha realmente bisogno di sapere chi siano, Ozick e Lentricchia. E Lish potrebbe avere la presunzione di tacerlo, dando per scontato che il «suo» lettore lo sappia. Ho frequentato abbastanza gli ambienti accademici (e l’editoria) per aspettarmelo, ma lui invece no, lui al lettore lo dice: una romanziera e un critico letterario. A tanti potrà sembrare poca cosa, e chissà se davvero non lo sia, ma per me è un segno di rispetto, se non un atto dovuto, e dunque mai scontato, e quando bisogna restituire la voce di un testo in un altro sistema significante sono dettagli importanti; il lavoro su un testo non è mai finito (per questo in tanti non rileggiamo le nostre traduzioni quando vengono pubblicate), ma fino alla consegna c’è sempre tempo per un ripensamento, per tornare indietro. Piuttosto che a un presuntuoso, ho preferito dunque pensare al negozio che, nello stesso racconto, Lish narratore incontra mentre va al ristorante, che si chiama (il negozio) «GORDON» e che tratta «Giochi di Prestigio, Curiosità, Travestimenti» (p. 253).
La poeta, dicevamo. Una scrittrice mediocre, contro la quale il narratore un po’ se la prende ma in fondo, ammettiamolo, come dargli torto? Era doveroso, qui, resistere alla tentazione di calcare la mano (il testo lo fa già di suo) – ma quell’articolo femminile premesso a un sostantivo che almeno per il mio caro Devoto-Oli (2015) è ancora solo maschile, e che indica pur sempre e comunque la si pensi una forzatura linguistica, proprio per questo si poteva scegliere, e l’ho fatto. Francesco Guccini «non dic[e] più d’esser poeta» dal 1974 («Canzone delle Osterie di Fuori Porta»); due anni dopo gli farà eco l’amico Roberto Vecchioni, lamentandosi che «adesso è giorno di mercato, spuntano a grappoli i poeti / tutte le isole han trovato» («Canzone per Francesco»). Lish non è da meno: «[Il marito della poeta] era un poeta anche lui? Molto probabile. Oggi ci sono tantissimi poeti» (p. 30) [L’inglese ha un verbo bellissimo per questi giudizi così tranchant, espressi però con molto aplomb, e l’aria impassibile: to deadpan]. Se l’atto di definirsi poeta può essere un segno di arroganza (e dev’essere così: il sostantivo ricorre trentuno volte in meno di sette pagine), farlo con una forzatura grammaticale non lo è, in fondo, di più, però magari contribuisce a smascherare questa donna, e con una bizzarra eleganza. Sono sfumature, tuttavia: non è nemmeno questa la sua vera debolezza (e quindi conviene non insistere): essa, la debolezza, è piuttosto non aver voluto, o saputo, scrivendo (ricordate l’atto creativo e l’inquietudine?), guardare negli occhi ciò che le ha messo paura, e farlo proprio (riassumendo le pp. 27-8). La poeta ha preferito darsela a gambe, e il risultato è la banalità.
Proprio quello che non accade, appunto, a Lish narratore nei due racconti che hanno come pre-testo la lunga malattia della moglie Barbara, spentasi nel 1994 per una sclerosi laterale amiotrofica, quella che il testo sceglie di chiamare piuttosto – quante cose edulcora il baseball: Schulz, per tacere di altri, ce lo ha insegnato – «malattia di Lou Gehrig»: il già citato «A cena con Ozick e Lentricchia» e «Buon divertimento, Anna!». Saranno stati, immagino, racconti difficili da scrivere. Dolorosi? Forse sì. Consolatori, magari catartici? Me lo auguro. Doloroso e difficile certo è stato tradurli. Uno dei loro temi è, infatti, il senso di colpa di chi sopravvive alla malattia di una persona cara: quello che accompagna inoltre, nella migliore delle ipotesi, l’umano desiderio di «staccare», prendersi ogni tanto una pausa dal dolore, e nella peggiore, la sensazione di non esserci «stati», per quella persona, come avremmo potuto, voluto e soprattutto dovuto. Lish narratore, qui, trasferisce tutto questo su due oggetti: i pince-nez di Barbara (quelli che, per coerenza con l’assunto, a un certo punto rischiano di ucciderlo) nel primo racconto, la moquette nuova – la parola moquette ricorre diciotto volte in quattro pagine e mezzo – nel secondo. Con ancora maggiore umiltà di Ernaux (e, naturalmente, cadendo in una sorta di contraddizione), Lish narratore riflette su come «quando diciamo certe cose a qualcuno gliele diciamo sempre tutte sbagliate», ma non rinuncia alla scrittura, a guardare negli occhi (a differenza della poeta) ciò che ha messo e mette paura. E se la vecchia moquette assorbiva e nascondeva tutti i segni della malattia di Barbara, sopra quella nuova si vede ogni cosa: «tutto il cascame, tutti i detriti, le scorie incessanti del semplice esistere che ti guardano in faccia e ti accusano». Io qua ho voluto vedere un riferimento alla «oscurità del mero essere» di Jung; anche la versione inglese di Erinnerungen, Träume, Gedanken (1961) usa «mere being», come Lish, e tuttavia il «mero essere» dell’edizione italiana mi sembrava francamente debole, e allora gli ho preferito «semplice esistere», che mette anche – o dovrebbe – più paura. Luciano Bianciardi una volta (non ricordo dove o quando, e forse dovrei ometterlo, ma anche se non l’avesse mai detto avrebbe potuto, perché lo sapeva) disse che tradurre significa bere l’amaro calice fino in fondo, alludendo al fatto che se un lettore può scansare un brano che lo addolora, il traduttore no. Questa è una delle cose più importanti che ho imparato, in trent’anni.
Nel primo di questi due racconti, inoltre, Lish narratore piange. «Lacrime» compare cinque volte in tutta la raccolta (all’università ci davano da mangiare pane e strutturalismo, si sente?), e di queste cinque tre sono qui. Nella raccolta, il primo racconto che ho tradotto è stato «How To Write A Poem», e avrei voluto intitolarlo «Istruzioni per scrivere una poesia», in omaggio a Cortázar. Poi abbiamo optato, coerentemente, per un titolo diverso; pazienza, sarà per un’altra volta. Ma con quelle lacrime sono tornato comunque a una delle pagine per me più belle dello scrittore argentino, le «Istruzioni per piangere» (in Historias de cronopios y de famas, 1962). Per Cortázar (nella traduzione di Flaviarosa Nicoletti Rossini), «lasciando da parte le motivazioni», per piangere (laddove per cantare bisogna dimenticarsi di sé) «occorre fissare l’immaginazione su se stessi» e, come bambini, farlo «con la manica della giacchetta sulla faccia, e preferibilmente in un angolo della stanza».
Per tradurre questi due racconti come meritavano ho dunque fatto ricorso alla memoria emotiva di Stanislavskij, e alle lunghe malattie di persone care che hanno segnato oltre quindici anni della mia vita. Io dico sempre e ci credo davvero che il traduttore, traducendo, debba sparire. Egli, parafrasando Dickens, non ha i dubbi di David Copperfield; già sa di non essere l’eroe di nessuna storia: quel posto è «tenuto da qualcun altro». Quando attinge alla sua memoria emotiva, però, diventa difficile. È per questo che, dopo trent’anni, mi rendo conto di aver cosparso i libri ai quali ho lavorato – sempre senza danneggiare i testi, anzi con l’obiettivo opposto – di una serie di messaggi in codice, che alcuni potrebbero (e chissà se qualcuno di loro mai vorrà) decifrare. C’è un motivo, per esempio, perché lo sfortunato ragazzo egiziano in The Winter Vault di Anne Michaels si chiama Bertuccia, o perché in Parisians di Graham Robb (peraltro mai pubblicato, ma lì sta) la madre di Proust è indicata come «la Maman». Uno di questi messaggi lo svelo qui: le lacrime di Lish narratore (ma «un pianto che non sconfini nelle urla», come prescrive Cortázar) sono anche le mie, il suo senso di colpa è anche il mio, per non avere accudito mio padre come a suo tempo lui aveva accudito me; e anche io, potendo, avrei scelto la moquette nuova proprio per il motivo di cui il personaggio di Anna Kraczyna (che, per dire, nella realtà ha appena firmato per Penguin, con John Hooper, una nuova traduzione delle Avventure di Pinocchio di Collodi) subito si accorge: «per la dannata penitenza che contiene», e per continuare a non perdonarmi.