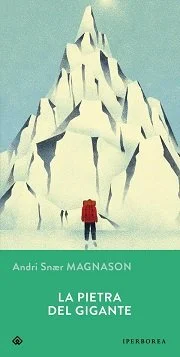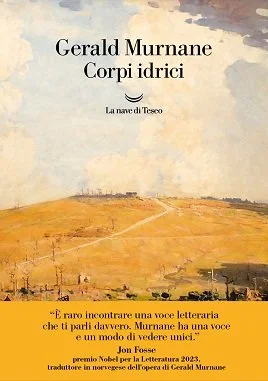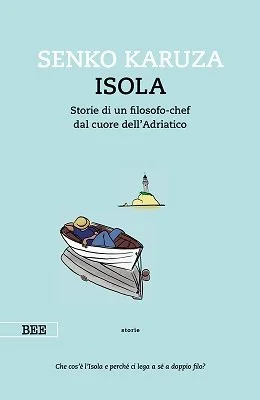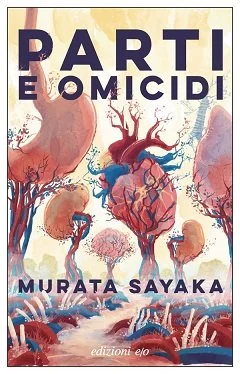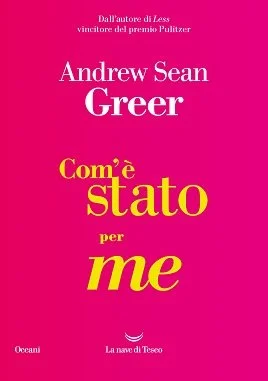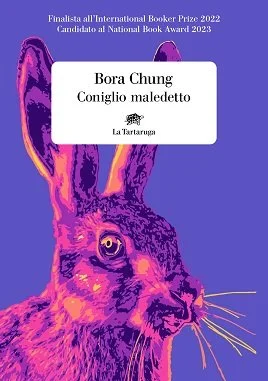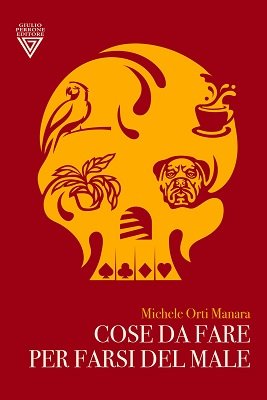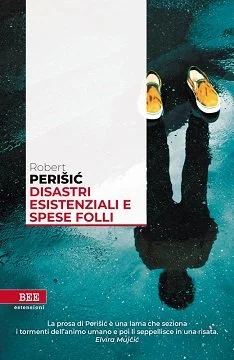di Debora Lambruschini
Dorothy Johnson è probabilmente la più importante autrice donna di opere western, che ha saputo dare al genere una connotazione letteraria e umana ben precisa. Autrice di diciassette libri, numerosissimi racconti e articoli, Dorothy Marie Johnson nasce nel 1905 in Iowa per poi trasferirsi con la famiglia in Montana, a Whitefish: una terra d’adozione cui sarà legata per tutta la vita, nonostante una lunga parentesi a New York City dove lavorerà per quindici anni come publisher e giornalista. Ma il cuore – e la sua identità di autrice – è laggiù, nel Montana. Un ritorno necessario. Qui alternerà la scrittura all’insegnamento – di giornalismo, presso l’università di Missoula – e il legame con la terra e le tradizioni si intrecceranno in modo indissolubile alle pagine, tra romanzi, racconti, saggi e articoli. E qui, a Missoula, morirà stroncata dal morbo di Parkinson nel 1984: con lo spirito che la caratterizzò tutta la vita, farà scrivere sulla lapide un enigmatico “Paid”, a cui sono state date varie interpretazioni.
In Italia il nome di Dorothy Johnson non è mai stato particolarmente noto, ma oggi che Mattioli 1885 porta per la prima volta in libreria L’uomo che uccise Liberty Valance, quattro racconti, tradotti magistralmente da Nicola Manuppelli, molti lettori probabilmente riconosceranno titoli ben noti nell’immaginario del pubblico di film western: tre di queste storie, infatti, sono state trasposte al cinema con grande successo. Personalmente non ho mai amato il genere, di cui pure possiedo mio malgrado una nutrita collezione ereditata da un padre invece grande fan di film western: ma l’impronta che certi scrittori e scrittrici hanno dato al genere è tutta un’altra questione. Penso per esempio a Annie Proulx, a Sam Shepard, al Butcher’s Crossing di John Williams – sì, l’autore di Stoner – , per arrivare fino a Cormac McCarthy e Larry McMurtry, per citare giusto una manciata di quegli autori che hanno reso letterario tutto ciò che è westerners. In questo solco si collocano le storie di Dorothy Johnson, di cui Mattioli porta ora in libreria quattro racconti straordinari: “L’uomo che uccise Liberty Valance” (che dà il titolo alla raccolta), “Un uomo chiamato Cavallo”, “L’albero degli impiccati”, “Una sorella scomparsa”. I primi tre sono diventati, come si accennava, celebri film, ma anche il quarto è un piccolo gioiello da non sottovalutare. Ma che cosa c’è nei racconti western di Johnson da esserle valsi i più prestigiosi riconoscimenti letterari e farla perfino diventare membro onorario della tribù dei Piedi Neri?
Con accuratezza storica e varietà di dettagli Johnson crea un mondo di uomini e donne di frontiera liberandoli di pregiudizi e stereotipi che molto spesso caratterizzano il genere, scavando al cuore delle storie e dei personaggi per restituirli al lettore – tanto di ieri quanto contemporaneo – in tutta la loro complessità; uomini e donne molto spesso duri, come la vita di frontiera richiedeva di essere, ma allo stesso tempo umani, preda di dubbi, paure, fragilità. Duri, ma non invincibili. E, andando contro a buona parte della narrazione western, Johnson dedica lo stesso approfondimento e complessità alla rappresentazione delle tribù indigene e all’incontro/scontro tra bianchi e nativi. A scanso di equivoci: Dorothy Johnson usa il termine “Indians” e, nella traduzione, ricorre quindi la parola “indiani”: così deve essere, non edulcorata, perché quello era il mondo entro cui si muovono i personaggi di queste storie.
Trova spazio sulla pagina anche il punto di vista femminile e delle donne native, di cui un esempio straordinario – che ci auguriamo arrivi presto anche questo nel catalogo Mattioli – è il romanzo Buffalo Women, pubblicato nel ’77 e ancora una volta basato su accurate ricerche e ricostruzione storica ma soprattutto sul desiderio di una rappresentazione non stereotipata o bianco centrica della questione tra nativi e colonizzatori. Johnson, tra l’altro, si muove agilmente tra forme letterarie diverse, calibrando lo sguardo dal racconto alla novella, al romanzo. Ciò che resta costante e che ben si nota in questa raccolta, è l’intreccio calibrato di plot e linguaggio scelto: la lingua è scarna, misurata, i dialoghi ridotti al minimo e ogni parola incisa sulla pagina è quella essenziale a evocare un mondo e le persone che lo popolano, letteraria – anche se forse il termine più idoneo è “artigiana” – ma mai artificiosa. Esempio ideale di che cosa sia una short story, indipendentemente dal genere cui appartiene, i racconti di Johnson prendono forma per sottrazione, a partire da una lingua che è l’unica adatta a raccontare la storia di un vecchio pistolero e il segreto che si porta nella tomba (“L’uomo che uccise Liberty Valance”), un uomo catturato da una tribù e la riconquista progressiva dell’umanità (“Un uomo chiamato Cavallo”), la vita tra euforia e dramma in un campo di cercatori d’oro (“L’albero degli impiccati”), una donna rapita dai nativi quando era ancora una bambina e che fa ritorno dopo quarant’anni dai suoi famigliari divenuti estranei (“Una sorella scomparsa”). Lavorando per sottrazione, plasmando il linguaggio per ridurlo all’essenziale, Johnson – e l’ottimo Manuppelli con lei, nell’aver reso tanto bene lo stile della narrazione – ricorda al lettore il potenziale della short story, con l’intreccio di storia e modo di raccontarla, la ricerca di una voce specifica, l’uso del tempo, degli spazi vuoti, il gusto per una certa sospensione, specie nei finali.
Storie di frontiera, perfettamente collocate nel tempo e nello spazio, ma la portata dei sentimenti che le attraversano arriva con immutata forza fino al lettore contemporaneo, superando distanze geografiche e cronologiche, grazie anche a una scrittura che sa farsi viva, vibrante. Non serve aver vissuto nel Montana di inizio secolo per sentire la polvere, il fango che si secca sugli stivali e la brama di oro dei cercatori, il tormento di segreti che potrebbero portare alla rovina; non serve aver percorso strade dissestate su una diligenza per cogliere il pericolo di un assalto improvviso, la corsa furiosa dei cavalli imbizzarriti, la sete delirante di una donna perduta nel bosco per giorni; come non serve essere stati rapiti da una tribù per addentrarsi nelle gerarchie e nelle usanze dei Crow, dove anche un prigioniero umiliato può lentamente riprendersi la propria umanità.
Di questo incontro/scontro tra bianchi e nativi sono intrise molte pagine delle storie di Johnson e “Una sorella scomparsa”, il racconto che chiude la raccolta è forse uno degli esempi più riusciti, una gemma da scoprire, nella quale riecheggia la celebre vicenda reale di Cynthia Ann Parker.
Bessie, la sorella scomparsa, era stata rapita ancora bambina da una tribù, non conserva alcun ricordo della sua vita tra i bianchi, nella sua famiglia, se non un nome, Mary, quello della sorella maggiore. La sua “liberazione” e il ritorno in famiglia sono accolte con grande commozione e attesa. Ma quella donna di quarant’anni, silenziosa, sfuggente, che dorme sdraiata sul pavimento dell’elegante camera che era stata preparata per il suo ritorno, scruta costantemente fuori dalla finestra e ai piedi indossa semplici mocassini, è ben diversa da quanto si aspettassero.
Margaret avrebbe potuto capire che una donna indiana non fosse in grado di conversare in una lingua civilizzata, ma sua sorella non era indiana. Bessie era bianca, quindi avrebbe dovuto parlare la lingua delle sorelle, la lingua che non sentiva da quando era bambina. (Una sorella scomparsa, p. 181)
In poche righe è condensato un sistema di ignoranza, pregiudizi, razzismo, cui del tutto non si sono ancora fatti i conti che si denota già dal quel dettaglio iniziale di non indicare nemmeno il nome della tribù, a sottolineare la distanza che divide la famiglia dal mondo in cui è cresciuta Bessie. I nativi sono selvaggi, la povera Bessie rapita da bambina è finalmente tornata a casa, dalla sua famiglia, nella civiltà. È sconcertante, quindi, per le zie rendersi conto che quarant’anni di vita nella tribù hanno plasmato una donna ben diversa da quella che si aspettavano e che Bessie non conserva alcuna memoria innata di loro e della società cui apparterrebbe. È necessario perfino un interprete della tribù che possa fare da tramite in quei primi momenti; interprete, naturalmente, che viene trattato con profondo disprezzo, tanto a parole quanto a gesti.
La storia è narrata mediante il punto di vista di un ragazzino di nove anni, figlio del fratello defunto – per mano degli indiani appunto – e che vive nella grande casa delle zie con la madre vedova. Una scelta interessante, che porta il lettore dentro la storia ma soprattutto ne permette una particolare connotazione. Se è vero che l’istintiva opinione del ragazzino nei confronti della gente che è responsabile della morte del padre è inizialmente piuttosto netta – lui, che sognava da grande di vendicare l’uccisione del padre – , la giovane età, un certo grado di innocenza e, probabilmente, una sensibilità innata, gli permettono di osservare la storia che si svolge davanti ai propri occhi con curiosità ma anche libero da condizionamenti e preconcetti. Ed è lui, infatti, a comprendere davvero quella zia ritrovata, bizzarra e taciturna, e il grande torto che le viene fatto nel pretendere che quel ritorno sia da chiamarsi libertà.
Bessie aveva davvero vissuto un’esperienza terribile, ma non del tipo che le sorelle avevano in mente. Le sue sofferenze, quando arrivò, provenivano dall’essere stata strappata alla propria gente, gli indiani, e consegnata a estranei. Non era stata liberata. Era stata fatta prigioniera. (Una sorella scomparsa, p. 174)
Solo il ragazzino e la sorella maggiore Mary comprendono e accettano Bessie, la donna che è diventata, mentre le zie dall’iniziale felicità per la sorella ritrovata sono presto passate alla costernazione e all’indifferenza, attente però a proteggersi dalla curiosità dei vicini.
In poche pagine Johnson costruisce un racconto retta da una storia sotterranea importante quanto quella in superficie, e ancora una volta coglie perfettamente le complessità svincolate da stereotipi nel rapporto tra bianchi e nativi per restituire al lettore una differente chiave di lettura, cambiarne le aspettative. Il finale lascia un minimo grado di vaghezza e dà così spazio al lettore, cui spetta colmare i vuoti della narrazione, ripercorrerne i fili.
Con “Un uomo chiamato Cavallo” forse osa ancora di più, raccontando la cattura e la prigionia di un giovane di buona famiglia che, partito dal New England in cerca di avventure a Ovest, cade presto nelle mani di una tribù Crow: fatto prigioniero, spogliato della propria umanità, è il racconto anche ironico a tratti di due mondi che si incontrano con violenza ma di come in qualche modo sia anche possibile costruire un ponte dall’uno all’altro. Il ragazzo attraversa tutti gli stadi della prigionia, ma nel tempo trascorso con la tribù ne apprende anche i costumi e il suo ruolo muta via via che dimostra il proprio valore, finendo per ritagliarsi una posizione ben diversa da quella iniziale. E, soprattutto, scegliendo di prolungare la sua permanenza nella tribù quando questa si fa necessaria. Farà forse ritorno a “casa”, alla società in cui è nato, ma di quell’esperienza non potrà che raccontare una minima parte, perché molto di quanto ha vissuto non sarebbe compreso. Una distanza, uno scarto, che probabilmente spiega quelle che ci sono tra bianchi e nativi, e la difficile comprensione macchiata di violenza, pregiudizio, rabbia.
Si rese conto che c’erano molte cose di cui non avrebbe parlato una volta tornato a casa.
(Un uomo chiamato cavallo, p. 48)
Il rapporto con le popolazioni native non è invece oggetto d’attenzione nei due racconti iniziali, che della realtà di frontiera raccontano un aspetto differente, tra cercatori d’oro, pistoleri, banditi, gente in cerca di una nuova vita.
«Bart Barricune è stato mio amico per più di trent’anni». Non poteva dirgli: Era mio nemico; era la mia coscienza; mi ha reso ciò che sono. (L’uomo che uccide Liberty Valance, p. 10)
“L’uomo che uccise Liberty Valance” è uno dei più celebri racconti, da cui nel 1962 John Ford realizzò un famoso film con John Wayne, John Steward e Vera Miles, e anche in questo caso la narrazione di Johnson è stratificata, complessa e molto interessante. Una storia di segreti, amore e rinuncia, desiderio di vendetta e omissioni, al cui centro ci sono due uomini, la donna che amano e un fuorilegge di cui vendicarsi: Ransome Foster, come tanti altri arrivato a Ovest in cerca di fortuna, si imbatte nel furfante Liberty Valance che lo deruba e lo lascia, malconcio, nel deserto; è Bert Barricune a trovarlo, in fin di vita, e salvarlo. Abile pistolero ma un uomo che, si dirà al suo funerale, «non era stato nessuno»; Barricune trascina Foster fuori dal deserto, restituendolo alla vita.
«Dunque ho ucciso Liberty Valance».
Fu la cosa più vicina a un grazie che osò mai dire. E fu allora che Bert Barricune iniziò a essere la sua coscienza, la sua nemesi, il nemico di una vita e l’uomo che lo rese grande.
(L’uomo che uccide Liberty Valance, p. 27)
Attraverso i due piani temporali della storia, per mezzo di dialoghi fulminanti e scene tesissime, Johnson costruisce la complessità del rapporto tra i due, complicato dal debito e dal segreto di cui entrambi si fanno tacitamente custodi. È una storia tesa tra verità e menzogna, che parla di rinuncia, di amore e di quanto la leggenda talvolta sia più importante della realtà.
Di ampio respiro, da farne una novella compiuta, è “L’albero degli impiccati”, la più lunga di queste storie, interpretata da Gary Cooper nella trasposizione cinematografica del ’59. È una narrazione più lunga, dunque, ma ha in sé tutta l’essenza del racconto, quella certa postura ellittica, con ambiguità e una storia sotterranea, il gusto per il frammento.
Mi chiedo, pensò Joe Frail, se quello è il ramo a cui verrò appeso. Mi chiedo chi sia l’uomo che ucciderò per meritare la corda. (L’albero degli impiccati, p. 52)
Sono i primi pensieri di Joe Frail lungo la strada che lo sta portando al campo di cercatori d’oro da qualche parte in Montana. Uomo dall’oscuro passato, è tormentato dal rimorso e dalla “maledizione” che sente incombere su di lui a seguito di un omicidio e dal senso di colpa per la perdita del migliore amico. Trincerato dietro la propria durezza, diviene medico della zona, temuto e rispettato.
Doc Frail era arrogante in modo silenzioso ed era l’uomo più solo dell’intero campo. Apparteneva all’aristocrazia di Skull Creek, a quella categoria di persone indispensabili come gli avvocati, il banchiere, il direttore dell’ufficio del saggio dei metalli preziosi e i proprietari di saloon. Ma questi uomini ostentavano rettitudine e nascondevano i loro revolver, come richiedeva la decenza. Doc Frail portava le sue due pistole in bella vista nelle loro fondine. (L’albero degli impiccati, p. 70)
È un microcosmo di cercatori d’oro, uomini e donne che fingono di essere privi di passato, avventurieri e furfanti, gente perbene o che quantomeno ne ha l’aria: una realtà che Johnson tratteggia abilmente, permeandola di vita, dettagli, con una scrittura che sa farsi materia. Una storia densa e articolata, in cui si intrecciano il discorso sulla perdita, il desiderio e l’orgoglio, la durezza e la fragilità. Una realtà in cui le parole infiammano gli animi e possono scatenare la violenza. E dove una donna, per tutti fragile, indifesa, inadatta perfino, può diventare arma e salvezza.
Il lettore si troverò a leggere una ricchezza e complessità variegata, una narrazione articolata e piacevolissima di un’autrice il cui nome è rimasto troppo a lungo sommerso, ma anche di un genere che come capita talvolta con le cose popolari è stato bistrattato ma in cui non mancano esempi magistrali.