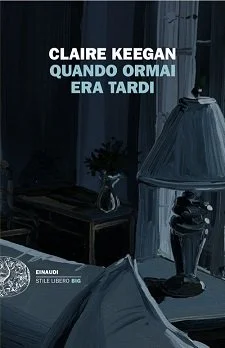Titolo: Quando ormai era tardi
Autore:Claire Keegan
Editore: Einaudi
Traduzione: Monica Pareschi
pp. 96 Euro 13,00
di Debora Lambrischini
«Elegance is saying just enough. And I do believe that the reader completes the story»
Parlava così Claire Keegan in un’intervista rilasciata al Guardian lo scorso anno, in occasione dell’uscita di So Late in the Day. Stories of Women and Men: poche parole, anche in questo caso, che arrivano dritte al punto della questione e danno un’idea piuttosto chiara della postura autoriale di Keegan, tra le voci più acclamate della narrativa irlandese contemporanea. È alla produzione breve che la scrittura di Keegan si lega indissolubilmente, il racconto o la novella quali dimensioni a lei più congeniali. A portare per primo i suoi testi in Italia fu diversi anni fa l’editore Neri Pozza, con due raccolte di racconti che oggi sono purtroppo introvabili: Dove l’acqua è più profonda nel 2010 (Antarctica, 1999) e nel 2009 Nei campi azzurri (Walk the blue fields, 2007), entrambe tradotte da Massimiliano Morini. Tuttavia, nel nostro paese, il successo di Keegan è cosa più recente, con la pubblicazione per Einaudi di due novelle magistrali, Un’estate (Foster, 2010) e Piccole cose da nulla (Small Things Like This, 2021) entrambe tradotte da Monica Pareschi e uscite tra il 2022 e il 2023. La traduzione di Morini era inappuntabile dal punto di vista formale – e sarebbe davvero un gran regalo per i lettori che entrambe le raccolte Neri Pozza fossero nuovamente disponibili – ma l’incontro con Pareschi è un connubio perfetto, fatto tanto di tecnica che di connessione emotiva e capacità profonda di comprendersi nelle sfumature del testo, nell’apparato di immagini, simboli, rimandi ed echi letterari. È ancora Pareschi, dunque, a dare voce all’ultima raccolta della scrittrice irlandese, Quando ormai era tardi (So Late in the Day. Stories of Women and Men): la raccolta è uscita a fine anno per Einaudi e contiene tre racconti originariamente scritti in tre momenti differenti e qui riuniti in ordine cronologico inverso, dal più recente che dà il titolo al volume, passando per “Una morte lenta e dolorosa” del 2007 e “Antartide” del 1999. Tre storie, quindi, che coprono un arco temporale molto ampio, indipendenti, ma che dialogano tra loro legate dal fil rouge della riflessione sui rapporti umani che anche in questo caso Keegan indaga con lucidità, penetrando anche negli angoli più oscuri e, tutte e tre, avvinte da un’atmosfera di inquieto disincanto. È anche la scrittura a tenere insieme questa breve raccolta, la voce autoriale di Keegan: la narrazione è tesa e misurata, fa ampio uso dell’ellissi e poggia su una generale economia descrittiva che si fonde alle immagini, ai simboli, agli echi della tradizione letteraria. Ogni storia è fatta anche dei suoi spazi bianchi perché, come sosteneva appunto l’autrice nell’intervista citata in apertura, è compito del lettore completarla trovando da sé le proprie risposte. Un’idea di libertà e interpretazione che è propria già della prosa di Keegan, concentrata sulla storia e non sul messaggio da trasmettere. È naturale, dunque, che la forma breve sia quella a lei più congeniale e la cura che dedica alla parola si evince anche da una bibliografia che gli standard editoriali giudicherebbero scarna, con “soli” cinque libri pubblicati dall’esordio nel 1999 a oggi, un’economia di parole che rimarca l’artigianalità della scrittura.
È possibile dunque osservare nel suo quadro complessivo la produzione letteraria di Keegan e notare, nelle varie sfumature della narrazione e nelle evoluzioni della scrittura, una serie di riferimenti e ricorrenze, tematiche e formali. La sua scrittura ha il passo della tradizione irlandese del Novecento, come sottolineava anche la sua traduttrice Monica Pareschi nel corso di un’intervista che le feci lo scorso anno, vicina alle narrazioni di Edna O’Brien, John McGahern, Joyce ma, a mio avviso, in qualche modo anche alla generazione di scrittrici irlandesi contemporanee da Sally Rooney a Naoise Dolan, passando per Eimear McBride, Anna Burns e soprattutto i racconti di Claire-Louise Bennet, pur nelle differenze peculiari di ognuna di loro. C’è dunque nei racconti di Keegan l’eco della letteratura su cui si è formata più o meno direttamente attraverso immagini e citazioni, l’urgenza di raccontare le storture dell’ambiente culturale e sociale entro cui si sviluppano, c’è il discorso di classe, diversi gradi di alienazione e solitudine che ricorrono nelle storie e una tensione costante che pur non sfociando spesso in aperta violenza, anzi proprio per questo, si insinua sottopelle.
I protagonisti delle narrazioni di Keegan sono uomini e donne qualunque, alle prese con un quotidiano che può essere alienante, solitario, teso tra ideale e realtà. Di queste vite l’autrice ci restituisce qualche istante, una porzione piuttosto limitata nel suo dispiego temporale ma profondamente incisiva, costellata di epifanie minime, piccoli gesti, drammi.
Uno dei suoi testi più acclamati, Piccole cose da nulla, è tutto concentrato nella settimana prima di Natale: tanto basta a Keegan nello spazio di meno di un centinaio di pagine per affrontare tematiche profonde e complesse, tratteggiare con poche pennellate mirate uno spaccato dell’Irlanda rurale degli anni Ottanta. A discapito del titolo è la storia di scelte fondamentali che cambiano una vita – più d’una in realtà – ma anche una riflessione profonda su quanto decidiamo di non vedere per proteggere noi stessi e l’equilibrio delle nostre vite, sull’omertà cui è facile finire invischiati per convenienza, quieto vivere, necessità. Un giorno uguale all’altro. Finché non è più possibile fare finta di niente e un gesto, tutt’altro che una “piccola cosa da nulla” ricorda al protagonista quanto la solidarietà possa fare invece la differenza e cambiare il corso di una vita, anche se questo significa mettersi contro le istituzioni religiose, attirarsi il malcontento della propria famiglia, andare incontro a sfide che rischiano di gettare in crisi un’esistenza ordinaria.
[…] si ritrovò a domandarsi che senso aveva essere vivi se non ci si aiutava l’un l’altro. Era possibile tirare avanti per anni, decenni, una vita intera senza avere per una volta il coraggio di andare contro le cose com’erano e continuare a dirsi cristiani, a guardarsi allo specchio? (Piccole cose da nulla, p. 89)
È una novella piuttosto breve, dunque, ma che resta a lungo nella memoria del lettore, per l’incanto della scrittura e la potenza delle riflessioni che porta con sé: possiamo davvero considerarci brave persone se viviamo una vita onesta ma scegliamo di non vedere le ingiustizie intorno a noi? Quali sopraffazioni decidiamo di ignorare? Anche in questo caso Keegan costruisce una narrazione in cui coinvolgere direttamente il lettore, lasciando gli opportuni spazi bianchi della narrazione e un finale aperto, concentrando la storia su quei piccoli momenti decisivi, tra presente e passato, in un arco temporale circoscritto.
Lievemente più disteso il tempo di Un’estate, con la storia che si sviluppa appunto entro il tempo di una stagione, quella necessaria alla piccola protagonista a comprendere il significato di cura, amore, gentilezza. Un’estate è un apprendistato all’affetto dove sono i piccoli gesti a modificare profondamente le cose. La protagonista è una bambina di nove anni, cresciuta in una famiglia affollata, povera, per lo più ignorata; viene mandata a trascorrere l’estate presso la fattoria di certi parenti della madre, un uomo e una donna che hanno perso un figlio molti anni prima. Una novella scarna di parole e dialoghi che si compie magistralmente mediante quei piccoli gesti entro cui è racchiusa ogni cosa: l’estraneità, l’affetto istintivo, la ritrosia, il dolore sepolto ma mai superato, la perdita, la scoperta dell’affetto.
Kinsella mi prende per mano. Allora mi rendo conto che mio padre non l’ha mai fatto, nemmeno una volta, e una parte di me vorrebbe che Kinsella mi lasciasse andare, così non sarei costretta a provare niente di simile. È una brutta sensazione, ma andando avanti comincio ad abituarmi alla differenza tra la mia vita a casa e quella che ho qui, e la accetto. (Un’estate, p. 37)
Da questa storia – come da Piccole cose da nulla – è stato anche tratto un bellissimo film, The Quiet Girl, per la regia di Colm Bairéad che ne ha saputo rievocare i silenzi, gli spazi sospesi della narrazione, il punto di vista della giovane protagonista, le atmosfere e l’intensità. Non era affatto semplice, ma questo film è un gioiello, al pari della novella di Keegan e la profondità di quello che racchiude entro così poche pagine. Anche in questo caso ciò che lo sguardo dell’autrice inquadra è solo una parte delle vite dei personaggi, quel «moment of truth» che fa il racconto, costellato talvolta di piccole fondamentali epifanie, ma che di lì a poco si appresta a sfumare, togliendo tutto il superfluo, dosando le parole con garbo e attenzione, aprendo le porte al lettore.
I tre racconti recentemente pubblicati da Einaudi nella raccolta Quando ormai era tardi portano in loro un’inquietudine più esplicita delle due novelle poc’anzi citate, la scrittura maggiormente tesa, lo sguardo disincantato. I rapporti umani sono indagati nei loro angoli più bui, la violenza latente pare pronta a esplodere, poco conta se sulla scena o appena fuori campo. Storie indipendenti ma accomunate dalla rappresentazione di una mascolinità negativa, mischiata al patriarcato, alla misoginia, a un costante desiderio di prevaricazione sul femminile, emotivo o fisico. L’uso peculiare del linguaggio nelle narrazioni di Keegan tra immagini e piccoli dettagli disvela nella rilettura tutto il potenziale e il sostrato di rimandi, epifanie, particolari sottesi, forte anche in questo della lezione dei classici della narrativa breve otto-novecentesca. Ecco dunque che una lettura veloce della storia eponima di questa più recente raccolta mostra la malinconia per la fine di un amore; il secondo racconto, “Una morte lenta e dolorosa”, la quiete del ritiro di una scrittrice disturbata da un vecchio professore antipatico; il terzo e ultimo racconto, “Antartide”, le insidie di una relazione extraconiugale. Ma lo stile piano non deve trarre in inganno: dietro ogni parola, ogni omissione, ogni dettaglio in apparenza minimo, c’è un mondo di riferimenti, simboli, particolari importanti. È interessante che nel primo racconto, “Quando ormai era tardi”, Keegan scelga il punto di vista del protagonista della storia, Cathal, con il quale in primo momento siamo portati a empatizzare ma che nel giro di una manciata di paragrafi si rivela un uomo meschino, incapace di reale affetto per la compagna, di cura, di generosità. La storia si scopre in un viaggio a ritroso ed ecco che tutti i pezzi che l’hanno portato a quella solitudine rivelano la misoginia dell’uomo.
«È solo che non immaginavo sarebbe stato così, tutto qua, - aveva detto lui. – Pensavo solo al fatto che saresti stata qui, che avrei cenato con te. Forse è solo una dose eccessiva di realtà».
(“Quando ormai era tardi”, p. 24)
Quella «dose eccessiva di realtà» è la vita, lo spazio da dare all’altro, i suoi bisogni, i gesti dell’affetto. E dunque di fronte alla troppa realtà, per Cathal resta soltanto l’ingombro delle cose della donna che dice di amare, le stravaganze, le differenze che non si completano ma si fanno distanza. Mentre la relazione diventa più seria da un punto di vista formale, i sentimenti non vanno di pari passo ed è come se in fondo non fossero altro che convenzioni sociali da cui non si è disposti a staccarsi.
Quelle stesse convenzioni, forse, che spingono la donna del racconto finale, Antartide, a restare dentro il ruolo che ci si aspetta da lei, cercando però altrove la passione che manca nella sua vita:
Ogni volta che la donna felicemente sposata si allontanava da casa, si chiedeva come sarebbe stato andare a letto con un altro uomo. (“Antartide”, incipit, p. 63)
Con la scusa degli acquisti per Natale la protagonista si allontana per qualche giorno, decisa a vivere una passione che nel suo quotidiano ha perduto. La seguiamo al suo arrivo in città, nell’elegante camera d’albergo che ha prenotato, mentre si prepara con cura per uscire alla ricerca di un amante sconosciuto. E quando dunque lo troverà al bancone di un bar, tra fiumi di alcol, non vorrà cogliere i tanti campanelli d’allarme che a noi lettori – soprattutto di oggi – risuoneranno invece potenti. Ciò che sembra dirci Keegan, con questa storia amara e ironica insieme, è che il mondo non perdona una donna che non rispetta le regole.
Il ruolo di una donna e, soprattutto, la delegittimizzazione del suo lavoro, è al centro di “Una morte lenta e dolorosa”, in cui Keegan sceglie il punto di vista di una scrittrice senza nome – anche questo un dettaglio importante – che soggiorna per un periodo nella casa dove Heinrich Böll scrisse alcune delle sue opere e riconvertita in residenza per artisti. Ma il soggiorno che dovrebbe fornirle la pace e l’ispirazione necessaria alla scrittura, è disturbato da uno sgarbato vecchio professore di letteratura tedesca che, si scopre tra le righe, non nutre la minima stima per la scrittura di quell’estranea che si insedia senza tante cerimonie nella casa di un autore della levatura di Böll. Nei modi sempre più apertamente sgarbati dell’uomo, nelle sue frasi spezzate, nel disprezzo malcelato, Keegan sottende una riflessione su un tema che ha radici antiche ma che è tutt’altro che risolto, ossia la legittimazione del lavoro femminile, dell’intelletto e del talento letterario. La donna rivendica il proprio ruolo di scrittrice, finendo anche per usare quell’esperienza, e già il suo soggiorno in quelle stanze rimarca l’esigenza di uno spazio da reclamare per sé; l’uomo, dunque, è archetipo della quotidianità che incombe sul lavoro intellettuale femminile, le esigenze da assecondare, il brusio di sottofondo che toglie concentrazione e il tentativo di delegittimarne il ruolo.
La prevaricazione maschile, più ancora del discorso sulle relazioni e i rapporti umani, dunque, è l’elemento che lega le tre storie di Quando ormai era tardi, che pur scritte a una certa distanza temporale restano ancora attuali e interessanti da leggersi nella particolare realtà contingente. La violenza di genere si compie qui tanto nei gesti che nelle parole, a riprova di un fenomeno radicato, culturale, e verso il quale continua ad avere un peso significativo la colpevolizzazione delle vittime, il femminile da sminuire, tentare di mettere a tacere. È una violenza verbale, intellettuale, fisica, che porta con sé un retaggio patriarcale da cui è difficile liberarsi davvero ma che la sensibilità contemporanea pare almeno riconoscere.
Ecco, dunque, che le narrazioni di Claire Keegan si dispiegano nello spazio di poche pagine ma in uno sviluppo in profondità difficile da dimenticare. Sono racconti magistrali, piccole cose tutt’altro che da nulla.