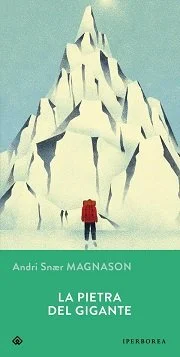Titolo: La pietra del gigante
Autore:Andri Snær Magnason
Editore: Iperborea
Traduzione: Silvia Cosimini
pp. 160 Euro 17,00
di Debora Lambruschini
Forse per ironia della sorte, quando il mondo alla fine è crollato davvero non è stato per una bomba o un virus, ma per una parola, e principalmente per causa mia.
Per questo sono venuto qui: voglio trovare la Parola. E da questa Parola voglio creare un mondo nuovo. (“Dormi, amore mio”, p. 40)
La pietra del gigante, la raccolta di racconti del narratore islandese Andri Snær Magnason appena pubblicata da Iperborea nella traduzione – dall’islandese – di Silvia Cosimini, è un volume piuttosto contenuto nel numero di pagine e racconti inclusi, ma che riesce a racchiudere numerose suggestioni. Ho scelto di partire dalle parole, quelle che mancano al protagonista del racconto “Dormi, amore mio”, quella di cui si mette in cerca e quelle che non possiamo comprendere, nella discrepanza tra testo originale e traduzione. Ho accennato al fatto che Cosimini traduca dall’islandese e non in una versione filtrata da un’altra lingua di passaggio, per esempio l’inglese, come avviene in diversi casi. È un dettaglio importante, a mio avviso, su cui forse non ci si sofferma in modo particolare ma che anche alla luce di quel racconto, il secondo della raccolta, mi pare invece rilevante: perché La pietra del gigante è una raccolta coesa in cui i luoghi, la tradizione, la leggenda e, di conseguenza, la lingua, si intrecciano per dare forma al mondo della narrazione. Ma anche perché su una lingua a me così lontana e impenetrabile, viene istintivo soffermarmi e ragionare appunto sulla voce dell’autore di cui non posso aver coscienza diretta, su che cosa possa significare trasporre un universo linguistico e letterario tanto distante nella lingua italiana, su cosa si perde e cosa arricchisce invece la narrazione. La riflessione sulla lingua, sullo scarto tra originale e traduzione, scatena anche altre considerazioni, a partire dal mistero di una cultura di cui fuori dall’ambito specialistico non abbiamo molta conoscenza, la consapevolezza di un mondo culturale che è per lo più anglocentrico e di quello che tale visione comporta in termini di ricezione, perdita, superficialità. L’Islanda è una terra sconosciuta ai più, al pari della sua cultura e delle sue tradizioni, e della quale ci costruiamo stereotipi basati su una conoscenza appunto superficiale, perlopiù ancorata al passato, quando non al mito. Della straordinaria ricchezza e varietà di questa cultura ne abbiamo oggi un accesso anche grazie all’opera di divulgazione dello studioso e scrittore italiano Roberto Luigi Pagani e al fondamentale lavoro della casa editrice Iperborea, impegnata nel portare nel nostro Paese le voci del Nord tra cui autori e autrici d’Islanda, per mezzo di traduttori preparatissimi come appunto Cosimini. Per superare certi stereotipi e preconcetti, dunque, è anche importante operare una certa selezione nelle proposte editoriali e il caso di Andri Snær Magnason è sicuramente una scelta oculata: la conoscenza del territorio, dall’ambiente alla società, è ben salda ma più che sul mito e sul folklore l’autore punta lo sguardo sulla realtà contemporanea, dagli anni Ottanta ad oggi; la realtà in cui sono calati è fatta di paesaggi e luoghi a noi molto distanti, ma i sentimenti, le dinamiche relazionali, i sogni e le frustrazioni sono ben riconoscibili.
Non voglio affatto dire che il lettore debba ritrovare sé stesso in quello che legge, anzi, è proprio una delle cose che meno mi interessano e che secondo me non dovremmo inseguire: intendo dire, invece, che l’Islanda non è solo quella del mito, terra ancestrale e fissata in un tempo remoto, ma è anche e soprattutto questo oggi, una realtà stratificata, contraddittoria, in cui una natura tanto spettacolare – e ostile, a tratti – è stata spesso trascurata e sfruttata, dove le conseguenze della crisi climatica sono particolarmente evidenti; una società fatta di persone che si interrogano su sé stesse, sulla discrepanza tra la vita immaginata da giovani e quello che è diventata, con peculiarità naturalmente date dal luogo, dalle scelte politiche, dal filtro con cui l’autore sceglie di osservare le cose.
Narratore, poeta, drammaturgo e attivista ambientale, Magnason pone sempre al centro delle sue riflessioni la crisi climatica e qualche anno fa è stato protagonista di un gesto dal forte impatto simbolico: con la sua “Lettera al futuro”, una targa posta sul ghiacciaio Okjokull, il primo in Islanda a essere dichiarato morto, ha sollevato una questione quantomai urgente e che ci riguarda tutti da vicino.
In Italia Iperborea ha portato quindi le sue opere più legate a questo filone, con Il tempo e l’acqua, testo ibrido etichettabile come saggistica narrativa, e La storia del pianeta blu, una “favola ecologica” per ragazzi; La pietra del gigante è una raccolta più variegata dal punto di vista tematico, ma la componente ambientale è senz’altro presente in modo importante e si lega ad altre questioni che ruotano intorno alla parola crisi: la crisi dell’età adulta, delle relazioni, la crisi che nasce dalla difformità tra ciò che immaginavamo sarebbe stata la vita e quello che invece è, la crisi sociale e il profondissimo divario economico e quella ambientale naturalmente.
Due questioni, quindi, mi paiono particolarmente interessanti, e sono appunto la frattura tra il sogno e la realtà della vita adulta e il divario economico delle nostre società.
E così eravamo in viaggio per Legoland con i bambini. Loro erano troppo piccoli per capire dove stavamo andando, ma in effetti nemmeno noi sapevamo perché lo facessimo. Doveva avere un valore simbolico visitare la capitale dell’infanzia proprio quando la vita ti si rovescia addosso come un macigno – anche se forse non è la cosa più giusta da dire quando è appena morto qualcuno. (“Legoland”, p. 55)
“Legoland” è uno dei racconti più interessanti e stratificati della raccolta, nel quale sono condensati moltissimi spunti di riflessione. La narrazione in prima persona e il punto di vista del protagonista, un uomo di trent’anni circa che sta attraversando un momento di profonda crisi personale, guidano il lettore dentro una storia che si sviluppa – come tipico di questa raccolta – su piani temporali diversi, intervallata da spazi bianchi che segnano i confini della narrazione e che raccontano sentimenti complessi. Il viaggio con la famiglia e alcuni amici verso Legoland, agognata meta dell’infanzia, è ora caricato di emozioni difficili da elaborare e che forse proprio attraverso quei piccoli mattoncini trovano una via di fuga e una chiarificazione. Nella stanza ricolma di tutti i pezzi prodotti da Lego, quella sognata durante l’infanzia, mattone dopo mattone il protagonista dà corpo alle proprie emozioni, ai sentimenti complessi che prendono ora la forma di una scatola nera, in quel mare di colore tra cui scegliere. È la scatola nera del lutto da elaborare, delle scelte prese e da cui ormai non si torna indietro, della paura del futuro, delle ambizioni di scrittura e delle responsabilità.
«Forse non volevo diventare adulto», sono le parole che il protagonista non riesce a esprimere ad alta voce ma che permeano tutta la sua esperienza e che si legano anche al suo essere padre, alla vita ordinata che si è costruito, alle scelte prese, alle rinunce, alle porte delle possibilità «in parte solo accostate e in parte chiuse per sempre». La paternità cambia ogni cosa per il protagonista, rallenta il ritmo della vita nel tentativo di essere prudente, con il fisico che sembra aver «sviluppato anticorpi contro l’adrenalina» per evitare il pericolo, per essere figura presente nella vita del figlio. Il viaggio arriva in un momento particolare della vita di tutti loro, si lega al ricordo, alla perdita di un amico, alle difficoltà di venire a patti con la vita adulta.
Così adesso stavamo andando a Legoland per distrarci, ma quel posto, che avrebbe dovuto essere divertente, mi riempiva di nostalgia per gli anni dell’infanzia e per l’innocenza che non sarebbe più tornata, e con noi c’era l’ombra di una persona che se n’era andata per sempre. (“Legoland”, p. 64)
Magnason ci conduce nei meandri della nostalgia, in quella crepa profonda che crea la maturità e che per molti dei protagonisti di queste storie significa confrontarsi con la frustrazione, con la disillusione e la rabbia verso una società impregnata di capitalismo e smania di ricchezza in cui per affermarsi pare necessario prevaricare gli altri.
Ricorre spesso in queste storie quindi la riflessione sulla ricchezza e, di conseguenza, sul divario tra vite fatte di un quotidiano ordinario e altre impregnate di soldi, potere, possibilità sempre più estreme. Un estremo raccontato in “Wild Boys”, protagonisti un gruppo di amici e uomini d’affari che hanno «superato qualsiasi limite in fatto di lusso ed eccentricità»: jet privati, star della musica ingaggiate per un concerto privato, bottiglie costose e abiti di lusso a rappresentare uno status conquistato con l’ossessione per il denaro e il potere che ne deriva. Un racconto in cui si intrecciano spunti diversi, dalla bramosia del denaro, alla distanza sempre più netta dalla realtà ordinaria, dalle relazioni e i ruoli da interpretare al discorso anche su rivalsa e desiderio di emanciparsi dalle condizioni di partenza. Filtriamo la storia attraverso lo sguardo della moglie di uno dei wild boys, ai margini del gruppo delle “vedove bianche” come si auto definiscono per il tempo che passano da sole mentre i mariti sono impegnati a far soldi. Un po’ outsider rispetto al gruppo, ha mantenuto il proprio lavoro di insegnante ed è anche questo uno spunto interessante su che cosa dica di noi la nostra professione, quanto il lavoro si intrecci ad altre questioni oltre il dato economico e il sostentamento, quanto per una donna sia fondamentale mantenere la propria autonomia, ma anche la stortura di una società come quella attuale in cui il valore della professione e perfino delle persone pare legarsi sempre più al potere economico.
Noi e loro, le vite ordinarie e quelle dell’1% della popolazione, è un tema che si rincorre quindi in questi racconti e si interseca al discorso ambientale, alla riflessione sui rapporti e la natura umana, ai luoghi e alla crisi. E che, in qualche caso, porta ad azioni impreviste, di cui non vediamo le dirette conseguenze ma tutto ciò che ha portato fino a quel decisivo momento. “La pietra del gigante”, il racconto che dà il titolo alla raccolta tutta, è quindi una storia in cui Magnason gioca con il tempo: non solo la narrazione segue binari differenti, tra presente e passato, ma il tempo appare malleabile. Materia duttile, dalle molteplici implicazioni e possibilità che mi ha richiamato alla mente certe narrazioni di Daina Opolskaitè (avevo scritto qui del suo Le piramidi di giorni, anche questo nel catalogo Iperborea), riflessioni e resa differente ma una comune concezione circa la malleabilità del tempo. Mentre la traiettoria della pietra si compie, Magnason attraversa i momenti che hanno portato il protagonista proprio lì, a scagliare un sasso contro la macchina al cui interno ci sono il cugino e la moglie e un’azione da cui non si tornerà più indietro, a differenza della narrazione che invece segue un filo cronologico non lineare. In quella pietra l’accumulo di tensione, frustrazioni e disagio del protagonista di fronte a un divario sempre più insopportabile tra ricchi e poveri che è anche il ritratto degli aspetti più problematici delle nostre società capitalistiche.
Avevo progettato case di ogni tipo – ville indipendenti, condomini, ville a schiera – e sapevo bene che non tutti avevano le stesse possibilità, che c’erano disuguaglianze nette nel tessuto sociale; ma quella era la prima volta che progettavo case così diverse per lo stesso committente. Mi sentivo un ladro.
(“La pietra del gigante”, p. 108)
E forse è necessario rendersi conto, oggi più che mai, delle scelte che compiamo ogni giorno e dell’impatto che hanno sugli altri e sul nostro pianeta. La consapevolezza con cui a un certo punto il protagonista guarda alla propria vita e al percorso che l’ha condotto a quel momento è una riflessione amara ma molto lucida delle derive delle nostre società, che si applica tanto al mondo reale quanto a quello dei social.
Ecco l’ideologia. Il cittadino deve essere un consumatore, deve essere in debito con le banche, mandare avanti il sistema economico, dimenticare la qualità e dare profitti a un piccolo pugno di ricchi. Ecco lo spirito dei tempi. La totale insensatezza. (“La pietra del gigante”, p. 111)
L’Islanda di Maganson, dunque, è ben lontana dal mito e dal folklore, ma è una realtà complessa e contraddittoria, e i suoi racconti sono spietati, tesi e illuminati da squarci improvvisi. Storie lontane, vicinissime.