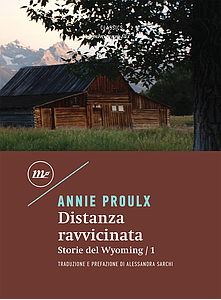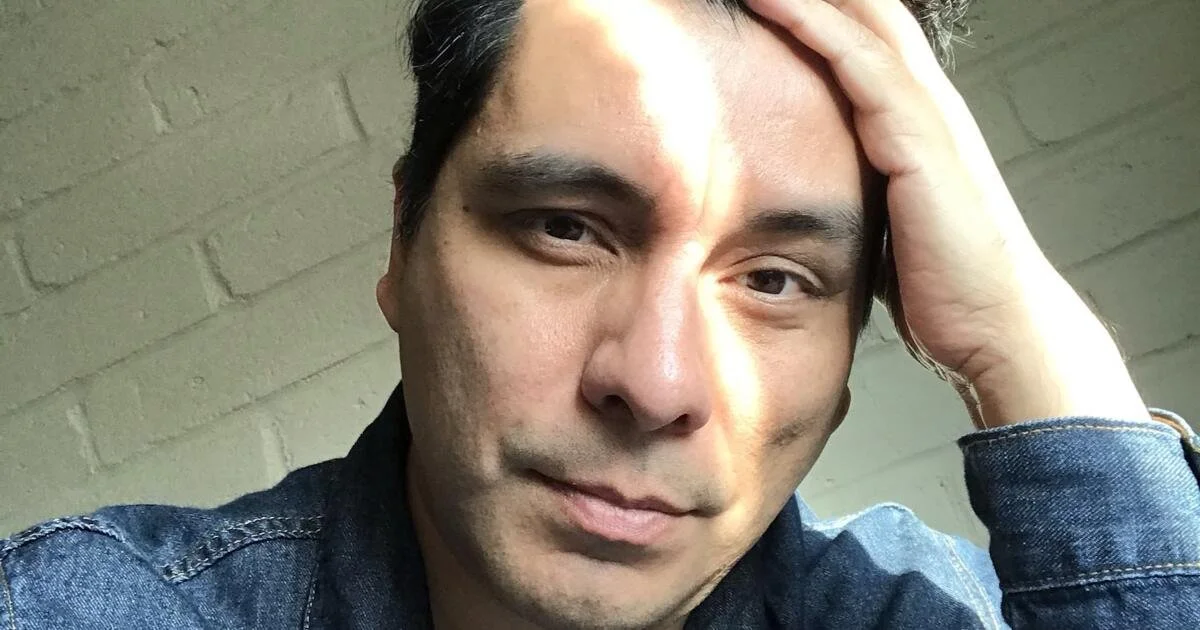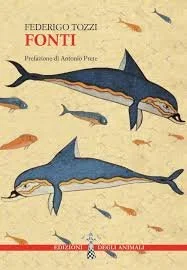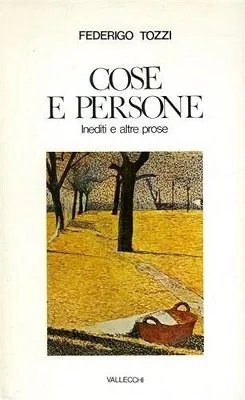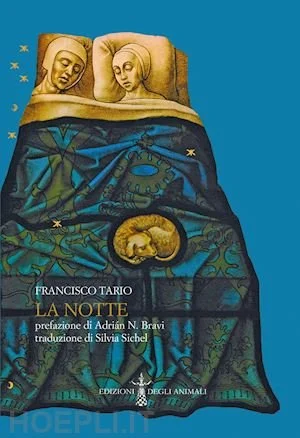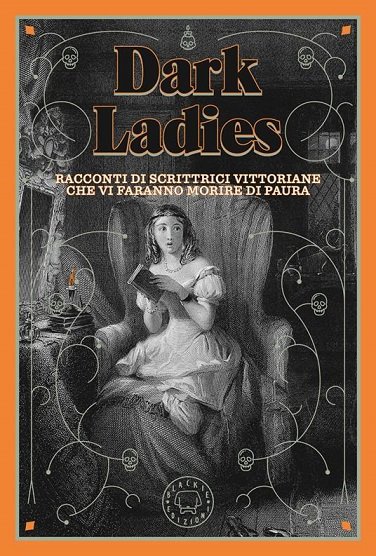di Debora Lambruschini
“Scrivere nel senso stretto e fisico, di sedersi con un pezzo di carta o un computer, è una piccola parte della scrittura. La mia condizione di scrittrice permea ogni gesto, ogni atto, la mia percezione, ogni cosa della mia vita. È una specie di religione, nel senso che mi dà un centro di gravità per essere e trascendere. Quando parlo di trascendere non parlo del dopo morte ma della possibilità di essere nell'altro, di uscire da me stesso e di essere letto da un altro.Sono una scrittrice tanto quanto sono eurasiatica e latinoamericana, quanto sono madre e figlia: non posso smettere di esserlo in nessun momento. Nemmeno voglio farlo”.
Quando ho posato la raccolta La pazienza dell’acqua sopra ogni cosa della scrittrice argentina Alejandra Kamiya ho sentito l’urgenza di dialogare con l’autrice, confrontarmi con lei su alcuni aspetti della scrittura che mi avevano particolarmente colpita. Grazie a Gianluca Cataldo, ufficio stampa de La nuova frontiera, editore per cui la raccolta è approdata pochi mesi fa in Italia con la traduzione dallo spagnolo di Elisa Tramontin, ho potuto rispondere a questa urgenza: le parole di Kamiya sono misurate ed evocative al pari dei suoi racconti, lo scambio mi ha permesso di riflettere sul senso della scrittura, su una prosa tesa tra realtà e sogno e l’intersezione tra due culture, quella argentina per parte materna e quella giapponese del padre. Mi sono soffermata a lungo su quanto essere scrittrice identifichi Kamiya, una condizione che, come dice lei «permea ogni gesto, ogni atto», investendo ogni aspetto del quotidiano, la percezione del mondo. Scrivere, dunque, è qualcosa che va ben oltre l’atto in sé di sedersi alla scrivania davanti al foglio bianco, è la postura tutta con cui si osserva il mondo e lo si interpreta.
Nei racconti de La pazienza dell’acqua sopra ogni pietra questa postura si avverte piuttosto chiaramente: sono storie in cui tutti i sensi vengono chiamati in causa, le immagini si intrecciano a una scrittura evocativa, onirica a tratti, racchiuse nello spazio di una manciata di pagine ciascuna. Le etichette di genere sono labili come i contorni delle storie che rifuggono rigide categorizzazioni e di volta in volta si misurano con il reale, il sogno, l’incubo, la memoria, l’invenzione letteraria. Nel racconto di apertura, “Sola”, la protagonista, Eva – e la scelta del nome non è affatto casuale – , si aggira tra le stanze di casa che scopre improvvisamente vuote, avvolte in un’oscurità che attraversa ogni cosa. «Tutto può accadere nelle ore vietate alla luce» e tutto infatti è accaduto: accanto a lei nel letto non c’è traccia di Antonio, il compagno, le sue cose sono dove le aveva lasciate ma la sua presenza è come fosse svanita. Lentamente Eva si muove tra gli spazi vuoti della casa, del palazzo, per accorgersi che non solo Antonio ma tutti quanti intorno a lei sono scomparsi. Kamiya compone una storia dai contorni perturbanti, evoca altri mondi e altre narrazioni, tesa tra realtà e incubo. Un’atmosfera che si ritrova ne “Il bagno” dove al contrario però più che la scomparsa colpisce l’apparizione: una donna sconosciuta «seduta sul bordo della vasca da bagno» di Pola, lo sguardo ferito e fragile. È quasi un gioco di specchi, ciò che per un momento aveva i contorni del sogno assume la forma dell’incubo. Un’altra casa, ora è lei la donna seduta sul bordo della vasca.
I racconti, dunque, sono sospesi tra due mondi, reale e immaginario, ma anche personale e finzionale: la narrazione si compie in tale intersezione ed è come se attraverso questa atmosfera anche le cose stesse restassero sospese, a partire dal giudizio sui personaggi e le loro scelte.
“[…] Non solo le mie storie si sviluppano all'incrocio tra il reale e l'immaginario ma anche la mia vita. I giorni passano lì, credo, che percepiamo e completiamo con le idee e le credenze che ci abitano. Per quanto riguarda il giudizio sui miei personaggi: cerco di non giudicarli, affinché agiscano liberamente, o almeno il più liberamente possibile.”
Lo spazio bianco della narrazione occupa una parte molto importante in questi racconti in cui ogni parola, dunque, è caricata di significato, amplificata dal sistema di immagini e simboli che li attraversa. Come lettori dobbiamo venire a patti con il mistero che non potrà mai essere pienamente svelato e calarci in quegli interstizi, trovare da noi la strada.
“Poi guardo le storie che ho, che, come dici tu, ognuna è stata scritta come un'unità chiusa, e penso a una forma, una scultura. E quindi organizzo le storie in modo da cercare quella forma e completarla”.
All’inizio della lettura riflettevo su quanta distanza ci fosse tra le due culture cui l’autrice appartiene e come questa distanza si traduca nella narrazione. Arrivata alla fine, in realtà, mi sembra di notare una compenetrazione ideale tra le due: è come se il mondo immaginifico di Silvina Ocampo, Mariana Enriquez e della grande tradizione del racconto femminile argentino, si sposi perfettamente alle atmosfere della tradizione nipponica.
“Mi sembra che siamo di nuovo d'accordo: scrivo inserita nelle tradizioni a cui appartengo. Non so se la combinazione è perfetta come dici tu, ma so che è la combinazione di cui sono fatta. È impossibile scrivere racconti in Argentina senza sentire lo sguardo di Borges sulle mie spalle e, nel mio caso particolare, senza sentirlo anche sopra e davanti a me, perché lo ammiro fin da quando ero piccola”.
La scrittura, ancora, non come atto in sé ma come identità, percezione del mondo. Ecco, dunque, che i due mondi cui appartiene Kamiya si intersecano nel racconto, affondano le mani nella tradizione, la reinventano. Il perturbante, le atmosfere oniriche, il quotidiano, il realismo magico, la realtà, l’invenzione, il cuento argentino, la cultura giapponese e gli haiku: la voce di Kamiya si forma qui, in questo spazio nuovo, si fa fluida e tende ora all’una ora all’altra. L’esperienza personale entra nel racconto e assume forma letteraria, rielabora situazioni, sentimenti.
All’epoca essere giapponese era passato da sorta di disonore a vantaggio. Ero diventata “esotica”, e ciò che prima mi aveva procurato castighi ora sembrava essere una cosa buona. Non ho mai capito il meccanismo né ho mai potuto eluderlo. (“Luoghi buoni”, p. 66)
L’identità giapponese nel racconto “Luoghi buoni” passa attraverso fasi diverse di diffidenza e accettazione ma è soprattutto memoria: la voce narrante è quella di una donna anziana, fermata per strada da un ragazzo che vorrebbe donarle l’ultimo cagnolino rimasto da una cucciolata ma del quale lei inizialmente rifiuta di occuparsi per via dell’età; inizia qui il susseguirsi dei ricordi dell’infanzia e della vita adulta, scandito dai diversi cani che l’hanno accompagnata. In poche pennellate Kamiya evoca un mondo, il pregiudizio verso i giapponesi, le vessazioni da parte degli altri bambini, la consolazione dei momenti in compagnia del primo, amatissimo cane. Il tempo scorre veloce nel racconto, un ricordo ne evoca un altro e le cose mutano ma non si dimenticano. Il tempo, ancora, è scandito dai cani che danno misura anche dei rapporti, della perdita, delle relazioni.
Che siano avvolte da atmosfere oniriche o più marcatamente realistiche, le storie di La pazienza dell’acqua sopra ogni pietra sono particolarmente legate dal fil rouge delle relazioni affettive, di cui Kamiya interpreta varie sfumature. È soprattutto il rapporto genitori-figli a colpire in modo peculiare e la forma di accudimento che, in talune storie, si ribalta. “Le prove” è il testo più lungo e a tratti più doloroso di questa raccolta, ma anche il più intimo e ricolmo di affetto: attraverso la storia di una figlia che accudisce l’anziana madre, Kamiya dispiega davanti a noi la complessità dei sentimenti e, come negli altri testi della raccolta, la sensazione come lettori non è di osservare da fuori ma di abitare questa storia.
E penso che lei, che mi ha insegnato tanto, non mi ha insegnato a gestire questa cosa, a ridere, a dimenticare, a essere sorda, un’altra, lontana, a essere più capace. O forse l’ha insegnato e io non ho imparato: mia sorella si allontana sempre da mia madre e questo alimenta l’amore di mia madre per lei. C’è una forma di incontro in quella danza. (“Le prove”, p. 92)
Ci sono moltissime forme di amore in questi racconti, moltissimi sentimenti, che legano uomini e donne ma evidenti anche nel rapporto umano-animale, che Kamiya esplora con curiosità in un richiamo evidente alla tradizione cuentista sudamericana. La tradizione, dunque, l’influenza di Borges come citato dalla stessa autrice nel corso del nostro dialogo, rappresenta però le radici da cui si sviluppa una voce del tutto nuova, inafferrabile, sospesa tra due mondi e due culture di cui pare assimilare di volta in volta ciò di cui ogni racconto ha bisogno e arricchendo così una realtà letteraria in cui trovano spazio, da sempre, voci e narrazioni tanto diverse. Nella brevitas di queste storie – a proposito, vale la pena recuperare anche la raccolta precedente, Anche gli alberi caduti sono il bosco, pubblicata nel 2023 da Ventanas – c’è il mistero della scrittura, il convergere di due tradizioni letterarie, dal cuento agli haiku, dei due mondi entro cui Kamiya si muove da sempre, forse non appartenendo davvero né all’uno né all’altro. Una terra di mezzo, dove nascono le sue storie immaginifiche.