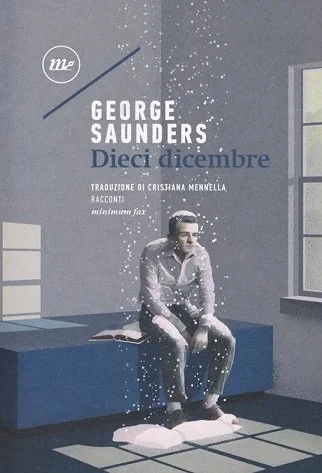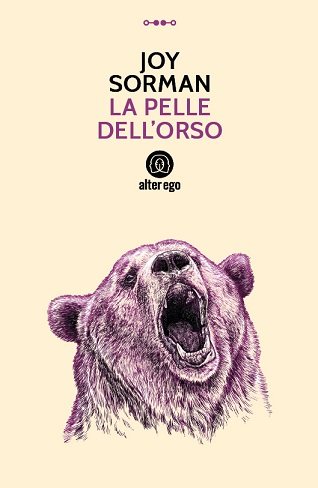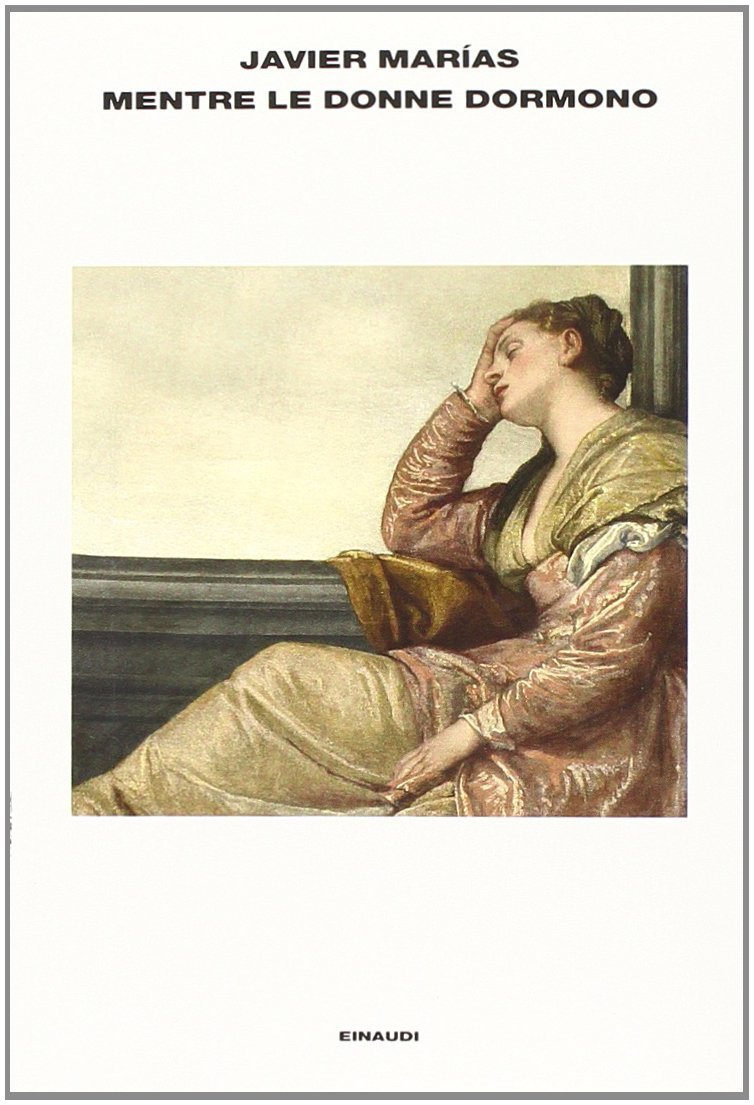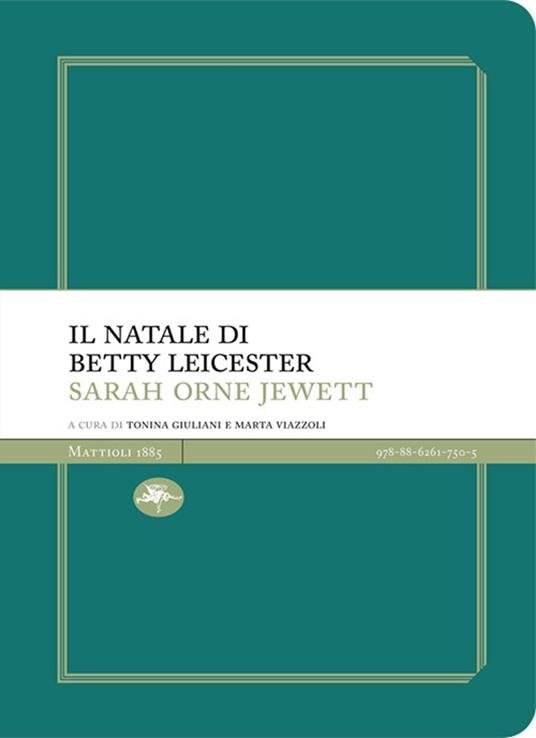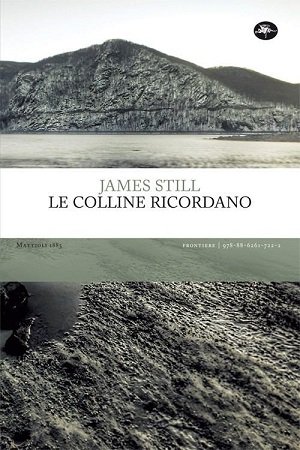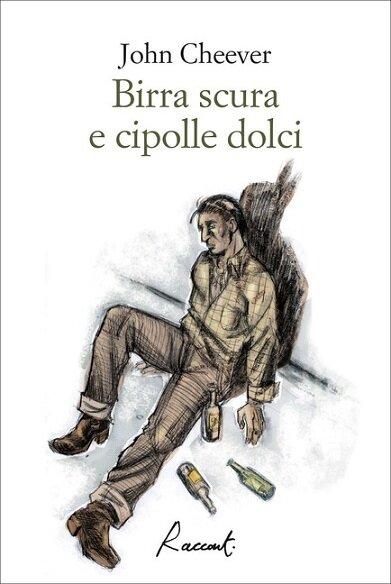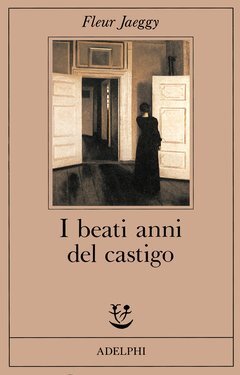di Giordana Restifo
«Vi depois, numa rocha, uma cruz
E o teu barco negro dançava na luz».
Amália Rodrigues - Barco negro
Una specie di Saudade
Struggente, forte, malinconico, disperato. Così era il fado interpretato da Amália Rodrigues dagli anni Quaranta in poi, e ancora oggi ascoltarla suscita un incongruo sentimento di afflizione. La sua commovente voce incarna alla perfezione quel sentimento, che in portoghese è definito “Saudade”. Una sorta di ricordo nostalgico legato agli affetti, che rievoca persone, cose e luoghi, in una dimensione, alle volte, mistica. Se, comunemente, questo trasporto nel sentire è attribuito al popolo portoghese, leggendo l’ultima opera di Kapka Kassabova, Il lago. Ritorno nei Balcani in pace e in guerra, pubblicata da Crocetti lo scorso maggio e tradotta da Anna Lovisolo, si scoprirà che anche altri popoli sono stati sconvolti da uno struggimento simile. Il lago ne è contaminato e tutti i capitoli ne sono intrisi.
Kassabova ci invita a entrare nella sua vita e in quella della sua famiglia attraversando conflitti, generazioni, confini. Percorrendo insieme il «paesaggio esistenziale» della sua famiglia materna e dei suoi antenati ci si rende conto di avere a che fare con quello che potremmo definire un trattato di storia, di politica, di geografia e di antropologia molto più ampio della sola biografia. Il mondo dentro il quale si entra, già dall’introduzione, è poco conosciuto, ne fanno parte paesi che, grossolanamente, definiamo con “est”, come fossero lontani chilometri da noi e con tutt’altre storie che non ci interessano. L’autrice bulgara ci offre una via d’accesso all’area balcanica differente, impervia, ma non ci lascia mai la mano fino all’ultima pagina, ci sostiene. Ogni tanto ce la stringe, ogni tanto la stringiamo noi a lei, ci sosteniamo.
Nel percorso ci sono vallate, catene montuose, strade desolate, e, soprattutto, ci sono i due laghi gemelli di Ocrida e di Prespa, attorno ai quali tutto ruota, si divide e si ricompone. Sono i laghi più antichi d’Europa, circondati da sorgenti e collegati tra loro da corsi d’acqua sotterranei. Nonostante le peculiarità idrografiche, ciò che stupisce maggiormente è che sulla loro superficie s’incontrano due, in certi punti tre, confini nazionali: Grecia, Albania, Macedonia (del Nord). Queste frontiere impercettibili via acqua, ma presidiate via terra, hanno causato, nei decenni, sofferenza e fughe, alimentato leggende, verità soggettive e menzogne. Quella di San Naum, tra Macedonia (del Nord) e Albania, ad esempio, era stata istituita nei primi anni Novanta:
per quasi cinquant’anni non c’era stata alcuna dogana in questa zona lacustre tra le due nazioni. Ma non si poteva tracciare una vera e propria linea tra gli albanesi e i macedoni del lago. La linea era soltanto fittizia, una linea nell’acqua
Come Anastassia, la nonna materna dell’autrice, anche tante altre donne, e prima di loro gli uomini, i padri di famiglia o i ragazzi in cerca di speranza, hanno lasciato le rive del lago per trasferirsi altrove. Viaggiatori leggeri, che partivano soltanto con i vestiti indossati quel giorno, perché di pesante avevano già il macigno della storia, personale e collettiva, e della nostalgia attanagliante. Nelle prime pagine appare un ricordo materiale del paesaggio perduto:
Sul tavolo rotondo nel salotto dei nonni, coperto da una tovaglia di velluto con le frange, c’era un vaso con i ciottoli del lago. Erano lisci come tutti gli altri, bianchi e rosa, ma erano anche dei talismani che si portavano dietro la brezza di un mondo più leggero e arioso.
Infatti, per i molti figli della diaspora, andare via dai propri luoghi era stato un atto dovuto o una conseguenza delle “liste nere” compilate dalle politiche nazionali, per tutti, a prescindere dai motivi dell’allontanamento, il dolore e il rimpianto non si erano mai attenuati.
Visti dall’alto i laghi di Ocrida e Prespa sono un’immagine topografica della psiche, la luce e l’ombra, il conscio e l’inconscio, collegati da canali sotterranei. Ciascuno contiene l’altro senza negarlo, come un simbolo perfetto di yin e yang. È così che sono sopravvissuti per un milione di anni in un sistema che si autorigenera.
Tra gli abitanti rimasti, invece, alcuni si sono abbandonati al “destino balcanico” dal quale non si può fuggire, e anche per loro la situazione si è trasformata in uno struggimento continuo, hanno vissuto accettando la malinconia di quello che poteva essere e non è stato, una sofferenza inevitabile. Ed ecco che torna il principio del fado: «Il fado non si canta, accade. È un avvenimento. […] Il fado si sente, non si comprende né si spiega. Il fado è sapere che non si può lottare contro quello che abbiamo. È quello che non possiamo cambiare. È chiedere perché e non sapere il motivo. È non smettere di chiedere e, allo stesso tempo, sapere che non c’è risposta», diceva Amália Rodrigues (Vítor P. Dos Santos, Amália Rodrigues, una biografia, Cavallo di ferro, 2006). Altri hanno preferito un’emigrazione interiore, come intuisce l’autrice parlando di politica interna con i cugini:
L’emigrazione interiore, praticata in massa durante il comunismo, qui era ritornata in auge: abiti nel tuo paese ma fino a un certo punto. Con la mente sei altrove, in un luogo più equo, più emancipato, proprio come dovrebbe essere la nazione in cui vivi.
L’intera opera è intrisa di questo sentimento malinconico, che l’autrice non definisce Saudade ma alla quale somiglia molto. La madre e la nonna avevano sempre nostalgia di qualcosa; le zie della signora Slavche, colei che ha fatto scoprire a Kapka Kassabova la «straordinaria e mistica tradizione del sufismo», emigrate nei travagliati anni Trenta in Romania, per tutta la vita avevano avuto nostalgia di Ocrida. Ancora, le molte religioni osservate nei Balcani, che hanno sempre convissuto (a tal proposito si legga questo passo: «I cristiani frequentavano i tekke [alloggio comunitario sufi – dal glossario presente alla fine del libro] e i musulmani i monasteri»), fanno riferimento a tale sentimento: la chiesa di Santa Maria Perivlepta, la “Più Gloriosa”, era dotata di alloggi per ospitare chi soffriva di malinconia; tra le attività del tekke era previsto di dare ospitalità «ai malati di mente e ai malinconici», finché non fossero guariti; infine, Naum, un teologo missionario, al quale è stato dedicato un miracoloso monastero, tra le sue tante qualità, aveva anche quella di «guarire i folli e i malinconici».
Ne Il lago c’è molto più di questo, ci sono le leggende che riguardano i due specchi d’acqua, ci sono personaggi illustri e personaggi sgradevoli della storia di quei paesi confinanti, c’è il folclore e ci sono i Santi, c’è l’immancabile bevanda dei Balcani (qui denominata rakija). C’è la famiglia dell’autrice e ci sono le tante famiglie balcaniche, sopra le cui pene sono passati senza remore i governi (quelli nazionali, quelli europei e quelli extraeuropei), i regimi e la politica tutta. Ci sono le “Questioni”, quella orientale, quella macedone, che sembrano sempre riguardare altri e mai noi. C’è anche quella che Rebecca West (citata dalla Kassabova) definisce la “religione fondamentale” in Macedonia, ovvero il culto della natura, «con una particolare predilezione per l’acqua». La pacifica convivenza delle tante popolazioni, che, nei secoli, era stata mantenuta nonostante le differenti lingue e religioni, nel corso della storia è cessata: «La gente dei laghi era composta da popoli che, con il trascorrere del tempo, dei confini e di politiche retrive, erano diventati nemici». Hanno dimenticato che da un lato e dall’altro dei confini sono le stesse persone, che hanno patito sofferenze simili specchiandosi l’un l’altra.
Confine diverso, stesso tormento
In questo viaggio partito dal confine che più guarda a Occidente e si affaccia, perdendosi, sull’Oceano Atlantico, e passato da quello che associamo più all’Oriente, si arriva a uno familiare, se non proprio fisicamente almeno geograficamente e storicamente. È il confine tra l’Italia e la Slovenia. Un tratto di terra travagliato, che ha fatto da scenario a molti scontri sanguinosi, a sommosse tra militari, alla lotta partigiana, e che negli anni ha subito numerose modifiche alle linee di frontiera. Nel suo Bestiario di confine, pubblicato anch’esso durante la primavera del 2022 da Bottega Errante Edizioni (BEE) e tradotto da Lucia Gaja Scuteri, Primoz Sturman affronta tutti i limiti e le potenzialità di questa terra di mezzo. Undici racconti in cui i sogni, le debolezze, le speranze, la questione della lingua e dell’identità, la politica e la religione, assomigliano incredibilmente a quelli letti poche righe più su, come se non ci si fosse mossi di oltre mille chilometri a Nord rispetto a dove ci si trovava con Kapka Kassabova.
In tempi più recenti, la distanza ravvicinata e il veloce, ma non semplice, passaggio tra una nazione e l’altra, per alcuni, sono stati una benedizione:
In effetti il confine, che prima era una maledizione per tutto e tutti, negli ultimi tempi era diventato una vera e propria benedizione. Rimasti tagliati fuori per una decina d’anni scarsa subito dopo la guerra, i borghi e i paesini a ridosso del confine ora se la passavamo molto meglio del resto della madrepatria jugoslava, proprio grazie alla vicinanza con Trieste e l’Italia.
Non tutti, però, hanno fatto affari e sono riusciti ad accantonare soprusi e sofferenze. C’è chi ha perso la testa, come il protagonista di Gorizia è nostra che viene portato all’ospedale psichiatrico di Idrija perché non si vuole arrendere all’idea che Gorizia sia una città italiana, anche se gli altri personaggi provano a disfare i suoi sognanti progetti di rivolta: «Il mio nono mi raccontava sempre com’era tra partigiani… e che non è per niente giusto che Gorizia non sia nostra…», a questo ricordo il dottor Skof risponde: «Ma se ce l’abbiamo da una vita la nostra, di Gorizia: Nova Gorica! Lasci stare quel che è accaduto nelle generazioni precedenti. Anche mio zio dal lato materno era partigiano. È trascorso tanto di quel tempo da allora… Non ci riguarda, di certo non al punto da rovinarci l’esistenza. Lei viva la sua vita qui e ora!». E poi c’è suo fratello che alla proposta di «spostare il confine un po’ più a ovest» lo mette a tacere dicendo solamente «lascia stare il confine dove sta, tanto non esiste più».
C’è anche chi ha dovuto subire passivamente il declino culturale, linguistico e identitario del proprio paese, lo spiega bene Martina Vocci nella postfazione del Bestiario: «”le parole sono importanti”, urlerebbe infastidito Nanni Moretti, e per un lungo periodo nel lembo occidentale dell’Italia, al confine con la Slovenia e poi la Croazia, sono state tutto, anche una forma inaudita di violenza imposta a chi qui era a casa sua ma non poteva che parlare o studiare la lingua italiana: ogni uso della lingua slovena era pubblicamente vietato». Così come per gli sloveni, ciò era accaduto anche per i portoghesi, i greci, gli albanesi, i macedoni e per tutti quei popoli soggiogati da regimi totalitari fautori di un discorso ideologico incentrato sull’omologazione della vita culturale e su principi ipernazionalistici come la lingua unica, la famiglia, la patria, la religione. Tutto doveva essere tenuto sotto controllo, anche se in alcuni paesini sul Carso l’unica cosa che veramente contava, durante gli anni del fascismo, era se fossi o meno uno di loro: «Questa gente del Carso ha ereditato dai propri avi il vigore, la resistenza, oserei quasi dire l’infrangibilità, necessari a cavarsela su una terra che tanto pretende e così poco offre in cambio. È interessante notare come mi considerino uno di loro, seppur solo fino a un certo punto», annota il protagonista del racconto Scherzando col fuoco, «a salvarmi è il fatto che la nona sia di Dutovlje, altrimenti non farebbero grandi distinzioni tra me e gli altri triestini che vengono qui in vacanza. Nel borgo, infatti, non conta se parli la stessa lingua e se sei, pertanto, anche tu un membro del popolo oppresso e perseguitato, conta solo se sei o non sei uno di loro».
Cosa resta quindi in quest’epoca moderna, dopo tutto questo carico crudele di storia e destino? Restano il fatalismo, la rassegnazione, una passionalità lugubre; ma quello appena compiuto non è un viaggio da turisti, si tratta di una ricerca, di un’ammissione a noi stessi, che dovremmo approfondire. Come ci suggerisce Kapka Kassabova: «Se si vuole compiere un viaggio nei luoghi dei propri antenati bisogna essere disposti a vedere cose che è più facile negare». Proprio questo è stato il motivo che l’ha spinta a partire, perché se non avesse scoperto, saputo, conosciuto a fondo, avrebbe potuto ripetere certi vecchi schemi, «e poiché in questo secolo ancora assistiamo a guerre civili e fratricide, a politiche divisive tra gli stati e al loro interno, a revisionismi e autocrazie di natura patriarcale, a migrazioni di massa e a spostamenti di popoli, poiché assistiamo a tutto questo, rischiamo di trasformarci anche noi in involontari agenti della distruzione, a meno di non prendere coscienza del modo in cui ci portiamo dietro la nostra storia familiare».