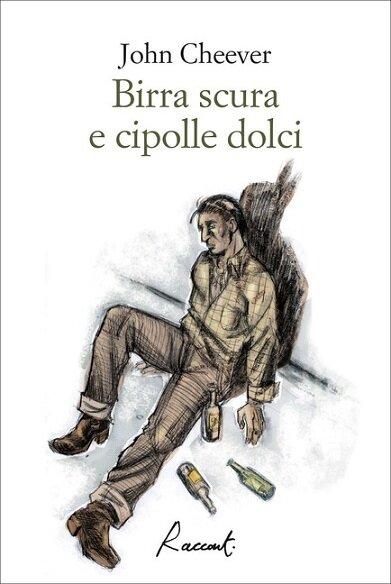di Fabrizia Gagliardi
Nel quartiere esclusivo di Sutton Place, Manhattan, tra i fasti architettonici di brownstones e villette a schiera sull’East River, c’è anche il sogno di un uomo in un condominio. Ogni giorno insieme a giacca e cravatta indossa l’aria generica di una frase sul tempo atmosferico pronunciata in ascensore. Mentre i vicini pensano al miglior anestetico per iniziare la giornata lavorativa in città, John Cheever scende nel seminterrato, si spoglia e scrive con l’aiuto di qualche drink. È finita la seconda guerra mondiale, la precarietà economica e la paura di un disastro nucleare l’hanno toccato senza mai scalfire un’instancabile speranza.
In un salto nel futuro, quasi trent’anni dopo, John Cheever bussa alla porta della camera sopra la sua nello studentato dell’Università dell’Iowa. Gli aprirà un giovane Raymond Carver che, prima di conquistarlo col talento, gli serve un bicchiere di scotch per essere sulla stessa lunghezza d’onda. Davanti a lui c’era uno degli scrittori più affermati del tempo – Cheever aveva vinto il National Book Award per il suo primo romanzo, Cronache della famiglia Wapshot, ed era un prestigioso collaboratore del New Yorker – che, proprio come i suoi personaggi, sembrava provare fascino per gli aspetti semplici e casuali della vita rispetto all’analisi letteraria.
Percorrere avanti e indietro la linea temporale di un’intera vita trasmette la pretesa di dare significato ai dettagli che ne determineranno l’esistenza e la sua fine, come a voler mitigare la cecità lungimirante della nostra.
Sembra proprio che, giunto alla metà della mia vita, io non abbia fatto nessun progresso, a meno che non sia da considerarsi un progresso la rassegnazione. C’è il momento erotico del risveglio, che è come nascere. C’è la luce o la pioggia, un simbolo immediato grazie al quale si ritorna al mondo visibile, forse al mondo adulto. C’è l’euforia, la sensazione che la vita non sia niente di più di ciò che appare, luce e acqua e alberi e persone piacevoli che rischiano di andare in mille pezzi per colpa di un collo, di una mano, di un’oscenità scritta sulla porta del gabinetto. C’è sempre, da qualche parte, questo accenno di aberrante carnalità.
Dai frammenti dei diari di John Cheever (tradotti in Italia da Adelaide Cioni in Una specie di solitudine, Feltrinelli) è facile giocare il ruolo dell’osservatore freudiano e vedere un uomo profondamente diviso tra la morale cattolica, la ribellione alle norme sociali, una bisessualità sempre presente e la dipendenza da alcol ad alleviare le lacune di amanti, frustrazione artistica e disillusione. L’unica colpa di cui si era macchiato John Cheever era la consapevolezza che il peccato originale ha una forma mutevole e attraente, ma è, soprattutto, onnipresente: ognuno se ne può costruire uno con l’unica condizione di non confessarlo per un tacito accordo d’ipocrisia. Probabilmente l’idea di essere un intruso in una classe sociale che non gli apparteneva non faceva che accentuare il senso d’inadeguatezza di un outsider. Quella stessa idea di avere il piede in due scarpe è il lasciapassare per una sperimentazione oltre la norma.
Alla maggior parte delle persone occorre coraggio per gettare la maschera minuziosamente adibita a facciata, perché è la regola che dà ordine al mondo, è l’illusione di una coerenza tanto agognata nelle storie della letteratura. La trasgressione rimane ancorata al sogno invisibile di una notte, per il resto tutto sarà votato all’equilibrio di una bilancia immaginaria tra peccati e opere buone. John Cheever, invece, sceglie di spogliarsi di ogni velo che lo divide dall’apparenza e ogni contatto con la sensibilità gli fa smantellare le impalcature borghesi con più sincerità di chiunque altro.
Per sviluppare uno stile tutto personale bisogna passare per un apprendistato letterario tortuoso e non sempre facile. Anche se, come ha affermato nella raccolta completa dei suoi racconti, «il parto di uno scrittore, diversamente da quello di un pittore, non rivela alcuna interessante affinità con i suoi maestri», il John Cheever degli inizi non nasconde un certo fascino per le opere di Ernest Hemingway. Birra scura e cipolle dolci (traduzione di Leonardo G. Luccone, Racconti Edizioni) raccoglie i tentativi letterari tra il 1931, quando aveva diciannove anni, e il 1942 e chiarisce subito una vicinanza di ricognizione: la semplicità del periodo, la ricerca del lasciar intendere ricordano la facilità dei personaggi di Fiesta di constatare il proprio stato d’animo senza alcun lirismo. Tra le maglie di quello che potrebbe sembrare uno scarno manierismo s’intravedono alcune intrusioni di stile che diventeranno nuclei fondanti.
Avverte i passaggi del giorno e della luce, mattina, pomeriggio, la confusione del crepuscolo, sera. Avverte la primavera e il volgere della stagione. C’è una rapida increspatura di verde tra i due orti, è il grano a modellarla. È un verde terribile, che è gocciolato sul paesaggio come acqua gelida. Il fiume è in piena. Le piogge martelleranno calde e amare sul tetto di lamiera. E lei tutto questo non può fermarlo. Ha mani scarnificate e nervose, che stridono di un’energia strana. Non può alzarle e far sì che il tempo si fermi e resti immutabile, per sempre inverno. Lei tutto questo non può fermarlo con le sue mani, così come non sarebbe in grado di arginare una cataratta o un’onda gigante.
Nel racconto che intitola la raccolta Amy è la proprietaria di una fattoria che ospita vacanzieri occasionali ed è impensierita dall’avvicinarsi del suo compleanno. In poche pagine l’autore raccoglie scene cruciali fondendo lo scorrere del tempo, il susseguirsi delle stagioni e l’illusione umana d’immutabilità.
Il ritmo delle storie si adatta alle scenografie cittadine e bucoliche che daranno una casa all’autore. Se alla natura appartengono visioni ampie e contemplative sull’inevitabilità e la lentezza del compiersi umano, la città è il movimento nella folla, un disseminare di indizi di una crisi imminente. Ai panorami sconfinati si sostituiscono interni di locali, compartimenti di treni, spazi angusti per segreti in piccole villette di periferia, tutti animati da bozzetti di uomini e donne dalle sorti incomplete. La cameriera Beyonne è ossessionata dall’arrivo di una giovane ragazza; Dorothy professa una fede totale nella disciplina della danza ne La principessa; l’incombente vecchiaia di Beatrice, la spogliarellista dell’omonimo racconto, non la fa arrendere a essere una semplice sostituta. Saranno soprattutto le donne ad allungare la mano verso la luce verde del sogno americano ispirandosi proprio all’umore narrativo di Fitzgerald. Tutta la durezza romantica di Hemingway sfuma in dialoghi dal sapore malinconico e in un sottofondo di innegabile speranza, mentre l’unico intervento del narratore sarà un coinvolgimento sincero senza alcuna interferenza.
Se i personaggi dei primi racconti erano apparizioni quasi anonime su sfondi mutevoli e ricchi di dettagli, le storie della maturità espandono le conseguenze delle scelte: spesso i protagonisti non sono semplici guizzi dal destino incerto, ma sono personalità ben definite ritratte nel percorso completo di sogno, illusione e disillusione. Il tempo delle vicende si dilata come a voler comunicare, oltre lo sviluppo stilistico, la crescita dolorosa e altrettanto lucida di chi scrive.
In Tutti i racconti (pubblicato da Feltrinelli con la traduzione di Marco Papi, Leonardo Giovanni Luccone, Adelaide Cioni, Franco Lucentini, Laura Grimaldi, Sergio Claudio Perroni) riusciamo a ricostruire le tappe di una consapevolezza crescente. Ne La pentola d’oro le luci di New York brilleranno in un modo inedito perché avvolte dal fascino distaccato che solo speranza, promesse e attese potranno conquistare; come ne Il sovrintendente della casa indovineremo i candidati alla scalata sociale attraverso la loro ascesa architettonica («Dopo un anno o due nel 9E, Chester prevedeva che si sarebbe trasferita in uno degli attici. E da lì sarebbe probabilmente decollata per uno dei più eleganti appartamenti nei quartieri alti nella Quinta Avenue»).
Anche quando il tedio della vita economica si eclissa tutti i protagonisti entrano in una spirale volubile dai contorni materiali e sociali ben definiti: i vialetti ben tosati, le villette dei suburbs disposte una accanto all’altra, le feste e le chiacchiere del vicinato, la prevedibilità della vita famigliare in tutte le sue sfumature, quel senso di profonda conoscenza e intimità che provocano voglia di evasione e insanabile noia nonostante l’infinito amore. La scrittura di John Cheever è in grado di attraversare i cliché più scontati senza offrire soluzioni ma scendendo nei meandri più oscuri della verità. Come il protagonista de Il marito di campagna che, sballottato tra lavoro e ritorno in treno alla vita di provincia, avverte un disagio che gli fa incanalare ogni speranza di cambiamento nelle fantasie con la giovane baby-sitter. O come ne La chimera in cui il pensiero del divorzio dalla moglie è frenato dall’attaccamento all’ordine del vialetto, la quiete solida e materiale di una casa che l’uomo ha riparato con le sue mani. Viene da chiedersi se il vero paradosso non sia l’ironia de Il baco della mela in cui un osservatore esterno non fa che scandagliare la perfetta normalità di una famiglia che sembra non avere nessun segreto.
I Crutchman erano così felici ma così felici, e così moderati in tutte le loro abitudini e così contenti di tutto quello che gli capitava, che si era portati a sospettare che ci fosse un baco in quella mela così rossa.
A leggere storie di matrimoni, innamoramenti, tradimenti, traslochi, figli, ricchezza e miseria si ha quasi l’impressione di essere al cospetto di un compendio della natura umana: tutti vivono nella speranza di un futuro che non c’è mai stato, tutti desiderano il tempo sospeso per vivere il presente allo stesso modo del passato.
“Speriamo che mio padre si sia ricordato di fare benzina”, dice un ragazzo, e una ragazza scoppia a ridere. In mente non hanno altro che lo snodarsi delle sere d’estate. Né tasse né elastici di mutandine – tutte quelle incresciose realtà di vita che minacciano di soffocare Cash – hanno ancora toccato le sagome che sciamano nel giardino dei Rogers. Allora l’invidia lo ghermisce – un’invidia talmente violenta e disperata da farlo star male […].
Si sente come se i ragazzi nel giardino dei Rogers fossero fantasmi di una festa allestita in quel passato che contiene ogni suo desiderio e ogni suo svago, e da cui è stato crudelmente scacciato. Si sente come il fantasma delle sere d’estate. La nostalgia lo soffoca. (dal racconto Oh gioventù e bellezza!)
Lo stile di Cheever riesce a dare importanza a ogni dettaglio del percorso tutto personale dei protagonisti fino a dissezionare ogni sentimento utile a scandire il momento di rottura. Non è detto che per ogni vicenda ci sia una risoluzione, basterà aver illuminato una crepa dell’oscillante natura umana per suggerire uno sviluppo futuro.
Più che leggere storie per estraniarci dalla realtà viene voglia di immaginare il narratore e avremo la tentazione di definirlo onesto, persino autentico perché, con un’eleganza stilistica maniacale, ha confessato una claustrofobia di valori e pratiche che per la maggior parte delle persone costituiscono tappe scontate. Non dimentichiamo però che John Cheever era il primo a rimanere fedele a quella stessa società che criticava, «un adultero che scrisse convincenti elogi della monogamia». Eppure la sua idea di letteratura era contro ogni riferimento alla vita privata perché «la fiction non è criptoautobiografia: il suo splendore sta nel fatto che non è autobiografica. E non è nemmeno biografica. È un ricchissimo complesso di autobiografia e biografia». Nonostante le proteste non possiamo che accostarlo continuamente alle sue storie, ma lo guarderemo sotto la lente di estrema fedeltà a se stesso e di una sottile ribellione, come a voler intraprendere il percorso esistenziale a ritroso dal mondo degli adulti all’innocenza dell’infanzia.
Il tentativo di conservare le apparenze di un uomo immerso nel suo tempo è la speranza di chi è sceso a patti con le parti più contraddittorie della vita. Invece di nasconderle e arrendersi a una normale accettazione, continuerà a raccontarle avvolgendole di speranza come ne I gioielli di Cabot: «I bambini annegano, donne bellissime vengono maciullate in incidenti stradali, le navi da crociera affondano e gli uomini muoiono di morte lenta nelle miniere o nei sottomarini, ma non troverete niente di tutto questo nei miei racconti. Nell’ultimo capitolo la nave rientra in porto, i bambini vengono salvati, i minatori vengono estratti da sottoterra».