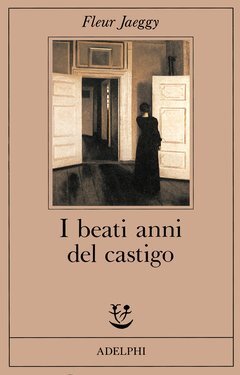di Debora Lambruschini
La felicità feriva come una lama ardente.
(“Senza destino”, La paura del cielo)
Di lame è disseminata l’opera intera di Fleur Jaeggy: frasi spietate, parole scelte con precisione chirurgica, la prosa limata e limata ancora fino a ridurla all’essenziale, non un termine o un segno di punteggiatura superflui. Nata in Svizzera e presto trasferitasi in Italia, Fleur Jaeggy è una scrittrice schiva, che rifugge ogni logica editoriale, centellina le parole e strega i suoi lettori con quella prosa scarna, le increspature minime della superficie che lasciano intravedere il mondo sommerso della narrazione. Leggere romanzi e racconti di Jaeggy, tutti editi da Adelphi, è un doloroso incanto: colpiscono per la profonda introspezione dei personaggi, i movimenti interiori svelati da un gesto, una di quelle piccole arricciature che rivelano l’abisso; ma è anche una lettura che scortica, mai consolatoria o salvifica, una discesa negli angoli bui dell’essere umano, tra solitudini, parole taciute, assenze, perdite. Una letteratura che si nutre di ossessioni, della scrittrice rispetto a determinate tematiche e spunti, del lettore catturato dalla «calma violenta» della narrazione.
Mi avvicino a Jaeggy con diffidenza, nel tentativo di svelarne il mistero, il suo nome che non smette di circolare sottovoce tra i lettori, una sorta di passaparola lontano dal caos del mainstream; è un incontro il nostro avvenuto quasi per caso: la prosa di Jaeggy portata come esempio delle capacità della sottrazione, di raccontare i moti dell’animo umano, una narrazione costruita sull’interiorità dei personaggi, in cui trama e forma si compenetrano. Traccio la strada che mi ha condotta a Jaeggy perché lì si è delineato il mio personale modo di leggerla, tentando di interpretarla e farla mia, sbagliando probabilmente e cogliendone solo una parte minima, soggettiva, marginale, come in fondo lo è ogni lettura che facciamo. Ma immergersi totalmente nel mondo di questa scrittrice sfuggente è stato il modo ideale per comprendere la malia esercitata sui lettori, il filo rosso che lega ogni pagina scritta in un gioco perfetto di rimandi, spunti, occorrenze e, ancora, la fiducia nella propria scrittura, mai mutata.
È così, quindi, che ci si accorge anche di come Jaeggy scriva e riscriva – magnificamente – la stessa storia: come Richard Yates, come Shirley Jackson, come Raymond Carver, Jaeggy nutre la propria ossessione e la nostra scrivendo e riscrivendo appunto lo stesso nucleo essenziale, ma ogni volta è un piccolo miracolo di scrittura e profondità. Inseguendo un filo cronologico, si parte da I beati anni del castigo – le primissime opere di Jaeggy sono praticamente introvabili -, il romanzo del 1989 con cui vinse il Premio Bagutta: e non è un caso, iniziare proprio da qui, perché è dentro queste pagine che si trova il nucleo narrativo di Jaeggy, quello che inseguiremo una storia via l’altra, tra richiami talvolta espliciti, altre più sottesi. E qui c’è già tutto il suo mondo letterario: un collegio femminile sulle alpi svizzere, le assenze, la solitudine, l’amicizia che sconfina nell’amore-ossessione, la gioventù mai innocente, la vita indissolubilmente legata alla morte, il contrasto dentro-fuori; la scrittura già perfetta, il gusto per l’ossimoro, i ripetuti cambi di tempo verbale e di soggetto, il profondo lavoro di omissione, i dettagli minimi che rivelano le voragini della narrazione. I beati anni del castigo è il romanzo più celebre di Jaeggy ed è qui che si delineano i tratti delle narrazioni che verranno, i perni intorno a cui l’autrice costruisce il suo mondo letterario, a partire dalle assenze e dal senso di solitudine, un fantasma che migra di storia in storia. È, per esempio, assenza di punti di riferimento famigliari solidi: il rapporto di quasi totale estraneità tra il padre e la figlia protagonista e narratrice principale della storia, la figura sullo sfondo di una madre lontana ma ingombrante che detta legge e decide di ogni aspetto della vita della figlia, pur non palesandosi mai.
Lei ordina, io obbedisco, i trimestri sono guidati da lei, è tutto scritto nelle lettere e nei francobolli,
campane senza suono. Dispacci.
(I beati anni del castigo)
Assenza di parole, perché non adeguate a dare voce a sentimenti complessi, all’amicizia tra lei e la nuova arrivata, Frédérique, bella, schiva, misteriosa quel tanto che basta a conquistare il cuore della protagonista e ad aprire una voragine con la sua improvvisa assenza.
Avevo perso ciò che avevo di più importante nella mia vita, il cielo era sempre azzurro, dimentico, tutto anelava alla pace e alla felicità, il paesaggio era idilliaco, come l’adolescenza idilliaca e disperata.
(I beati anni del castigo)
Di queste voragini, ancora una volta, è intessuta ogni storia di Jaeggy: abissi di solitudini e disperazione che si rivelano da una fotografia, da un segreto serbato per tutta la vita, da un gesto violento e brutale. Jaeggy apre squarci, sulla pagina e dentro il lettore, con una scrittura che rasenta la freddezza tanto è calibrata, scarna.
Mancanze anche quando le distanze si accorciano, almeno geograficamente, ma che non sanno farsi parola, affetto, reale vicinanza: nemmeno tra un padre e una figlia, insieme in crociera (Proleterka, 2001) per quello che sono consapevoli essere l’ultimo viaggio, l’ultima occasione per conoscersi davvero.
Per lui è importante quel viaggio. Avevo pensato prima di partire che mi era indifferente la destinazione. Il viaggio in Grecia faceva parte della mia educazione. È il nostro primo viaggio – e sembra l’ultimo. Johannes, la persona a me inverosimilmente ignota. Mio padre. Non una confidenza. Eppure un legame anteriore alle nostre esistenze. Una conoscenza nell’estraneità totale.
(Proleterka)
L’incomunicabilità è tale tra i due da renderli quasi estranei, la distanza che si fa vuoto, un’assenza già annunciata, vissuta. Quel viaggio che dovrebbe essere l’occasione di un avvicinamento, diviene invece per la protagonista il tempo della scoperta sessuale, il passaggio brutale dall’infanzia all’età adulta ma, si badi bene, non la perdita dell’innocenza, una condizione estranea ai personaggi e alle narrazioni di Jaeggy. E quella madre lontana, la cui autorità non viene mai meno, nonostante la distanza e la “libertà” conquistata dopo gli anni del collegio, il vuoto che la sua partenza ha lasciato tra loro.
Il suono del pianoforte rappresenta tutto ciò che non ho avuto. La sentivo suonare quando ero molto piccola, quando ancora era sposata con Johannes. Poi quel suono è finito. Le stanza tacevano. Ho odiato quel silenzio, senza saperlo. Il silenzio ricevuto da un uomo e una donna che si lasciavano e hanno disposto in modo assoluto della vita di una figlia.
(Proleterka)
Una madre che muove vite e custodisce segreti terribili, che si rincorrono, come altre micro narrazioni, da un racconto all’altro. Dove, per esempio, ritroviamo Frédérique, irriconoscibile, perduta, colmiamo parte dei vuoti della narrazione, delle assenze, ma rinunciando subito all’idea di ottenere un quadro con tutti i dettagli, possiamo solo cogliere i piccoli indizi che Jaeggy dissemina qui e là, le rivelazioni che ci concede improvvise. Tragica e meravigliosa, Frédérique appare come un fantasma, alimenta l’ossessione mai svanita della protagonista, la intravediamo qualche volta chiaramente altre meno, in un gioco di complicità tra Jaeggy e il lettore. Perduta, la malattia mentale che esplode violenta, i tentativi di salvarla. Ecco, la violenza, tanto brutale quanto inaspettata, è un’altra ricorrenza nelle pagine di Jaeggy che, a tratti, ricorda certe storie di Shirley Jackson, pur con tutte le differenze del caso. Esplode sulla pagina di Jaeggy in forme e moti diversi: è il gesto improvviso di una mente distorta, è la vendetta contro una vita sofferta, ma è anche la complicità dettata dalla compassione e dall’amore, forme molteplici che si sommano quasi tutte ne La paura del cielo, sette racconti di brutale bellezza. Qui le occorrenze sono date dal cielo minaccioso, dal gesto violento appunto, dalla riflessione su solitudine e assenze che come un fil rouge percorrono l’opera tutta di Jaeggy. Ancora, la perdita e il lutto, l’incomunicabilità dentro i rapporti, la morte, il suicidio talvolta, che tornano nelle pagine di Sono il fratello di XX, un altro sguardo ancora sulla protagonista senza nome del primo romanzo, sulle vite intrecciate alla sua, i misteri almeno in parte svelati.
Le «vite sbagliate» cui Jaeggy dà forma sono intrise di mancanze, dolore, un vuoto riflesso come si diceva dalle profondità della narrazione, dalla sottrazione, che trova massima espressione nel racconto breve, brevissimo, ma che in fondo è un modo proprio di guardare e sentire una storia, fotografandone un certo dettaglio, lavorando ossessivamente sulla parola, mostrando le increspature della superficie; un’attitudine che si rivela anche nei romanzi – se possiamo considerarli davvero tali o non più propriamente novelle. Che racconti un frammento o una vita intera – per esempio nelle Vite congetturali di De Quincey, Keats e Schwob – riconosciamo quella particolare lente con cui lo scrittore di racconti osserva il mondo e ne ricrea un dettaglio.
Tra le pagine di Jaeggy non c’è consolazione, ma nutrimento per quel demone della scrittura che tanto ci ossessiona.