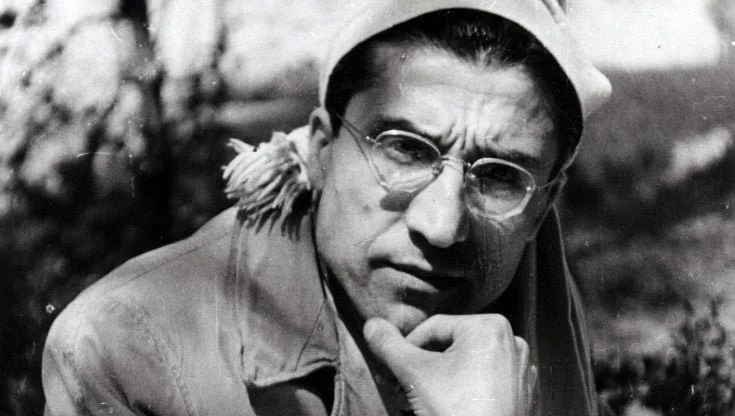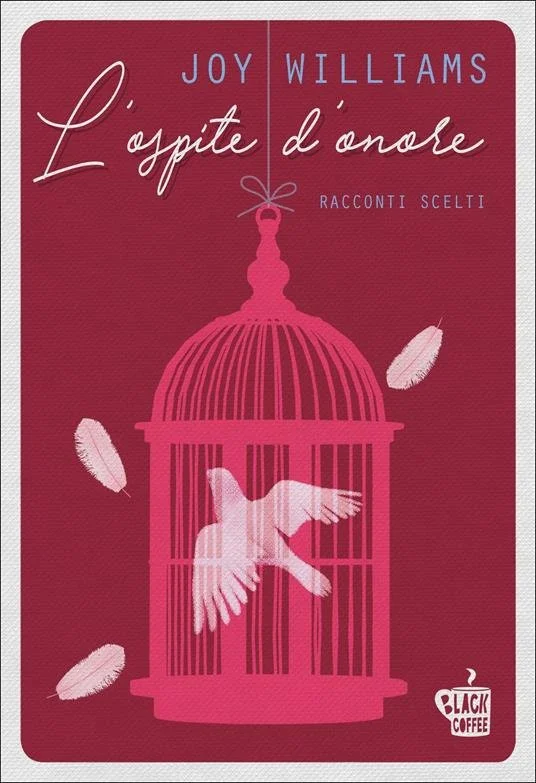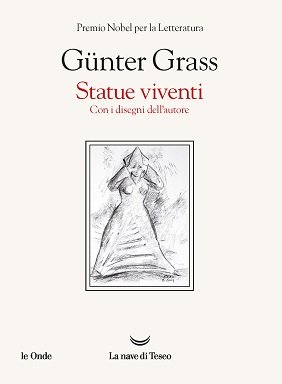Con Edicola, parte la nuova rassegna estiva Storie senza scadenza, in cui proponiamo racconti, e quindi libri, non più freschi di pubblicazioni, nella assoluta convinzione che i libri non abbiano scadenza e che hanno bisogno di tempi più lenti e duraturi di fruizione, proposta e vita nel sistema editoriale.
Come primo titolo vi proponiamo un racconto tratto dalla raccolta Gli azzardi del corpo di Maria Ospina Pizano, tradotta da Amaranta Sbardella e pubblicata nel 2020.
Sullo sfondo di una Bogotá caotica e attraversata da forti diseguaglianze sociali, la scrittrice colombiana - tradotta per la prima volta in Italia - sceglie nell’universo delle relazioni femminili quelle più asimmetriche e inusuali per raccontare sei storie di donne che cercano di salvarsi le une con le altre, il più delle volte fallendo. Una raffinata geografia degli affetti, autentica e spietata, dove la cura e il senso di protezione si alternano all’ossessione e al tradimento, e dove il corpo femminile rivendica, e trova, nuove forme e nuove circostanze per essere raccontato.
So I’m left to pick up
The hints, the little symbols
of your devotion.
Antony Hegarty, Fistful of Love
“Aspettati eccitanti novità, che arriveranno in modo imprevisto.” Questo aveva pronosticato l’oroscopo a Estefanía mentre aspettava nell’ospedale vuoto, in un sabato di agosto. Sulla rivista dove lo aveva letto compariva anche una notizia dal titolo “L’universo sta lentamente morendo”. Ciò nonostante, poiché le era parsa angosciante e ovvia, si era rifiutata di leggerla. Seduta dietro al bancone, Estefanía si perforava un lembo di pelle sollevatasi da una vescica al piede con un grosso ago che aveva trovato nella cassetta dei bisturi e degli strumenti di sutura, e nel frattempo si chiedeva se la notizia, quella delle sorprendenti novità, si riferisse al viaggio a New York. Forse sì, sebbene lei non avesse mai voluto credere all’oroscopo pur di fare la bastian contraria con la madre, che era sempre stata una fanatica dell’astrologia da rotocalco. Nel momento in cui si rimise le scarpe, si rimproverò per essersi fatta trascinare dall’entusiasmo passeggero di quella mattina serena e non aver indossa to le calze. Una volta conclusa l’operazione, passò uno straccio sul bancone di vetro sotto il quale riposavano scarpette, cappelli e accessori da bambola, nonché diversi animali di peluche appena operati, che nelle buste di plastica attendevano i legittimi proprietari. Proprietarie, anzi: erano quasi sempre loro a entrare nell’ospedale, anche se ormai con una frequenza via via minore.
Prese le sei vecchie bambole dalle buste e le adagiò in fila in attesa dell’elegante signora che le aveva fatte ricoverare all’inizio della settimana e che aveva richiesto per loro svariati interventi chirurgici. Ancora nude, irradiavano una dignità scolpita dai decenni. Pur senza i vestitini inamidati di faille, lamé e trine, pur senza le scarpette in velluto e lino con cui erano arrivate, esibivano le loro cuciture e i loro punti di sutura con discreta vitalità e soddisfacente orgoglio.
“Ho invitato alcune amiche a un tè speciale, al quale dovranno portare le loro bambole di infanzia. Le hanno ancora quasi tutte, ben custodite. Visto che siamo così vecchiette, sarà proprio una bel la mostra di cimeli.” Così le aveva detto la signora sciogliendo i fiocchi alla scatola piena di bambole ferite.
Estefanía si immaginò un grande banchetto di anziane dai profumi costosi e dalle pettinature ordinate, che in un ampio salone rimpinguavano le morbide carni con succulenti dessert, mentre i corpicini rigidi delle bambine perenni, adagiati su minuscole sedie, evita vano i loro sguardi. Forse ogni signora avrebbe raccontato la storia di ciascuna bambola, come le era arrivata e fino a quando si era protratta la sua fiducia in lei, fino a quando era stata convinta che possedeva un’anima. Forse nel parlare delle bambole avrebbero modulato il timbro e la cadenza delle parole, e la vivacità delle voci infantili avrebbe interrotto per qualche tempo l’aridità di quelle gole vecchie. E le bambole lì, a scansare senza indulgenza ogni attimo di contemplazione.
“Lei ha un vero tesoro, signora. Ne capisco io di bambole, mi creda, perché sono cresciuta in questo ospedale e ho visto di tutto.”
Nel voluminoso Registro dei ricoveri, dove venivano conservate le diagnosi e le operazioni avvenute negli ultimi quindici anni, Estefanía annotò i sintomi che la signora le descriveva. Accanto all’impeccabile grafia del nonno e della madre, gli addetti al registro prima di lei, le sue lettere sembravano goffe e profane.
“A Leonor, che era la bambola di mia cugina Leonor, andrebbe sistemata la faccina, perché si sono sbiaditi i colori degli occhi e del le labbra. Sebbene le tenga al sicuro e riposte perché non me le tocchi nessuno. Sotto il mio letto e avvolte nella carta velina. Beatricita, questa con i capelli corvini, ha un braccio rovinato. Bisognerà cambiarle il lattice, immagino. Ingrid non è così antica, ma era la bambola dell’amica tedesca di mia figlia, e ho commesso l’errore di lasciarla qualche volta alle mie nipotine. Guardi i suoi capelli, così irregolari, le bambine glieli hanno tagliati, guardi che scempio. Che disastro. Ha bisogno di un innesto di capelli. Per favore, di un materiale di qualità.”
“Non si preoccupi, ho i capelli che fanno al caso suo. Ne abbiamo alcuni francesi di importazione che mio nonno si era procurato tempo fa, quando ancora li fabbricavano. E sono proprio così, della stessa tonalità chiara.”
“Perfetto. Glieli lasci lunghi, fino alle spalle. Non importa quanto mi verrà a costare, basta che siano a tono con la pelle. María Inés, guardi questa meraviglia di bambola, è inglese, di inizio secolo, e guardi bene, vede? Ha un gancetto qui sulla schiena, se uno lo muove, dice sì o no. Guardi, guardi come dice no, no, no.”
Estefanía imitò la risata della donna. Da tanto non si poteva ridere così, sulle cose prosaiche di cui la gente rideva con gusto, come se racchiudessero una battuta indimenticabile.
“Bene, che ha questa meraviglia? Ecco bisognerebbe sistemarle il dito scheggiato. E ridisegnarle le unghie. E guardi Shirley Temple.
Me la regalò mio padre quando vivevamo in Inghilterra, e Shirley Temple era appena arrivata al cinema con un film, uno dei primi che fece da bambina. Be’, ma lei non saprà chi era Shirley Temple. Una enfant prodige, famosissima negli anni trenta. Divina, con certi boccoli dorati, proprio come questa. All’epoca in cui diventò famosa, uscirono alcune sue bambole che fecero furore. Non dimenticherò mai quando aprii la scatolina bianca, e dentro c’era lei. Per poco non mi venne un colpo dall’emozione. Questa sì che è da veri intenditori. Bisogna rimetterle a posto la gamba, è ruotata dall’altra parte. Di sicuro sono state le bambine, l’avranno presa dalla scatola senza chiedermi il permesso.”
La vecchia afferrò la gamba con una certa violenza e la spinse verso il centro.
“E la bambola araba, o meglio, non so di preciso se è gitana o araba. Questa è proprio un gioiellino, guardi che rifinitura. È francese. Era della mia amica Lucía, che per un periodo aveva vissuto a Vienna. Doveva avere un nome strano ma quando Lucía me la diede poco prima di morire non se lo ricordava più, e allora l’ho battezzata Lucy. Quella volta mi raccontò che, al suo ritorno lungo il fiume Magdalena, se ne stava sul parapetto della nave e le mostrava la rotta. Allora il Magdalena sì che era un signor fiume, una meraviglia. Non era ancora la fogna di adesso. L’avrà capito, Lucy ha visto di tutto, dalle cupole della Senna alle scimmiette e i cervi del Magdalena. Un gioiello tra i gioielli. Dovrebbe fare qualcosa per le dita dei piedi, che sono danneggiate. E le rimetta a posto quest’occhio, vede che si sposta da un lato?”
Estefanía le aveva promesso di restituirgliele sistemate per il sabato, prima di mezzogiorno, in modo che potessero partecipare al tè del lunedì successivo. “È un sollievo che sia riuscita a venire. Passo qui davanti da più di un anno, e ogni volta penso che dovrei entrare, ma ci sono riuscita solo oggi. Finalmente ho potuto trovare del tempo da dedicare alle mie amiche. È così che le chiamo, le mie amiche, per via di tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Ne ho salvate diverse dalle amiche in carne e ossa, che non sapevano più che farsene. Le avrebbero lasciate alle donne delle pulizie, si figuri.”
Mentre aspettava la proprietaria delle bambole più raffinate mai accolte alla Clínica de Muñecos Reyes da quando la Barbie e altri esemplari cinesi avevano invaso il mercato della capitale, Estefanía pensò a come sarebbe stato lavorare da colf al servizio di una donna della levatura di doña Cecilia. Avrebbe dovuto indossare un’uniforme azzurro pastello con un grembiule inamidato e for se si sarebbe vergognata di uscire in strada con quella indosso. In cucina, avrebbe osservato di nascosto i pasti della signora dalla finestrella. Avrebbe sbocconcellato gli avanzi del tè quando fossero tornati semidistrutti, e avrebbe finito di rovinarli. Probabilmente si sarebbe ingozzata di qualche dolcetto, prima e dopo il suo viaggio per la grande tavolata. Cercò, senza però riuscirci, di immaginare come sarebbe stato lavorare da colf al servizio di una donna della levatura di doña Cecilia, ma a New York. Lì quel tipo di signore avevano più soldi e chissà quali abitudini. Forse le stesse. Al lora ricordò l’oroscopo della rivista. Magari le pronosticava davvero l’imminenza del viaggio a New York. Magari prevedeva che dal nulla si sarebbe materializzato un buon acquirente per l’ospedale. Che le avrebbero concesso un visto. Si impose di credere che le fioche lettere di un oroscopo avessero un tale potere.
Estefanía aveva promesso alla cugina Shirley che avrebbero festeggiato insieme a New York l’Halloween seguente. Non glielo aveva detto perché ne fosse convinta, bensì perché lo desiderava. Sarebbe stato il primo Halloween insieme da quando Shirley se ne era andata a vivere là, due anni prima, appena aveva finalmente ottenuto i documenti della residenza che il padre aveva chiesto per lei dieci anni prima. Estefanía aveva riferito a Shirley di aver già pensato a un travestimento per la festa. Si sarebbe mascherata da cane randagio. Avrebbe lasciato i capelli sporchi e avrebbe provato a farsi dei nodi nella chioma crespa perché sembrassero simili alle ciocche degli afroamericani.
“Mi metterò un cartello al collo con scritto Ciao, sono un cane randagio.”
Shirley le aveva detto che a New York non c’erano cani randagi. Che nessuno avrebbe capito il suo travestimento. Che avrebbe per so un sacco di tempo a spiegarlo e la gente avrebbe pensato che era matta. Che non fosse così deprimente.
“Ciao, zia, sono al lavoro. Vado di fretta perché sta per venire una signora a riprendersi un ordine. Mi ero dimenticata di dirtelo: una collezione di bambole antiche, una cosa stranissima. Queste bambole sono straordinarie, un incanto. A vederle restaurate così, nonno sarebbe morto per la commozione. Sì, oggi chiudo a mezzogiorno. Bene, sono felice se mi vieni a prendere, e ti accompagno, certo. Non vedo l’ora di vedere il tuo nuovo look.”
Zia Martica, la mamma di Shirley, aveva promesso di passare a prendere Estefanía al ritorno dal carcere, dove era andata a trovare la sua cliente più viziata, un’imprenditrice arrestata per aver dato in prestito il proprio magazzino a chi ci aveva stipato le materie prime necessarie a produrre cocaina. Grazie al duro lavoro di anni, Martica era divenuta la manicure e la massaggiatrice di una lunga lista di clienti. Si occupava di unghie, mani, massaggi tonificanti e dimagranti, secrezioni e segreti. Di massaggio in massaggio, e dopo anni passati ad allenare le braccia robuste e il corpo farcito al fine di accogliere piedi e mani altrui, Martica era riuscita a risalire i gradini della trionfante classe media. Gli affari andavano talmente bene che si era potuta permettere di pagare la retta scolastica di Estefanía, dopo che sua madre era morta, e, poiché la nipote si era appena diplomata, le aveva promesso che avrebbe contribuito al viaggio per studiare inglese a New York. Shirley si trovava già lì e, grazie all’offerta di Martica, Estefanía coltivava l’illusione di andarsene, almeno per qualche tempo.
Quel pomeriggio Martica avrebbe svelato a Estefanía il suo nuovo volto. Il ritorno a una certa gioventù. Da un paio di settimane, in occasione del compleanno, la chirurga plastica che consigliava al le sue clienti per la liposuzione le aveva regalato una nuova faccia. Al posto del lifting gratuito che la dottoressa le aveva proposto all’inizio, mentre dormiva beata nella pace dell’anestesia, Martica aveva ricevuto un regalo ancor più grande. La chirurga le aveva scolpito un viso più scarno, con il nasino all’insù, gli zigomi più affilati e la mandibola meno squadrata. Un viso gradito, anche se non richiesto. Dopo due settimane di recupero Martica aveva ancora un paio di bendaggi alla testa, ma si era quasi sgonfiata. Non appena fosse stata pronta a mostrarsi di nuovo al mondo, voleva che una delle prime a vederla fosse Estefanía.
Una volta finita la rivista degli oroscopi, Estefanía aprì il Don Chi sciotte del nonno che aveva sempre occupato lo scaffale vicino ai libri della contabilità. Aveva deciso di leggerlo la settimana dopo il diploma, ma in modo superficiale, scegliendo a caso i capitoli. Da bambina, quando trascorreva il sabato all’ospedale, il nonno le raccontava cosa succedeva nel capitolo che stava leggendo. Spalancò il libro al capitolo intitolato “Di ciò che avvenne a Don Chisciotte entrando a Barcellona” e si convinse che era un altro segnale del suo futuro viaggio in luoghi a lei ignoti. Suonò ancora il telefono, e pensò che si trattasse della signora delle bambole, che la avvertiva di un impedimento. Stava per chiudere, in effetti. Tuttavia, sentì la voce grave e compassata di un uomo dallo strano accento. Chiedeva del la Clínica de Muñecos Reyes. Spiegò che chiamava dagli Stati Uniti. Che lavorava per la chiesa Saint Ignatius of Antioch di New York, e che aveva trovato i dati dell’ospedale su internet dopo la segnala zione di un’amica colombiana.
“Sto cercando di comprare parti di manichini e bambole antiche per il nostro altare.”
Estefanía provò ad adattare la voce al suo tono più formale. Spiegò che lì si limitavano a riparare peluche e bambole per bambini. Lo poteva aiutare a mettersi in contatto con alcuni antiquari del quartiere, però. “Be’, in realtà io cercavo santi coloniali, ma non mi interessa soltanto questo. Cerco anche bambole antiche di ogni tipo, e pure parti o pezzi sfusi. Forse lei può aiutarci.” Promise una buona remunerazione.
Estefanía disse all’uomo che forse aveva qualcosa di suo gradi mento. Doveva prima fare un controllo. Annotò l’indirizzo e-mail per scrivergli una lista e mandargli le relative foto. Antonio Pesoa tradiva un accento argentino e una voce davate ascetico che sembrava riemergere da ere trascorse ai confini di una piccola grotta.
Prima di chiedersi se la telefonata fosse uno scherzo, Estefanía pensò ai dollari che l’affare prometteva. Alla possibilità di liberarsi finalmente da quell’eredità di arti, occhi e capelli che il nonno aveva lasciato alla madre, e la madre a lei e al fratello. Avevano già avvertito Juvenal della prossima chiusura dell’ospedale e Martica gli stava cercando lavoro da un’altra parte. Prima o poi il laboratorio sarebbe stato venduto. Se le avessero concesso il visto, finalmente lei sarebbe andata a New York. Avrebbe visto Shirley, avrebbe iniziato il buon corso di inglese che questa le aveva trovato nel Queens. Avrebbe imparato la lingua. Sarebbe rimasta a vivere lì e avrebbe atteso con ansia le visite di Martica due volte all’anno. Avrebbe cominciato a credere negli oroscopi. Nel retro del negozio un orso di peluche, una bambola con il naso corroso e una Barbie dai capelli rossi senza una gamba attende vano l’intervento di Juvenal. Estefanía spinse la porta con forza, e per la prima volta dalla morte della madre entrò nel piccolo deposito alla fine della sala. Sopra la cassapanca sulla sinistra le targhette dei cassetti, annotate con la grafia elegante del nonno, recitavano: “antichità”, “parti porcellana”, “vestiti”, “volto”, “religiosi”, “scarpe”. Dall’altra parte della stanza c’era un vecchio bancone con una pila di braccia, gambe, torsi, e borse con diverse teste bionde, teste di orsi e cani di peluche, mani, bacini in plastica di differenti tonalità color “pelle”, eufemismo per indicare la pelle bianca con cui erano dipinte le bambole che circolavano tra le mani dei bambini bogote si. In un angolo, alcuni rotoli di stoffa e uno di materiale per peluche sprigionavano odore di naftalina.
“È proprio vero che non ha mai buttato niente.”
Quando Estefanía alzò il primo braccio della pila di resti amputati, un grande occhio cadde rotolando sulle mattonelle rosse fino all’altra estremità della stanza. Si chinò a prenderlo e notò l’iride dalle screziature verdi e nere. Il vetro si era graffiato legger mente, ma solo nella parte posteriore, così da non rivelare il difetto una volta all’interno della testa di una bambola. Estefanía riconobbe l’antica tecnica di pittura su vetro. Quegli occhi erano ormai in trovabili. Quelli di adesso non erano più tridimensionali, né estrai bili, bensì banali disegni su plastica che privavano le bambole della libertà di uno sguardo laterale, che proibivano alle loro pupille di muoversi nervosamente per incontrare o schivare quelle del la piccola proprietaria. “Gli occhi di adesso viziano i bambini,” pensò. Promettevano loro la certezza di uno sguardo sempre pronto ad aspettarli. Infondevano loro la speranza di essere sempre speciali. Per questo lei non avrebbe avuto bambini. A New York quell’occhio di tempi ormai andati le avrebbe potuto fruttare qualche dollaro. Lo ripose nella tasca mentre andava verso i cassetti della cassapanca per controllare cosa contenessero.
Nella scatola con scritto “antichità” trovò tre bambole avvolte nel la carta velina, che prese con estrema cautela. Ne venne fuori una bambolina in gesso grande quanto il suo avambraccio, con i capelli neri, il viso rotondo e una bocca a forma di ‘o’, le gote rosa e la pelle immacolata. La copriva uno scialle dalle fattezze antiche, abbinato al vestitino. Sembrava un’energica ambulante della piazza del mercato di un villaggio andino, eppure sull’etichetta che le scendeva dalla mano Estefanía lesse “Germania, 1870”. Quindi scartò una bambola nuda, con le parti pubiche in olona e le parti pubbliche della porcellana più raffinata. Dal torso soffice pendevano le gambe, prossime a scucirsi, che diventavano di porcellana dalle ginocchia sino ai tacchi neri. Le braccia erano in buono stato, a eccezione della crepa sul palmo di una mano e di un dito rotto a metà. Le labbra si arricciavano in una smorfia e lasciavano intravedere i denti. Aveva occhi celesti e lunghe ciglia, capelli scuri dipinti sulla testa all’altezza delle orecchie, alla maniera della sua epoca. “Francia, 1918”. Malgrado le membra nude e l’anonimato di decenni trascorsi dentro un oscuro cassetto, non svelava niente di sinistro. Sembrava diligente, e anche ben educata. Infine Estefanía tirò fuori un bimbetto androgino avvolto in un involucro di trine che lo copriva sino alla testa, formando una sorta di magnifica corona. L’unica parte visibile del corpo era il capo. “Gesso bisque” riportava la targhetta scritta dal nonno. Campeggiavano il volto circondato dal merletto due brillanti occhi grigi, spalancati e lambiti da lunghe ciglia che preannunciavano un futuro di intense sofferenze. “Vienna, 1901”. Il bambolotto implorava di uscire a passeggio con una bambinaia di una città di un’altra epoca. Sotto Natale avrebbe sicuramente potuto impersonare il Bambin Gesù in una chiesa di Manhattan.
Nella lista che Estefanía mandò all’argentino bizzarro figuravano anche altri articoli antichi collezionati dal nonno.
* Corpo infantile senza testa, Bisque, taglio su una gamba e piccolo buco su un tallone. Gomme intatte. Di razza nera. Grassottello. Etichetta dice “Francia, 1926”.
* Pezzi sfusi: 1 paio di occhi dipinti su superficie di legno, iride celeste e pupilla di vetro. Quattro paia di occhi di vetro, di versi colori. Un occhio sfuso leggermente graffiato nella parte posteriore. 1 paio di braccia di ceramica con estremità di pezza. 1 paio di piedi in legno, media lunghezza. 1 paio di piedi in gesso (5 cm di lunghezza).
* Varie: flaconcino profumo di vetro azzurro, calzini di filo ricamato per bambola di grandi dimensioni, ventaglio in miniatura pieghevole di avorio con disegni floreali, guanti in pelle bianca con ricami neri, specchietto di metallo, album di ricordi per bambola con fodera in pelle del quale si possono aprire le pagine, corsetto di cotone e merletto con nastri azzurri per bambola di media grandezza, cagnolino di compagnia in porcellana con filati di peli color marrone, bocca spalancata e lingua dipinta che si vede dentro la bocca.
“Vieni e guardami, piccola mia, così mi dici cosa ne te ne pare.”
Estefanía sentì la voce di Martica dal magazzino e le andò incontro.
“Che bella!” “A volte mi viene da pensare che questa faccia da matrona contra sti con il mio corpo.”
“Stai molto bene, zia.”
“Manca ancora un po’ perché si sgonfi del tutto, e ti sembrerò una di quelle bambole eleganti che ti hanno portato.”
Quando si sedette nella macchina di Martica, Estefanía sentì che la tasca del pantalone le incideva la gamba. Era l’occhio di vetro che non aveva avuto il tempo di lasciare nella pila di bambole antiche per poter correre incontro all’altra bambola della sua vita.
Estefanía aspettò per tutta la settimana che la signora venisse a riprendersi le bambole. All’ospedale giunsero alcuni lavori che lei di resse con grande efficienza e che mantennero occupato Juvenal: un orso di peluche alto un metro che vomitava gommapiuma da uno squarcio nella spalla, tre bambole pusillanimi che si erano recate in un salone di bellezza infantile ma alle quali non si addiceva la cresta punk, una bambola che faceva pipì e aveva bisogno di un nuovo tronco perché la proprietaria le aveva distrutto l’originale versando acido disgorgante nel canale interno, dalla bocca al pube. Tuttavia, le bambole eleganti rimasero sul bancone senza aver preso parte al tè della signora. Poiché era incline ai pensieri tragici, Estefanía si immaginò la donna dentro una bara, immobile in un rigor mortis di nostalgia. Il venerdì decise di chiamare al numero di telefono che aveva annotato sulla ricevuta. Le rispose la donna delle pulizie, la quale le spiegò che la signora aveva lasciato la città per un tempo indefinito. Estefanía chiese cosa dovesse farne delle bambole, e le disse che presto, e per sempre, avrebbero chiuso l’ospedale. “Doña Cecilia è in una casa di riposo dal weekend scorso. Il figlio è venuto dall’estero a portarcela. Mi ha dato l’ordine di dire che starà fuori per un po’. Che ora non riceve telefonate. Chiedo io per le bambole. Chiami la settimana prossima e le dirò qualcosa.” Estefanía vide attraverso il vetro del bancone le faccine delle bambole nelle buste di plastica e capì che doveva salvarle: non meritavano di starsene nella vetrina scheggiata per altro tempo.
Estefanía,
ricevere la sua risposta ci ha dato un’immensa allegria. Siamo interessati a comprare tutto quello che ci propone. Anche se alcuni degli oggetti che menziona non hanno tema religioso, ne abbiamo lo stesso bisogno. Possiamo offrirle 300 dollari per tutto l’inventario. Nel caso in cui fosse interessata, dobbiamo soltanto accordarci sulle modalità di spedizione fino a New York. Questa settimana controllerò le differenti possibilità e le farò sapere. Mi piacerebbe venire a prendere tutto di persona, a Bogotá, ma sarebbe un’utopia. Rimango in attesa di una sua risposta.
Antonio Pesoa
Cara Estefanía,
nella e-mail precedente ho dimenticato di chiederle se, tra gli oggetti in vendita, ha pure delle bambole da ventriloquo. Mi dica di sì! La prego di avvisarmi appena possibile.
Dopo aver chiamato per due settimane al numero di doña Cecilia senza ricevere risposta, Estefanía concluse che doveva trovare una nuova casa alle bambole in esilio. Aveva cercato l’indirizzo della signora per portargliele di persona, eppure il suo nome non compariva nell’elenco telefonico. Forse la vecchia era stata così esplicita riguardo alla storia di ogni bambola perché gliele stava lasciando in eredità. Chissà se le sarebbero tornate in mente nello stupore narcotizzato dei tramonti della casa di riposo e se tutti avrebbero pensato che i nomi da lei evocati invano non fossero altro che un ulteriore sintomo del suo malessere.
Dopo altre due settimane di attesa e di telefonate senza risposta, Estefanía accettò le bambole come un’eredità indiscutibile. Quella notte le sognò, tutte e sei, vestite da sante, che decoravano la pala di un altare coloniale bagnato nell’oro. In ognuno degli scomparti del retablo c’era una bambola con la sua tunica inamidata da santa, il mantello e il rosario tra le piccole dita appena riparate da Juvenal. Arrivava Antonio, integralmente vestito di nero e con un copricapo di lana sulla testa calva. Incedeva fluttuando, come tirato da una cordicella leggera legata all’addome. Si inginocchiava sulla prima panca. Estefanía entrava nella chiesa e provava ad avvicinarsi alla pala d’altare, ma un prete furibondo la scacciava in malo modo in un inglese incomprensibile. Antonio non diceva niente, si limitava a guardarla, commosso, ed Estefanía piange va vicino al signore lebbroso che chiedeva l’elemosina sulla porta appestata di pipì, e solo allora capiva di trovarsi nella chiesa di San Francisco, nel centro di Bogotá, dove il nonno la portava da bambina.
Cara Estefanía,
è perfetto se riesce a farci avere il materiale la settimana prossima, tramite sua zia. Dovrebbe essere ben imballato perché non si rompano i pezzi, sono talmente delicati. Gli occhi sfusi! Certo che li vogliamo. E la vicenda delle sei bambole ci lascia senza parole. Se le va bene, gliele potremmo pagare 400 dollari. Saranno sicuramente dei capolavori rarissimi, perché così rare sono le cose di cui fare tesoro. Gioielli al di sopra di qualsiasi classificazione.
Che risplenda quanto deve risplendere.
Mi piace l’idea di queste bambole frivole su un altare.
Morirei per tenere tra le mani una bambola coloniale da ventriloquo. Sono molto difficili da trovare. Ho intenzione di proporre ai preti una sorta di performance religioso-didattica tra il ventriloquo (mascherato da santo, o da vergine) e la sua bambola (che potrebbe farsi passare per angelo, un’anima, o qualcosa del genere).
Posso venire a prendermi il pacco e darei i soldi a sua zia, come mi suggerisce. Le lascio il mio numero di telefono, perché mi contatti al suo arrivo a New York: (212) 945–3850.
La prego di scrivermi e di tenermi al corrente. Un enorme abbraccio.
P.S.: Grazie per avermi raccontato il suo sogno. Se dovessi sognare qual cosa di così brillante, nella mia versione io assalterei il prete, lo legherei dietro una colonna, lo costringerei all’harakiri e porterei lei a vedere le bambole ormai santarelle e il ventriloquo che recita la parte dell’anima. Non mi prenda sul serio, però. Non dormo da giorni.
Una pioggerella sottile imperlava la città, nella mattina di settembre in cui Estefanía prese dal bancone le bambole di doña Cecilia, sciolse i nodi delle buste e le portò su uno dei lunghi tavoli della sala operatoria. Juvenal lavorava sull’altro tavolo, intento a cucire un nuovo paio di orecchie a un gigantesco San Bernardo. Una dopo l’altra, le bambole si lasciarono coricare. I corpi nudi ne tradivano la nuova precarietà. Estefanía andò nel magazzino, aprì il cassetto con la scritta “vestiti” e tirò fuori un fagotto di panni avvolti nella carta velina. A Leonor cadeva a pennello il vestito di raso azzurro con la crinolina. La tunica di trina era per Beatricita. L’abitino a pieghe con le maniche corte sembrava perfetto per Ingrid. E sopra, il cappottino di panno bianco. Recuperò qualcosa per ognuna di loro, in modo da mandarle ben coperte, perché non fossero soltanto meravigliose dentro. Ci avrebbe poi pensato Antonio a trovare per loro dei vestiti adeguati all’altare. Dalla scatola degli oggetti religiosi prese dei minuscoli rosari in legno di rosa e di arancio, e ne mise uno al braccio di ciascuna. Le avvolse separatamente nel pluriball e le adagiò nelle scatoline che si era procurata per il viaggio. Quindi spolverò e impacchettò le altre bambole del magazzino e le parti sfuse che aveva promesso ad Antonio, sistemandole tra carta e gommapiuma.
Estefanía accompagnò Martica all’aeroporto quando a Bogotá aveva appena cominciato ad albeggiare. Martica andava a New York nei due periodi di saldi dei grandi magazzini. Partiva leggera e tornava con due valigie piene dei vestiti che le avevano ordinato le sue clienti bogotesi e che lei rivendeva in cambio di una percentuale, con cui rientrava delle spese del viaggio e ingrossava il libretto di risparmio. Prima dormiva dalla sorella, quella che assemblava i minuscoli pezzi di motori di aereo in una fabbrica nel New Jersey, ma da quando Shirley si era trasferita a New York alloggiava nel nuovo appartamento della figlia.
Mentre Martica avanzava nella lunga fila del check-in, i due pacchi nei quali viaggiavano le bambole e gli altri articoli per Antonio vennero selezionati per un controllo della polizia antidroga. Un poliziotto avvicinò loro un giovane cane che dimenava forte la coda alla ricerca della polverina costosa. Le guardie lo aizzavano a trovare la cocaina, ma il cane non mostrò alcun interesse. Per fugare ogni dubbio uno dei poliziotti prese la bambola araba dalla scatola, la spacchettò, si leccò l’indice, lo sfregò contro la gamba della bambola e se lo rimise in bocca. Poiché non sentì il sapore dell’alcaloide che credeva diluito nella pelle delle bambole, diede l’ordine di richiudere tutto. Un paio di giorni dopo Martica chiamò Estefanía per confermarle che aveva consegnato le scatole ad Antonio e che aveva il denaro. “Mi ha detto solo Grazie, signora, e ha aggiunto che avevo una nipote dolcissima. Che ti voleva conoscere, tesoro mio.”
Incoronata, vittoriosa,
(è l’etimologia del suo nome, lo sapeva?). Malgrado gli ostacoli, ho ricevuto le meraviglie che mi ha mandato. Se fossi stato un poliziotto aero portuale le avrei sequestrate tutte, senza il pretesto di un cane, e mi sarei dato alla macchia. Può stare serena, i tesori di suo nonno riceveranno i giusti onori. La bambola che muove la testa sì-e-no è arrivata con una mano ferita. È stata lei a essere annusata dal cane? Chissà come avrà turbato il suo olfatto.
Ieri ho pensato a lei, Estefanía, e alle questioni della carne, perché per poco in palestra non amputo il dito a una vecchietta. Stavo facendo i pesi e la vecchietta ci ha infilato la mano: le ho rotto il dito. Abbiamo dovuto chiamare l’ambulanza. Le era diventato una poltiglia. L’ha messo proprio nell’ingranaggio. È schizzato sangue per tutta la palestra, e non è stato poi troppo male perché la gente impegnata a guardarsi allo specchio ha dovuto fare una pausa per guardare in faccia la realtà. L’ambulanza è arrivata dopo quaranta minuti e non scendeva nessuno. Vado a vedere e la ragazza che guidava era tutta presa a passarsi il lucidalabbra. Insomma, inconvenienti della vita atletica, mio Dio. Per fortuna la vecchina è stata piuttosto stoica. Ma perché mai una persona dovrebbe ficcare la mano in un meccanismo che sale e che scende? Le ho detto “I’m sorry” una volta e non ci rimetterò più piede. E pensare che mi trascinavo in palestra da un paio di settimane. Tutto per colpa di uno dei tizi che vendono macchinari da ginnastica alla televisione. Il tizio ha una massa amorfa di resina schifosa, secondo lui è puro grasso, e la chiama “signor grasso”, e ti ripete allo sfinimento che ce l’hai pure tu, dentro di te. Lo ha visto? Mi ha fatto talmente schifo che ho pagato un anno di palestra. Dopo l’incidente con la vecchietta, però, non posso tornarci. Meglio stare qui in incognito, ad aggiustare la ferita alla mia bambola.
Sua zia mi ha detto che forse verrà presto a New York. La devo portare a prendere il tè, e ci mangeremo dei buonissimi dolcetti con il ripieno di pesca che vengono da una lontana isola dell’arcipelago nipponico. E parleremo di qualsiasi cosa. Presto le manderò le foto delle bambine ascetiche nella loro nuova casa. Mi scriva. Mi racconti qualsiasi cosa, mi fa piacere tutto. In questi giorni passo le notti in bianco, a tenere a freno i pensieri che mi rintronano di latrati come cani in fuga.
Grazie, regina.
Abbracci,
Estefanía rilesse l’e-mail. Si dispiacque che non fosse scritta a mano. La zia le aveva raccontato che Antonio era un uomo timidissimo, uno di quegli uomini che con il silenzio rivelano di sapere più di tutti gli altri. Lei pensò a un cavallo selvaggio delle steppe asiatiche, a un pino vecchio di quattromila anni, uno di quei pini che vivono ancora sulle colline del Medio Oriente. Doveva essere all’incirca così, Antonio.
La liquidazione finale della Clínica de Muñecos Reyes durò quattro settimane. La vendita del locale fu rapida e redditizia. Un’impresa edile stava comprando l’intero isolato per costruirvi condomini di appartamenti eleganti, come gli altri già eretti in tutto il Chapi nero. Mentre aspettava che gli arrivasse un lavoro da qualche cliente di Martica, Juvenal decise di mettersi alla guida del taxi di un parente. Estefanía tenne per sé gli oggetti che voleva conservare – al cune bambole, un paio di quadri con bambole europee sedute sulle panchine di parchi primaverili che la madre aveva appeso nella sala operatoria, la collezione di cappelli per bambole in mostra sul bancone, la targa del negozio e i registri della contabilità, nonché il Don Chisciotte. I mobili e gli articoli in eccedenza vennero donati a una fondazione scolastica per ciechi che distava un paio di isolati. Il resto se lo portarono via un rottamista e i riciclatori. Quando Estefanía chiuse l’ospedale per l’ultima volta, il giorno dopo averlo consegnato agli acquirenti, pensò che, qualora fosse tornata da New York e passata di lì, non avrebbe riconosciuto quell’angolo di strada sporco e in rovina della sua infanzia e ne avrebbe avvertito il vuoto.
Sull’aereo per gli Stati Uniti, mentre sfogliava le pagine bianche di un’agenda che Martica le aveva regalato perché vi annotasse i contatti e le amicizie della sua nuova vita, Estefanía tornò a farsi domande sul silenzio di Antonio. Non aveva ricevuto risposta al la e-mail che gli aveva mandato con i dettagli del viaggio, in cui gli scriveva che in un paio di settimane sarebbero potuti andare assieme a bere il tè giapponese, promettendogli inoltre di portargli un mango dolce perché per la prima volta provasse cosa significava aspirare la polpa succosa del frutto da una fessura nella buccia. Non aveva ricevuto risposta nemmeno alla seconda, nella qua le aveva copiato la precedente e gli chiedeva se l’avesse letta. E neppure all’ultima, scritta pochi giorni prima di arrivare nell’appartamento del Queens dove viveva la cugina Shirley. Forse Antonio si era scandalizzato per l’immagine della bocca che succhiava il mango dolce? Chissà, probabilmente lo aveva turbato nella sua rigida vita da celibe. Si era ricreduto sulle bambole borghesi, che Estefanía intuiva poco degne di un altare? O forse aveva avuto un incidente. Nella sua ultima e-mail Antonio aveva accennato a un dolore al petto, a una grande spossatezza e alla difficoltà nel respirare. Per questo gli stava portando un mango. Martica diceva sempre che non c’è niente di meglio del mango dolce per mantenere in forma il cuore.
Pian piano il frutto marcì nel frigo dell’appartamento di Shirley.
Qualche giorno dopo averlo gettato nell’immondizia, Estefanía si recò all’indirizzo che Antonio le aveva fornito in una delle prime e-mail. Prese la metro per Manhattan indicatale da Shirley e scese all’incrocio tra 23rd Street e Park Avenue. Percorse tutta la 23rd, e alla 2nd Avenue girò verso la 25th Street. Sorpassò una lavanderia, un pub irlandese, scale di palazzi, un negozio che declamava Christian Science Library, ma in tutto l’isolato non vide neppure una chiesa. Il civico 228 corrispondeva a un palazzo rosato con diversi piani di appartamenti. Estefanía continuò a camminare alla ricerca della chiesa più vicina, ma l’unica che scorse a un paio di caseggiati recava l’insegna For Sale. Ready for immediate occupancy.
Trascorse i successivi tre weekend a recarsi nelle chiese di Manhattan. Entrava quando le messe stavano per finire, esaminava l’altare e chiedeva a ogni prete se conoscesse Antonio Pesoa. Le prime chiese si trovavano vicino all’indirizzo che lui le aveva dato. Tuttavia, nelle sue indagini si allontanò sempre più dal quartiere e capì che avrebbe trascorso il resto dell’inverno a cercarlo chiesa dopo chiesa. E a cercare le bambole. La notte di Halloween, in occasione di una festa a cui andò con la cugina Shirley, si mascherò da cane randagio. Dei ragazzi del posto le chiesero di spiegare il suo travestimento, e lei indicò il cartellino che le pendeva al collo e che diceva: Hello. I am a street dog (woman), scritto nel suo nuovo e splendente inglese.
L’investigazione ecclesiastica venne improvvisamente interrotta a gennaio quando, durante una delle telefonate quotidiane, Martica le disse che era giunto un pacchetto da New York. Dentro c’erano una scatola avvolta nella carta da regalo, con disegni di mostri e caratteri in giapponese, e una lettera che le lesse per telefono.
Cara Estefanía,
le scrivo per avvisarla che Antonio Pesoa è venuto a mancare alla fine di settembre. Poiché sono l’amica incaricata di distribuire gli oggetti da lui lasciati, la informo che nel suo appartamento ho trovato questa scatola, pronta per essere spedita, e a lei diretta (all’indirizzo a cui la sto mandando, spero sia ancora il suo). Mi aveva parlato di lei il giorno in cui mi aveva mostrato le bambole antiche appena acquistate. (Ed ero stata io a dargli il contatto dell’ospedale di bambole perché da piccola ho vissuto da quelle parti per molti anni. Mia madre ci aveva portato tante mie bambole. È un peccato che non sia mai entrata, anche se avrei sempre voluto farlo). Antonio passava ore e ore con le bambole, rinchiuso nel suo appartamento. Negli ultimi mesi di vita è uscito di rado. Non ci voleva vedere perché si sentiva molto a disagio per la sua malattia, e perciò loro erano diventate la sua unica compagnia. Lavorava a una serie di foto di svariate persone sedute tra i pezzi sfusi e le bambole che gli aveva spedito. Tempo fa mi aveva detto che stava scrivendo un romanzo epistolare su un fuggitivo che si nascondeva in uno dei seminari del West Side e cercava articoli per i manichini della chiesa vicina. Nel romanzo compariva una ragazza che glieli mandava da lontano. Tra le sue cose non ho trovato il manoscritto ma, se comparirà, glielo farò avere. Mi preme farle avere questo, che le ha lasciato prima che il suo cuore si ribellasse.
Un abbraccio dall’amica di un amico,
Claudia Galindo
“Apri, zia, apri la scatola.”
“È un libro, piccola mia. Un libro antico in un’altra lingua che non so nemmeno che è.”
L’antico messale rilegato in pelle si poteva aprire solo in un punto, nel centro, perché le restanti pagine erano incollate. E lì, in un foro scavato tra le pagine, riposava tra i fiori secchi, al riparo di un vetro, la testa di una vecchia bambola. Una testa bruna, riposta in un libro delicato, cinta da caratteri sconosciuti e incomprensibili. Non appena il libro veniva aperto per metterla a nudo, i suoi occhi roteanti si muovevano nervosi da un lato all’altro.
Nella foto del regalo che le aveva poi inoltrato la zia, Estefanía riconobbe la testa di Lucy, la bambola araba portata all’ospedale dalla signora, la stessa bambola che aveva solcato la Senna e poi il Magdalena tra le braccia di una bambina elegante, fino alla rozza Bogotá degli anni trenta. La stessa che si era rifiutata di corrompersi nel transito per i caldi torridi di Honda, la stessa che era montata a dorso di mula sulle montagne e che per settant’anni aveva tollerato le attenzioni borghesi di due proprietarie. Fino a quando Estefanía e Antonio erano giunti a stravolgere i suoi giorni di pace e naftalina.
Che fine avevano fatto le altre bambole, i monconi di braccia, gli occhi sfusi che non avrebbero presieduto nessun altare? Dal giorno in cui aveva sepolto la madre, Estefanía aveva capito che i vivi non riescono mai a occuparsi degli oggetti che lasciano i loro morti. Stavano forse sugli scaffali degli amici di Antonio? Dietro le vetrine di un negozio di antiquariato? Finì per immaginarle addirittura in una discarica nei dintorni di New York, con le braccine tese che emergevano da una montagna di plastica, vecchie scarpe, buste di rifiuti, bucce di frutta, faldoni da ufficio e obsoleti schermi di computer. Estefanía pensò alle loro pupille che osservavano sprechi di silicone per impianti, siringhe, confezioni di yogurt, tupperware per la colazione. Gli occhi di vetro antico convertiti nel contenuto inerte della discarica in un Paese produttore di grandi rifiuti. Testimoni della di sintegrazione di tante ossa di ali di pollo che si rammollivano prima di loro. Degli occhi senza pubblico per riflettere la decomposizione.
La rasserenò pensare che la testolina della bambola bruna rimaneva al sicuro nella rilegatura in pelle verde di un antico libro venuto fino a lei a Bogotá.
“Zia, portamelo ora che vieni.”
Le sette Claudia Galindo che Estefanía aveva trovato su Internet – una giocatrice bogotese di beach volley, una cake designer messicana, un’avvocatessa del Canada, una professoressa di sociologia in Bolivia, un’attrice che viveva a Miami e altre di cui non era riuscita a capire la professione – non risposero mai alle sue e-mail.
A eccezione di due weekend in febbraio, durante i quali le tempeste di neve avevano paralizzato la città, Estefanía passò tutti gli altri sabati e domeniche invernali e primaverili a controllare i negozi di antiquariato che a Manhattan vendevano bambole. Quando le scadde il visto da studentessa, agli inizi dell’estate, dovette tornare a Bogotá, e ormai le mancavano soltanto nove negozi della lunga lista che aveva redatto. Dal suo altare pagano, Lucy rimase a sorvegliare i giorni nell’appartamento di Shirley. Estefanía promise a entrambe che non sarebbe stata via a lungo e ripose nel libro la lista di antiquari a cui non aveva ancora fatto visita. Per continuare a cercare le altre, non appena fosse tornata.