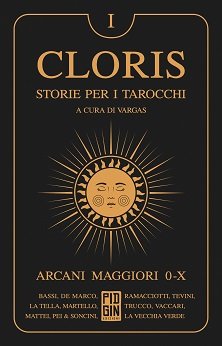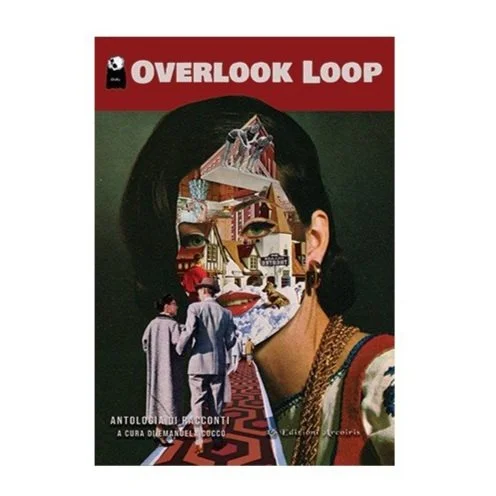Alter Ego porta in libreria Il Diamante del Rajà e altri racconti, tre racconti di Robert Louis Stevenson tratti dalla raccolta New Arabian Nights, pubblicata in due volumi nel 1882. Perfetti esempi del virtuosismo stilistico di Stevenson, capace di collimare con sagace caparbietà fantasia e sostanza morale.
Cattedrale vi propone uno dei racconti della raccolta, per gentile concessione dell’editore.
Il sire della porta di Malétroit
di Robert L. Stevenson
Denis de Beaulieu non aveva ancora ventidue anni, ma già si stimava uomo maturo e, per di più, compito cavaliere. I giovani, in quei rozzi tempi di guerre, si formavan presto: e quando uno aveva preso parte a una battaglia campale o a una dozzina di scorrerie, o aveva accoppato un uomo onorabilmente e sapeva qualcosuccia di strategia e darsi una cert’aria spaccona, era certo d’essere assolto.
Quella sera, governato con le dovute cure il suo cavallo e cenato di buon appetito, uscì, in ottima disposizione di spirito, per recarsi a far visita a un amico. Non era quella una risoluzione troppo prudente per un giovane. Avrebbe fatto meglio a restarsene bravamente accanto al fuoco o andarsene a letto: ché la città era piena di truppe borgognone e inglesi sotto misto comando, e, quantunque Denis possedesse un salvacondotto, era assai probabile che questo gli giovasse assai poco a trarsi d’impaccio, sventura volesse fosse stato aggredito. Era il settembre 1429. Il tempo s’era messo al brutto. Un vento leggero e fuggevole, con rovesci di pioggia, scorrazzava sibilando lungo tutto il territorio della città, e le foglie secche menavan riotta su per le strade. Qua e là qualche finestra s’illuminava, e il frastuono degli uomini armati, che dentro le case facevano chiasso sulle lor cene, usciva, a folate, subito inghiottito dal vento. Poi la notte calò rapida. Il vessillo inglese che sventolava dalla cima del pinnacolo divenne sempre più scuro su quello scenario di fuggenti nuvoli, una macchia nerigna, come di rondine sperduta là nel tumultuoso plumbeo caos del cielo. Caduta la notte, il vento raddoppiò di furore e cominciò a ululare sotto l’arcate e a muggire fra gli alberi della vallata che si stendeva sotto la città.
Denis de Beaulieu camminò svelto, e fu presto a picchiare alla porta dell’amico; ma quantunque si fosse proposto di restarvi assai poco per far presto ritorno alla sua taverna, l’accoglienza che gli si fece in quella casa fu così cordiale ed egli vi trovò tante occasioni per indugiarvisi, che mezzanotte era già sonata da un pezzo avanti che i due amici si salutassero dalla soglia dell’uscio. Nel frattempo il vento era caduto di nuovo, e la notte era divenuta nera nera come un sepolcro. Non una stella, non un barlume di luna trapelavano giù dal fitto padiglione delle nubi.
Denis era poco pratico di tutto quel dedalo di vicoli di Château-Landon. Già altre volte, di pieno giorno, aveva stentato a rintracciarvi la strada: ora, poi, con quel buio pesto, era interamente disorientato. D’una cosa sola era certo: che per ritornare a casa doveva risalire la collina, poiché la dimora dell’amico si trovava nell’estremità più bassa, nella coda, diremo, di Château-Landon, mentre la taverna dov’era alloggiato, era dalla parte opposta, sotto la guglia della cattedrale. Con questo unico punto di riferimento Denis andava innanzi, ciampiconi, brancolando nel buio, traendo larghi respiri quando arrivava su qualche spiazzato dove poteva scorgere una buona fetta di cielo sopra il suo capo, procedendo a tastoni rasente il muro quando si trovava a passare attraverso recinti chiusi e affogati.
C’è un senso di sgomento misterioso a ritrovarsi così ravvolti nella tetra opacità d’una notte come quella, in una città quasi sconosciuta. Il silenzio intorno ci atterrisce per tutte le possibilità che vi fantastichiamo: il contatto con la sbarra gelata d’una finestra ci fa trasalire come il contatto d’un rospo: gli avvallamenti e i rialzi del terreno su cui camminiamo ci fan balzare ogni tratto il cuore alla gola, nelle zone dove la oscurità è più fitta pare ci stiano ad attendere imboscate o fenditure: e anche là dove l’aria è più chiara, le case creano di strane e ingannevoli apparenze come volessero deviarci e spingerci lungi dal nostro cammino. Quanto a Denis che doveva raggiungere la taverna senza un indizio qualsiasi che gli mostrasse la via da tenere, i pericoli cui andava incontro eran gravi quanto lo sconforto che gli recava quel camminare balordo: e procedeva così, cauto, quantunque con coraggio, e, a ogni svolta, si fermava per guardarsi attorno.
Fino a quel momento il vicolo per il quale s’era messo era così angusto ch’egli poteva toccarne i muri laterali con ambedue le mani, ma, d’un tratto, questo si fece più largo e divenne ripido e scosceso. Era evidente che quella non era la direzione della taverna, ma la speranza di qualche luce in più lo consigliò a continuare per quella strada, onde riconoscere i luoghi. Presto il vicolo sboccò su di una terrazza la quale terminava in una costruzione murale fatta a mo’ di bertesca, donde, come da una feritoia, si poteva dominare, frammezzo ad alti caseggiati, la vallata che, oscura e informe, si stendeva parecchie centinaia di piedi sotto di essa. Denis s’accostò a quella torre e guardò giù, e poté discernere cime d’alberi agitate dal vento e una piccola macchia scintillante nel punto dove la corrente del fiume si riversava giù da una chiusa. Il tempo s’era un po’ rimesso, e il cielo rischiarato per modo che si potevano scorgere i profili dei nuvoloni più spessi e il lineamento delle colline. A quell’incerto barlume Denis poté anche osservare che il caseggiato che sorgeva alla sua sinistra era un’abitazione di qualche pretesa. Era sormontato da molti pinnacoli e torricelle, e la tonda struttura d’un’abside circondata torno torno come da una frangia di degradanti colonnette sporgeva all’infuori, con una certa baldanza, dal viluppo degli edifici principali. Là era pure un uscio dentro un portale tutto scolpito a figure e dominato da due lunghe garguglie. Attraverso fitte reti di fil di ferro che le rivestivano si vedevan le finestre della cappella illuminate di dentro dalla luce di molte candele, la quale faceva spiccare più cupo sul cielo il disegno del loggiato e del tetto cuspidato. Era quella certamente la dimora di qualche nobile famiglia della città, e poiché con le sue forme richiamava alla mente di Denis una casa cittadina di sua proprietà a Bourges, stette là, per qualche tratto, a contemplare la costruzione, paragonando fra loro, mentalmente, la perizia dei due architetti e la nobiltà delle due famiglie.
Pareva non ci fossero altre vie per arrivare alla terrazza oltre a quel vicolo che ve l’aveva condotto. Denis pensò, quindi, di ritornare sui suoi passi, e, avendo ormai acquistata qualche cognizione dei luoghi, riuscire così su qualche strada frequentata e di là lestamente raggiungere la taverna. Ma faceva il conto senza quella fila d’incidenti che gli stavano per capitare e che avrebbero reso quella notte la più memorabile di tutta la sua vita. Non aveva, infatti, dato un cento passi che vide una luce che s’avvicinava a lui e, nello stesso tempo, udì un frastuono di voci come di gente che ciarlasse insieme confusamente su nella risonante strettura del vicolo. Era un drappello d’armigeri che andava attorno con fiaccole per la ronda notturna. Denis s’accorse subito che quegli uomini eran stati in confidenza coi boccali e che, ad ogni modo, non dovevan essere d’umore tale da star troppo a largheggiarla sul suo salvacondotto o simili delicatezze ancor in uso durante la guerra cavalleresca. Anzi era assai probabile che, se lo avessero trovato lì, l’avrebbero accoppato come un gatto, e piantatolo dove si trovava. La situazione era abbastanza interessante, quantunque gli andasse suscitando una certa nervosa trepidazione. Allora, riflettendo che il chiarore stesso delle torce avrebbe potuto confondere la vista della sua persona e il chiasso delle voci il suono dei suoi passi, stimò che, per poco fosse stato svelto e circospetto nel fuggire, avrebbe potuto sottrarsi interamente alla vista della ronda.
Ma sfortuna volle che, mentre si volgeva per spiccare la corsa, un piede gli smucciò su di un ghiajottolo, ed egli stramazzò al suolo mandando un grido, mentre la spada battendo sulle pietre dava un suono cupo. S’udirono due o tre voci gettare il chi va là, in francese, in inglese… Denis stette quatto, poi, rimessosi in piedi, riprese svelto a fuggire giù per il vicolo. Giunto sulla terrazza si voltò per vedere. Gli uomini di ronda continuavano a vociargli dietro, e, proprio in quel momento, allungavano il passo per raggiungerlo, e si udiva il gran baccano dell’armature scosse, e si vedevano balenamenti di fiaccole qua e là fra le strette muraglie del sottopassaggio. Denis girò lo sguardo intorno, e, senz’altro, si risolse d’avventarsi dentro la strombatura della porta. Così acquattato, pensava di poter sfuggire alla loro vista o, quanto meno, trovarsi in una posizione eccellente sia per parlamentare sia per difendersi. E, snudata la spada, si pose con la schiena a ridosso del battente della porta. Ma ecco che, con sua meraviglia, la porta cedeva sotto al suo peso! Si volse di colpo, ma quella, come girando su perni oliati e silenziosi, continuò a indietreggiare, finché rimase là spalancata sopra al buio d’una stanza.
Quando nella vita ci accade qualche buona ventura, non è il caso di star a sottilizzare sul perché e sul come ci sia capitata, poiché l’utile immediato che ne ricaviamo sembra sufficiente motivo per farci accettare per buoni anche i più stravaganti rivolgimenti e le più matte incongruenze di queste nostre sublunari faccende. Per il che, senza esitare un istante, Denis si cacciò là dentro, poi riaccostò dietro di sé la porta per celare ai sopraggiungenti la vista del suo rifugio. Certo, egli non aveva intenzione di chiuderla interamente, quella porta, ma, per qualche motivo inesplicabile, forse a cagione d’un ordegno nascosto o del peso stesso del battente abbandonato a sé medesimo, fatto è che la poderosa massa di quercia gli sfuggì di fuor dalle dita e si venne richiudendo da sé con uno strepito fragoroso, come il cadere automatico d’una lastra di ferro.
Proprio in quell’istante la ronda irrompeva sulla terrazza e si dava a chiamarlo con alte grida e bestemmie. Li udiva sferracchiare per gli angoli bui, e ci fu pure un momento che il calcio d’una alabarda venne a grattare sulla superficie esterna della porta dietro la quale egli stava. Ma quei bravi uomini eran certamente troppo sovreccitati per dilungarsi nella faccenda, sì che, di lì a poco, egli li udì che si precipitavano giù per un passaggio fatto a chiocciola che era sfuggito prima alla sua vista, e di là s’allontanavano via lungo il muro merlato del castello.
Denis trasse un respiro. Stette ancora lì quatto per qualche minuto per timore ch’essi ritornassero, poi si mise a cercare un mezzo per riaprire la porta e fuggirsene fuori. La superficie interna della porta era tutta liscia: non una presa, non un oggetto, non una sporgenza qualsiasi. Si provò a ficcare le unghie nella commessura superiore e trarla a sé, ma la greve massa non si rimoveva. Tentò di scuoterla: era fissa come rupe. Denis de Beaulieu aggrottò le ciglia e diè fuori un fischiarello sommesso. Ma che diavol ha questa porta?, pensava. E perché prima stava aperta? E come va che s’è chiusa con tanta docilità e tanta fermezza dietro di me?
V’era in quella faccenda qualcosa di misterioso e di losco da dar l’aire alla fantasia d’un giovane. Tutto lì aveva l’aria d’un tranello bell’e buono. Eppure, come supporre un tranello su quella strada così cheta, in una casa che aveva un’apparenza così florida, così signorile? Comunque, si trattasse o no d’un tranello, fosse o no la cosa premeditata, egli si trovava là dentro trappolato a dovere. E, pur tuttavia, per scampare la vita altra via non c’era che uscire di là.
Tese l’orecchio. Al di fuori s’era fatto un gran silenzio; ma di dentro, proprio vicino a lui gli sembrò a poco a poco di udire come un lento respirare, un sommesso brusio di singhiozzi e dei piccoli scricchiolii come di molte persone che stessero lì al suo fianco e tutte quatte e immobili, sforzandosi di rattenere i fiati per non farsi accorgere della loro presenza. Queste immaginazioni risvegliarono di colpo tutti i suoi istinti vitali e subito si mise in atto di difesa come per proteggere la vita. Fu allora che i suoi occhi scorsero, a qualche distanza, verso l’interno della casa, un barlume di luce ch’era situato al di sopra del livello dei suoi occhi… un filo di luce verticale che si veniva allargando verso il basso, come sfuggisse dallo spiraglio lasciato da una cortina calata su l’ingresso d’un vestibolo. Il vedere qualcosa fu già un sollievo per Denis: fu come a uno che lavora in una palude toccare il duro d’un terreno sodo. Egli s’aggrappò avidamente a quel rigo di luce, e stette là per un po’ a fissarlo cercando di raccapezzare qualche indizio sul luogo dove si trovava.
Era evidente che una serie di gradini si spiccava dal punto dov’egli era e ascendeva verso un andito illuminato, e, infatti, là poté notare pure un altro rigo di luce, sottile come un ago, fievole come fosforo, e che poteva bene essere quella prima luce riflessa nel pulito legno della maniglia d’una scala. Da quell’istante in cui Denis s’avvide di non esser più solo, il cuore gli ripigliò a battere con soffocante violenza, e un folle desiderio lo invase di agire, agire, comunque si fosse. S’immaginò minacciato da mortale pericolo. E allora quale cosa più semplice e naturale che montare quei gradini, alzare la tenda e fronteggiare di colpo la terribile situazione? Almeno sarebbe venuto alle prese con alcunché di tangibile, almeno sarebbe uscito da quell’oscurità penosa!
Con le braccia protese camminò lentamente in avanti finché venne a urtare col piede nel primo gradino della scala. Allora, di volo, la salì: stette un istante sulla cima per dar tempo ai tratti del suo viso di ricomporsi, poi alzò la cortina ed entrò.
Si trovò in un ampio salone tutto pavimento e pareti di lucide lastre. Là erano tre porte, una su ciascuno dei tre lati, tutte egualmente incortinate da arazzi, ma il quarto era occupato da due larghi finestroni e da un camino grande in pietra scolpito con lo stemma dei Malétroit. Denis riconobbe subito l’impresa, e ringraziò la Provvidenza d’esser caduto in sì buone mani. La stanza era ampiamente illuminata, ma povera di mobilio: appena un tavolone e due o tre sedie. Il focolare era senza foco, e sul pavimento era sparsa una fiorita di giunchiglie ma che pareva di molti giorni prima.
A lato del camino, seduto entro un alto seggiolone stava proprio di faccia a Denis, quando entrò, un vecchierello che indossava una palatina di pelo. Teneva le gambe incrociate, le mani sobbracciate sul grembo e una tazza di vin drogato stava posata su una mensola al suo fianco. Il suo aspetto aveva una espressione fortemente maschia: ma non propriamente umana. C’era qualcosa in lui che arieggiava l’espressione di un toro, di un gatto o di un maiale: qualcosa insomma di equivoco e di stranamente mansueto a un tempo: qualcosa di avido, di bruto e di minaccioso. Il labbro superiore, irto di densi peli arruffati, appariva enfiato come da un colpo di pugno o da una flussione di denti: il sorriso della sua faccia, le sopracciglia a sest’acuto, i piccoli occhi pieni di gagliardo foco davano a quella fisionomia un’apparenza bizzarramente e quasi comicamente malvagia. Una zazzera di splendido candore gli scendeva diritta intorno al capo e si veniva raccogliendo in un unico ricciolone adagiato sul bavero della palatina. Barba e mustacchi erano modelli di ogni venerabile maestà e dolcezza, e, forse a cagione di qualche trattamento preventivo, la vecchiaia pareva non avesse lasciato traccia alcuna sulle sue mani. Sarebbe stato difficile immaginare un disegno più robusto e più delicato. Le dita affusolate e sensuali richiamavano quelle delle donne di Leonardo: tra l’indice e il pollice, quando stavan chiusi, si scorgeva, alla base, una protuberanza tutt’a pozzette: le unghie eran tagliate a perfezione e la carne di una sorprendente cadaverica bianchezza. Ma ciò che rendeva quell’aspetto ancor più temibile era appunto vedere quel vecchio che se ne stava con quelle mani così belle sobbracciate sul grembo come una vergine martire, quel vecchio che recava nella faccia un’espressione così intensa e sgomentante, sedere là con tanta pace nel suo seggiolone e volgere attorno uno sguardo immacolato, come un dio, come il simulacro d’un dio. Ma la sua pace pareva piena d’ironia e di perfidia tanto poco s’addiceva al suo aspetto.
Era Alain, Sire di Malétroit.
Per un attimo i due si guardarono in faccia, muti.
«Prego, venite avanti» disse alla fine il Sire di Malétroit «è tutta sera che vi sto aspettando».
Non s’era levato da sedere, ma le parole aveva accompagnate con un sorrisetto e con un lieve cortese chinar di capo. E un po’ per il sorriso, un po’ per uno strano murmure melodioso con cui il vecchio preludiò a quella sua dichiarazione, Denis sentì un diaccio brivido di disgusto serpeggiargli su per il midollo. E a stento riuscì a metter insieme qualche parola per una risposta.
«Temo, signore» finì per dire «che siamo caduti ambedue in un equivoco. Io, certo, non sono la persona che voi credete. Se non erro, voi aspettate delle visite; da parte mia vi dirò che nulla era più lontano dal mio pensiero, nulla più contrario al mio desiderio che l’entrare qui da voi…».
«Bene, bene» s’affrettò a dire il vecchio con un certo compiacimento «voi, ora, siete qui, e questo è l’essenziale. Accomodatevi dunque, amico mio, e mettetevi pure a vostro agio. Tra poco sbrigheremo tra noi i nostri piccoli affari».
Qui Denis s’accorse che la faccenda s’andava imbrogliando e s’affrettò a ripigliare i suoi schiarimenti.
«La vostra porta…» cominciò.
«Ah, la mia porta?» interruppe l’altro alzando le sopracciglia aguzze. «Ma quello non è stato che un ingenuo giochetto!» e alzò le spalle. «Una fantasia da ospite!… S’era per voi, giovinotto, non avreste certo desiderato di far la mia conoscenza. Ebbene, che volete, noialtri vecchi, di quando in quando, andiamo volentieri in cerca di tali riluttanze, e, quando ciò impegna il nostro onore, ci diamo attorno a trovar qualche modo per soggiogarle e per vincerle. Voi non foste invitato qui, certo; ma credetemi, signor mio, non per questo siete meno il benvenuto».
«M’avveggo» replicò Denis «che continuate a persistere nel vostro errore. Tra voi e me, signor mio, non può esservi rapporti di sorta. Io sono straniero in questo Paese. Mi chiamo Denis de Beaulieu. Se voi mi vedete qui, in questa vostra casa si è soltanto…».
«Mio giovine amico» l’altro ribatté «permettetemi ch’io abbia una mia opinione su questo argomento. È assai probabile che, per il momento, questa mia opinione sia differente dalla vostra» e qui lo fissò con uno sguardo un po’ traverso «ma il tempo dimostrerà quale di noi due abbia ragione».
Denis, a questo punto, si convinse d’aver proprio a che fare con un mentecatto. Per il che sedette abbrividendo, e, per il momento, si contentò di star ad aspettare lo scioglimento della strana avventura. Poi seguì una pausa durante la quale gli parve come di udire, da dietro l’arazzo calato sulla porta che gli stava dirimpetto, un rapido sussurrio come di persona che pregasse. E un momento pareva una persona sola, un altro parevan due, e la veemenza con cui venivan proferite le parole, ancorché sommesse, pareva dinotare una gran fretta o una grande ambascia d’animo. Denis pensò che quella ricca portiera doveva ricoprire l’ingresso della cappella di cui aveva ammirato l’abside quand’era fuori.
Nel frattempo il vecchio signore con un sorrisetto andava squadrandolo da capo a piedi e lasciandosi sfuggire ogni tanto un piccolo gorgheggio che aveva dell’uccellesco e del topesco a un tempo, e che sembrava denotare in lui un certo grado di soddisfazione. Questo indugio e questo stato di cose divennero in breve così insopportabili che Denis, per porvi fine, osservò cortesemente che il vento aveva cessato di soffiare.
Allora il vecchio proruppe in un riso silenzioso, ma così prolungato, così violento che la sua faccia si fece quasi vermiglia.
Denis, detto fatto, balzò in piedi, e, rigirandolo alla brava per l’aria, si rimise il cappello in testa.
«Signore» disse poi «se siete sano di mente vi dico che m’avete villanamente oltraggiato; se non lo siete, v’assicuro che spero trovare migliore occupazione al mio cervello che non starmene qui a cianciare con un pazzo. Io ho la coscienza pulita, signore. Vi siete fatto gioco di me fin dal primo momento che son arrivato qua dentro: poi avete rifiutato di ascoltare i miei schiarimenti. Ora, badate, non c’è forza al mondo che mi possa trattenere qui più a lungo, e, s’io non potrò trovarmi una via d’uscita onorevole, vi giuro che saprò far a pezzi la vostra porta con questa spada».
Il Sire di Malétroit levò la mano destra e la tese verso Denis, col pollice e il mignolo aperti.
«Caro nipote» disse poi «via, sedete».
«Nipote?» ribatté Denis. «Voi mentite per la gola!» e gli fece schioccare le dita sott’al naso.
«Sedete, furfante!» gridò allora il vecchio con rabbiosa voce, che pareva latrato di cane. «Ma che vi credete?» continuò.
«Che quando io ebbi inventato il mio piccolo ordegno della porta m’avessi a fermar lì? Se preferite esser legato mani e piedi sino a sentirvi scricchiolar le ossa, alzatevi pure e tentate di fuggire. Ma se gradite meglio rimanere e ragionarla un po’ con me, da buon amico, sedete là quieto quieto, e Dio vi abbia in gloria». «Che intendete dire?» proruppe Denis.
«Ch’io sono prigioniero?». «Constato il fatto» replicò l’altro «e preferisco lasciare a voi la risposta».
Denis risedé. All’esterno si sforzava di tenersi calmo, ma dentro bolliva di rabbia, gelava di spavento. E non andò molto ch’egli finì anche per convincersi di aver a che fare proprio con un pazzo. Perché, se il vecchio era sano di mente, che voleva da lui? In quale tragica e assurda avventura s’era mai cacciato! E come doveva diportarsi adesso?
Mentre stava su queste riflessioni, l’arazzo che ricopriva la porta d’ingresso della cappella si sollevò e un prete lungo lungo ne venne fuori vestito dei suoi abiti sacri, il quale, gettato un lento acuto sguardo su Denis, si chinò poi a parlare, a bassa voce, al Sire di Malétroit.
«Si trova essa in buona disposizione di spirito?» domandò quest’ultimo.
«Ella è ora più rassegnata, messere» rispose il prete.
«Che Dio la benedica, la è ben difficile da contentare!» ghignò il vecchio.
«Un giovincello simile… di non cattiva nascita… e pure di sua scelta! Bene, che pretende di più, la sgualdrina?».
«Per una ragazza» disse l’altro «la cosa non è delle più semplici e correnti. È tale almeno da mettere a dura prova il suo pudore».
«A questo perché non ci ha pensato prima d’imbarcarsi? Mica l’ho voluto io l’intrigo, Dio sa… Ma dacché è in ballo, per la madonna, balli». Poi volgendosi a Denis: «Signor de Beaulieu» gli domandò «permettete che vi presenti mia nipote? Essa attendeva la vostra venuta con la medesima impazienza, direi, con cui l’attendevo io stesso».
Anche a questo Denis si rassegnò di buona grazia, poiché, infine, egli non desiderava che una cosa sola, arrivare alla conclusione dell’avventura il più presto possibile. Perciò si levò su e fece un inchino di assentimento. Il Sire di Malétroit s’inchinò pure lui, poi, appoggiandosi al braccio del prete, si incamminò zoppicando verso la porta della cappella. Colà giunti, il prete sollevò un lembo dell’arazzo, e tutt’e tre entrarono.
L’interno di quell’oratorio aveva una certa ricercatezza architettonica. Una leggera cordonata si spiccava dalla cima di sei grosse colonne e veniva a raccogliersi nel mezzo della vòlta donde pendevano due ornamenti. Dietro l’altare la cappella si chiudeva in uno spazio emicicloidale, le cui pareti erano tutt’a bozze e scavi, sovraccarica di ornati in rilievo, e forata da molte finestrelle a forma di stella, di trifoglio, di ruota. Queste finestre erano male invetriate, e l’aria della notte entrava e s’aggirava liberamente per la cappella strapazzando senza misericordia le fiamme d’una cinquantina di candele posate sull’altare: onde la luce passava, per fasi graduali, dallo splendore più brillante a una penombra d’eclissi. Sui gradini, davanti all’altare, stava inginocchiata una giovane donna riccamente abbigliata, in abito di nozze.
Al vedere quell’abbigliamento Denis si sentì un brivido di freddo: e lottò, lottò con disperazione contro certo presentimento che gli era caduto nell’animo. No, non poteva… non doveva accadere quello ch’egli temeva.
«Bianca!» esclamò il sire con la sua voce a tono di flauto. «Ti ho portato qua un giovinotto che desidera conoscerti, piccolina mia. Su, da brava, volgiti e porgigli la tua vezzosa manina. Buona cosa è l’esser devoti, ma è necessario esser cortesi con gli ospiti, nipote mia».
La fanciulla, allora, si levò in piedi e si volse incamminandosi verso i sopraggiunti.
Si moveva a stento, tutta stecchita, e i lineamenti del suo fresco giovanile corpo esprimevano un pudico riserbo misto a un estremo abbattimento. Venne innanzi lentamente, a testa bassa, gli occhi fitti al suolo: finché, a un certo punto, il suo sguardo cadde sui piedi di Denis de Beaulieu – il quale, detta fra noi, era solito calzare, anche viaggiando, assai ricco ed elegante – e allora sostò di colpo, ebbe un trasalimento, come se la gialla calzatura l’avesse d’improvviso richiamata alla realtà delle cose, e levò lo sguardo su alla figura di colui che la recava. I suoi occhi incontrarono quelli di Denis, e il suo aspetto timoroso fu invaso dal terrore. Le sue labbra impallidirono gettò un alto strido, e, copertosi il volto con le mani, s’afflosciò di colpo sul pavimento della cappella.
«Non è lui!» gridava. «Zio, non è lui!».
Il Sire di Malétroit mandò il suo piacevole gorgheggio, poi: «Naturalmente» esclamò «io questo me lo immaginavo. È una sventura davvero, ve’, che non puoi ricordarti il suo nome».
«No, no!» gridava lei. «Questo signore io non l’ho veduto mai prima d’ora… Non mi è mai accaduto di porgli gli occhi addosso… Signore» esclamò poi volgendosi a Denis «se voi siete gentiluomo, aiutatemi a trarmi d’impaccio… Dite, ho io mai veduto voi? E voi mi avete veduta mai, prima di questa maledetta notte?».
«Per me» rispose il giovine «dichiaro di non aver avuto mai questo piacere… È proprio la prima volta, signore, che io ho l’onore di incontrarmi con questa vostra graziosa nipote».
Il vecchio fece spallucce, poi disse: «Son dolente d’udire questo… Ma, a dirvi il vero, non è mai troppo tardi per incominciare. Io, per esempio, con la mia defunta moglie, quando la sposai, ci avevo poca dimestichezza sulle prime. Ciò non toglie» soggiunse con un ghignetto «che matrimoni simili, improvvisati, possano sortire bene, in andar di tempo. E siccome è il fidanzato che ha da aver voce in capitolo in queste cose, così io vi concederò due ore per rifarvi del tempo perduto, quindi daremo inizio alla cerimonia». E, detto questo, s’avviò verso la porta, seguito dal prete. In un balzo la fanciulla fu in piedi.
«Zio, zio tu non puoi dir questo sul serio!» esclamò. «Dichiaro davanti a Dio che preferirei darmi una pugnalata piuttosto che forzare la volontà di questo giovine. Il cuore vi si ribella… Dio vieta un tale matrimonio! Voi disonorate la vostra canizie, zio! Oh, abbiate pietà di me… Non v’è donna al mondo che non anteponesse la morte a una simile unione! Ma è mai possibile» proseguì tremando «ma è mai possibile che non mi crediate? Che voi pensiate che questi…» e additò Denis con un tremito di collera e di vergogna «che voi pensiate ancora che questi possa essere lui?».
Di sulla soglia dove s’era indugiato il vecchio rispose: «Francamente, lo penso. Ma concedi, Bianca di Malétroit, che ti dichiari il mio pensiero in questa faccenda. Dacché ti sei ficcata in capo di gettare il disonore sulla mia famiglia e sul buon nome che, da più di tre ventine d’anni, io porto in pace e in guerra, ti sei preclusa anche ogni diritto non pure di intervenire nei miei disegni, ma pur anche di fissarmi in volto. Fosse vivo ancora tuo padre, t’avrebbe dato una buona dose di scapaccioni e cacciata di casa. Aveva mano di ferro, quell’uomo. Ringrazia il cielo se ora hai a che fare soltanto con una mano di velluto, mademoiselle. È mio dovere farti sposare, e subito. Per mia pura benevolenza ho tentato di scovarti fuor il tuo galante. Mi lusingo esservi riuscito. Ma se non lo fosse, Bianca di Malétroit, ti giuro davanti a Dio e a tutti gli angeli sacrosanti, che non me ne importa un fico. Ti consiglio, adunque, di essere cortese e gentile col nostro giovine amico, ché, parola, il tuo valletto è certo meno piccante e appetitoso di lui».
Detto questo, egli uscì col cappellano alle calcagna. E l’arazzo calò dietro di loro.
La fanciulla si volse a Denis. Aveva gli occhi vampanti.
«Ditemi, signore, ditemi» ella esclamò «che significa tutto questo?».
«Che volete che sappia? Io sono qui prigioniero in questa casa, che la mi par proprio una casa di matti. Di più non so: né mi riesce di capirci nulla».
«E come siete arrivato qua dentro?».
Denis glielo narrò succintamente, poi aggiunse: «Abbiate la bontà di far altrettanto anche voi, di spiegarmi un po’ in che rebus ci troviamo, di dirmi quale diavol verrà a essere, a un di presso, la fine di questa imbrogliata faccenda».
Bianca stette silenziosa, ed egli vide che le sue labbra tremavano, che i suoi occhi senza pianto brillavano d’uno splendore febbricoso. Poi ella si tolse il capo fra le mani.
«Oimè, come mi duole la mia testa!» cominciò con un accento accorato. «… per non dire del mio povero cuore!… Ma è bene sappiate la mia storia, signore; per quanto essa poco s’addica a una ragazza. Io mi chiamo Bianca de Malétroit. Ero assai giovine quando padre e madre mi morirono, tanto ch’io non ricordo più nulla di loro e davvero fui assai infelice tutta la mia vita… Tre mesi or sono, un giovine capitano cominciò a venirmi presso, ogni giorno, in chiesa. M’avvidi che gli piacevo. Son molto da biasimare, ma, che volete, ero così felice di sapere che qualcuno mi amava! E quando egli mi passò un biglietto, io me lo portai a casa e lo lessi avidamente con gran gusto. Da allora me ne scrisse molti biglietti. Era così desideroso di parlarmi, povero ragazzo! E cominciò a dire se, qualche sera, gli avrei lasciato aperta la porta, che avremmo fatto due chiacchiere lì su per le scale. Poich’egli sapeva quanto mio zio si fidasse di me». E qui scoppiò in un mezzo singhiozzo e pausò un poco avanti di ripigliare a parlare. «Mio zio» riprese poi «è uomo assai difficile, ma fine e sagace. Ha compiuto di molte gesta in guerra, aveva un grado eminente a corte, ed era molto in confidenza con la regina Isabeau, nei tempi andati. Bene, com’egli venisse in sospetto della cosa non saprei: certo ch’era assai difficile fare alcunché all’insaputa di quell’uomo. Fatto è che, stamane, mentre tornavamo dalla messa, egli d’un tratto m’afferra la mano, l’apre a forza, e si mette a leggere il mio bigliettino, pur sempre continuando a camminare. Finito di leggere, me lo restituisce cortesemente. Purtroppo, in esso, il mio innamorato mi rinnovava quella tal sollecitazione di lasciargli aperta la porta. Fu questo che ci perdé. Lo zio mi rinchiuse nella mia camera e mi vi tenne sotto chiave sino a sera; poi m’ordinò mi vestissi nel modo che qua mi vedete. Oh, uno scherno ben atroce per una povera ragazza, non vi pare? Poi, immagino che, non essendo egli riuscito a strapparmi di bocca il nome del giovine capitano, gli abbia teso un agguato, quello appunto nel quale siete caduto voi stasera, in vece sua, per disgrazia del cielo. Oh, io sono assai confusa, poiché penso ch’egli certamente avrà abbandonato l’idea di tormi in moglie adesso che le cose sono arrivate a questo punto. In verità io non pensavo di dovermi meritare un castigo così vergognoso. Non pensavo che Dio avrebbe permesso che una fanciulla si trovasse davanti a un giovine in una maniera così disonorata!… E ora che v’ho raccontato ogni cosa, davvero che ho poca speranza che voi non m’abbiate a disprezzare».
Denis le fece un rispettoso inchino. «Signora» disse «voi m’avete onorato della vostra confidenza; a me ora dimostrarvi che non ne sono indegno. Dov’è il Sire di Malétroit?».
«Suppongo che stia scrivendo nella sala di là» rispose la fanciulla.
«Vi posso accompagnare da lui?» domandò Denis porgendole il braccio con atto galante.
Avendo ella accettato, la coppia s’incamminò e uscì dalla cappella. Bianca era tutta abbattimento e vergogna, Denis invece assai impettito e compreso della missione che si recava a compiere: e, per di più, con una certa baldanzosa consapevolezza di averla a risolvere con onore.
Come li vide apparire, il Sire di Malétroit si levò e mosse a incontrarli facendo loro un’alquanto ironica riverenza.
Denis, allora, dandosi l’aria la più grandiosa del mondo, cominciò a parlare:
«Signore, credo d’aver pur io qualche parola da dire in argomento a questo matrimonio. E lasciate che vi assicuri subito ch’io, per me, non sono affatto persona da forzare l’inclinazione di questa signorina. Mi fosse stata spontaneamente offerta la sua mano, sarei orgoglioso d’accettarla, dacché so che ella è onesta quanto bella fanciulla; ma, allo stato in cui sono le cose, messere, io ho l’onore di rifiutarla».
Bianca lo fissò con uno sguardo pieno di riconoscenza, ma il vecchio sorrise soltanto, e continuò a sorridere, sorridere, fin che a Denis quel sorriso cominciò davvero a suscitare un certo disgusto.
«Ho timore» disse alfine «ho timore, signor de Beaulieu, che non abbiate ben compreso il partito ch’io ebbi il piacere di proporvi. Venite qua, di grazia, a questa finestra» e lo condusse a una delle finestre che stavano aperte nella notte. «Guardate» riprese a dire «guardate su alla parte superiore di questo edificio. Lo vedete quel grosso anello di ferro lassù, dove sta infilata una fune molto robusta? Ebbene, ora fate attenzione a quel che vi dico. Se voi trovate che la vostra antipatia per la persona della mia nipote è affatto irriducibile, fate conto, avanti l’alba, di vedervi bell’e impiccato a quella fune, fuori di questa finestra… Credetemi, è con mio gran rincrescimento ch’io sarò costretto a risolvermi a quel partito estremo, poiché non è certo la vostra morte ch’io desidero, ma solo di procurare a mia nipote una buona posizione nella vita. E tuttavia, a ciò si deve pur venire, se voi v’ostinate. La vostra famiglia, signor de Beaulieu, è nobile e onorata, ma, discendeste anche da Carlo Magno, voi non potete rifiutare la mano d’una Malétroit, impunemente: nemmeno ella fosse volgare come una strada di Parigi o mostruosa come una delle garguglie che stanno sopra la mia porta. Non mia nipote, non voi, non i miei personali sentimenti mi muovono a quest’atto: ma l’onore della mia famiglia ch’è stato compromesso. Io suppongo che voi siate il colpevole, ma se anche non lo foste, siccome siete ora a parte del segreto, non vi dovete affatto meravigliare se chiedo a voi di lavare la macchia di quest’onta. Non lo fate, il vostro sangue ricadrà su di voi. E vi dico che sarà un gran piacere per me vedere il vostro interessante cadavere spenzolare e sgambettare al vento sotto le mie finestre. Meglio una mezza pagnotta oggi che digiuno domani. Non posso rimediare alla vergogna? Voglio almeno soffocare lo scandalo».
Qui una pausa.
«Io credo tuttavia» disse Denis «che un altro modo vi sia di accomodare la cosa fra due gentiluomini. Voi avete una spada e so che la maneggiaste con bravura».
Il Sire di Malétroit fece un cenno al cappellano il quale, attraversata a passi lunghi e silenziosi la sala, s’accostò alla terza delle tre porte, e sollevò l’arazzo. Di lì a poco lo lasciava ricadere: ma non troppo presto che Denis non avesse avuto tempo di scorgere, dietro quello, un andito tenebroso dove stavano adunati molti uomini in arme.
«S’io era soltanto un po’ più giovine» riprese a dire Sir Alain «sarebbe stato un piacere per me onorarvi in quanto mi richiedete. Ma io sono adesso troppo vecchio. Che volete, il circondarsi di servi fedeli è una delle poche risorse di cui si compiace l’uomo vecchio; e io ho pur da impiegare le forze che ho. Vedete, è cosa dura pensare come un uomo matura negli anni e invecchia; ma, via, anche a questo, con un po’ di pazienza, si finisce per farci il callo. Voi e la vostra signorina, sembra – non è vero? – che desideriate restar soli in questa sala per godere il tempo che ancor vi rimane prima che scocchino le vostre due ore. Ebbene, io non desidero certo contrariare questo vostro desiderio, e vi cedo la sala con tutto il piacere del mondo. E, niente furia!» soggiunse poi levando in alto la mano come vide che un’espressione minacciosa s’appalesava sulla faccia di Denis de Beaulieu. «Se la vostra mente si ribella all’idea dell’impiccagione, due ore, sapete, è tempo sufficiente per gettarvi giù dalla finestra o sulle picche levate dei miei famigliari. Due ore di vita son pur sempre due ore di vita e grandi cose si possono operare in tale tenue spazio di tempo. Mi sembra, poi, se bene arguisco, che mia nipote abbia ancora qualcosa da dirvi. Non vorrete certo guastare le vostre due ultime ore di vita con un atto incivile verso una graziosa signorina, non è vero?». Denis si volse a guardare Bianca, e questa gli fece un gesto implorante.
È assai probabile che il vecchio si compiacesse di questi indizi d’un accordo che poteva nascere tra i due giovani, perché di nuovo sorrise all’uno e all’altra, poi, voltosi a Denis, con un tono più mansueto, soggiunse:
«Se voi mi date la vostra parola d’onore, signor de Beaulieu, che aspetterete il mio ritorno fino al termine delle due ore senza tentare atti disperati, vi prometto d’allontanare i miei servi e di lasciarvi qui a discorrere con tutta pace e segretezza con mademoiselle».
Denis fissò ancora la fanciulla, che parve implorarlo di accettare.
«Vi do la mia parola» diss’egli.
Messer di Malétroit s’inchinò e si diè quindi a girare zoppicando intorno per la sala schiarendosi di tanto in tanto la voce con quel tal grottesco e flautino gorgheggio che già tanto era piaciuto alle orecchie del signor de Beaulieu. Pigliò su da prima alcune carte che stavan posate sulla tavola, poi si diresse verso l’uscita dell’andito dove fu udito impartire qualche ordine agli uomini che stavan dietro l’arazzo; infine, arrancando, se ne uscì per la porta dalla quale Denis era entrato, non senza prima essersi indugiato sulla soglia a fare un altro sorrisetto e inchino alla coppia. Dopo di che scomparve, seguito dal prete con una lampada in mano. Appena soli, Bianca s’accostò a Denis e gli tese ambe le mani. Era tutta imporporata in volto, commossa: nei suoi occhi brillavano lacrime. «Voi non dovete morire» esclamò «dovete sposarmi piuttosto, e nonostante tutto».
«Mi sembra, signora, che voi pensiate che la morte mi faccia di molto paura» rispose Denis.
«Oh, no!» diss’ella. «Lo vedo bene che non siete un codardo. Dico così per me… Io non potrei reggere al pensiero di esser stata la cagione della vostra morte, e ciò soltanto per un mero scrupolo di coscienza». «Signora mia» rispose Denis «temo che voi facciate troppo poco caso delle difficoltà. Ebbene, quello che voi siete tanto generosa da voler eludere, io posso essere invece tanto orgoglioso da accettare. In un momento di nobile slancio verso di me, forse dimenticaste ciò che dovete ad altri».
E, questo dicendo, egli ebbe il pudore di tener gli occhi chinati e anche un po’ dopo ch’ebbe finito, tanto da non scorgere la confusione che s’era dipinta sul volto di Bianca. La quale rimase lì silenziosa per un istante, poi subito si volse via e abbandonatasi dentro il seggiolone dello zio scoppiò in singhiozzi.
Denis fu imbarazzatissimo. Si guardò attorno come cercasse un’ispirazione e, scorto uno sgabello, vi si lasciò cader su, tanto per fare qualcosa. Là egli stava, rigirandosi fra mano la custodia dello stocco, augurandosi di esser piuttosto le mille volte morto e sepolto sotto il più lurido immondezzaio di Francia. Il suo sguardo errava attorno per la vasta sala, né trovava su che posarsi. E vi erano tali ampi spazi tra mobile e mobile, e la luce si spandeva per tutto così nuda e così aduggiata, e il buio della notte penetrava dalle finestre così freddo freddo, ch’egli pensò non aver mai veduto chiesa tanto vasta, né una tomba così triste. I singhiozzi regolari di Bianca parevano scandire il corso del tempo come il tic tac d’una pendola. Denis contemplò a più riprese l’emblema dipinto sullo scudo, finché gli s’intorbidiron gli occhi: cacciò lo sguardo dentro gli angoli più bui finché gli parve vederli brulicanti d’orribili mostri e, a ogni tratto, si destava, trasaliva, e gli veniva in mente che quelle erano le due ultime ore della sua vita, e che stavano per fuggire, e che la morte era in cammino.
Intanto, sempre più sempre più, durante quel tempo, il suo sguardo s’andava indugiando sulla figura della fanciulla. Ella stava con la faccia giù chinata nelle mani, e, a ogni tratto, era scossa da un convulso di singhiozzi più dolorosi. Anche così era pur cosa graziosa a riguardarsi, pienotta eppure tutta delicata, con una pelle di una tinta calda e morata, e la più bella capigliatura di donna che mai accadesse a Denis di rimirare per il mondo. Le sue mani assomigliavano a quelle dello zio: ma certo stavano meglio lì, all’estremità di quelle giovanili braccia, e avevano un che d’infinitamente tenero e carezzevole. E Denis ricordò pure come i suoi occhi turchini avevano folgorato sopra di lui pieni di collera, di pietà, d’innocenza. E più egli andava innanzi a considerare quella perfezione e più nera gli appariva la morte, più profondamente era colpito dalla pietà e dal dolore al vederla lacrimare a quel modo, continuatamente. Allora egli si disse che a nessun uomo basterebbe l’animo di abbandonare un mondo che conteneva sì bella creatura; e che volentieri egli avrebbe dato quaranta minuti di quella sua ultim’ora pur di non aver proferite le crude e decisive parole di dianzi. D’improvviso, uno stridulo canto di gallo si levò dalla buia vallata sottostante. Nel silenzio che pesava su ogni cosa, l’assordante grido fu come un guizzo di luce che lacerasse l’oscurità d’una stanza, e li riscosse di colpo dagli amari pensieri.
Ella levò il capo e lo fissò.
«Ebbene» disse «non posso proprio far nulla per voi?».
«Signora» Denis rispose, eludendo con sottile grazia la domanda «s’io ho detto alcunché che possa avervi ferita, credetemi, l’ho fatto per amor vostro, non per mio giovamento».
Un’occhiata lacrimosa di lei fu il ringraziamento per quella risposta.
«Il vostro stato mi addolora profondamente» continuò Denis. «Il mondo fu crudele con voi. Vostro zio è una vera disgrazia per l’umanità. Credetemi, signora, non c’è in Francia giovane gentiluomo cui non parrebbe gioia trovarsi ora nella buona occasione in cui mi trovo io di morire per rendere a voi anche il più futile servigio».
«So che siete valente e generoso» essa rispose. «Ciò che mi occorre sapere adesso è se io posso esservi utile, in qualche modo, ora o dopo…» ella aggiunse con un brivido.
«Oh, certo che lo potete» rispose egli sorridendo. «Ma lasciatemi sedere un momento, qui, accanto a voi, come fossi un buon amico vostro, e non uno strano importuno. Cercate di dimenticare la balzana posizione in cui ci troviamo l’uno di fronte all’altro. Fate che questi ultimi miei istanti scorrano un po’ piacevolmente, e voi m’avrete reso il miglior servigio del mondo».
«Siete molto gentile» ella rispose con un accento ancora assai desolato «molto gentile… e questo, vedete, mi contrista ancor più. Ma avvicinatevi pure se vi piace; e se avete qualcosa da dirmi, state pur certo che troverete in me una affettuosa ascoltatrice. Ah, signor de Beaulieu, come ardirò io mai fissarvi in volto?…» e qui scoppiò di nuovo a piangere con rinnovata effusione.
«Signora» disse Denis prendendole una mano fra le sue «pensate al breve tempo che ancor mi rimane a vivere e alla grande tristezza che mi procura la vostra desolazione. Risparmiatemi, vi prego, in questi ultimi momenti, la vista di un dolore cui io non potrei porre rimedio neppure col sacrificio della mia vita».
«Sì, sono molto egoista» rispose Bianca «voglio esser più savia per voi, signor de Beaulieu. Ma, suvvia, riflettete, ditemi s’io non possa giovarvi in alcun modo pel futuro… Non avete amici ai quali io possa recare il vostro estremo saluto? Datemi pure incarichi, gravi fin che vorrete; ogni peso, per piccolo che sia, mi varrà ad alleviare la gratitudine senza prezzo ch’io vi devo. Procurate ch’io possa fare qualcosa per voi oltre che piangere».
«Mia madre» disse Denis «è passata a seconde nozze e ha una seconda famiglia da badare. Mio fratello Guiscardo sarà, quindi, l’erede del mio feudo; e, se non erro, della mia morte egli sarà assai soddisfatto. La vita è un fumo, come ci han appreso quei tali che stan negli ordini sacri. Quando l’uomo è su un bel cammino, e vede la vita dispiegarglisi davanti, gli sembra d’esser la creatura più importante della terra. Il suo cavallo gli annitrisce, le trombe squillano, le ragazze si affacciano alla finestra per rimirarlo quand’egli entra in città cavalcando alla testa del suo drappello. Riceve dimostrazioni di fiducia e di stima, alcune volte per lettera, altre a parole, da persone di grand’affare che gli capitano fra capo e collo. Non è quindi da meravigliare se la testa alcun poco gli gira. Ma, una volta ch’è morto, fosse stato valente come Ercole o saggio come Salomone, chi più si ricorda di lui? Dieci anni fa, in una molto feroce mischia, mio padre cadde insieme ai suoi cavalieri; ebbene, io credo che di nessuno d’essi, che neppure del luogo del combattimento, v’è più chi si ricordi al mondo! No, no, signora, più v’andate avvicinando alla morte, più v’accorgete ch’essa è una buia e polverosa stanza dove v’han chiuso dietro per sempre la porta. Io ho pochi amici, adesso; morto, non n’avrò più nessuno».
«Ah, signor de Beaulieu» esclamò la fanciulla «voi dimenticate Bianca di Malétroit».
«Siete assai cortese, signora mia, vi compiacete valutare il piccolo servigio che v’ho reso assai più di quanto esso meriti».
«Non è questo» ella replicò. «Avete torto se pensate ch’io sia tanto preoccupata del mio interesse. Dissi così perché voi siete il più nobile uomo che mai incontrassi, perché rilevo in voi un animo pieno di generosità e di finezza».
«E con tutto questo» ribatté Denis «eccomi qui, condannato a morire in questa trappola come un sorcio!». Una nube d’angoscia volò sulla faccia di lei, che rimase silenziosa, per un istante. Poi una luce brillò improvvisa nei suoi occhi e, sorridendo, ella riprese a dire:
«Io non voglio che il mio paladino pensi così bassamente di sé. Chi fa getto della propria vita per un’altra persona, sarà accolto in Paradiso da tutti gli angeli e arcangeli del buon Dio. Ma, ditemi, pensate ch’io sia bella?» proruppe infine arrossendo.
«Lo penso davvero» diss’egli.
«Son contenta di questo» rispose ella cordialmente. «Ebbene, pensate che vi possano essere molti uomini in Francia che, chiesti in nozze da una bella ragazza, e di sue proprie labbra, abbian rifiutato? So bene che di simili trionfi voialtri uomini fate poco caso. Ma noi donne sappiamo meglio di voi quello che v’è di più prezioso nell’amore: e non c’è nulla, credetemi, che più di questo possa innalzare una persona nella nostra stima: noi donne nulla s’apprezza più caramente».
«Vi ringrazio delle vostre gentili parole» diss’egli «ma voi non potete farmi dimenticare che io ero domandato di pietà e non d’amore».
«Di questo non son ben certa» replicò la fanciulla col capo chinato. «Ascoltatemi, signor de Beaulieu. Immagino quanto dovete disprezzarmi voi, e sento ch’è giusto lo facciate. Sono una troppo misera creatura, io, per occupare un pensiero nel vostro cuore. Tuttavia è pure vero che voi siete condannato a morire per me, stamani. Ma, sappiatelo, se io vi domandai che mi sposiate, sì, sì, fu perché io vi stimavo, perché vi ammiravo, perché, dal momento che pigliaste le mie difese contro lo zio, ho sentito d’amarvi con tutta l’anima. Oh, se aveste potuto vedervi allora, non disprezzo, ma pietà avreste sentito per me. E ora» continuò, rattenendolo con una mano «sebbene, posto da parte ogni riserbo, io sia arrivata a dirvi di queste cose, sappiate che i vostri sentimenti verso di me io già li conosco. Io non vorrei, essendo nobile di nascita, tediarvi con dimostrare l’utilità di un consenso da parte vostra. Io pure ho il mio orgoglio, e vi dichiaro davanti la santa Madre di Dio, che se voleste tornare sulla parola data, quant’a me, ho tanto desiderio di sposare voi quanto di non sposare… il lacchè di mio zio».
Denis sorrise un poco amaro.
«Gli è un piccolo amore» disse «che adombra un piccolo orgoglio». Ella non rispose, ma assai probabilmente aveva formulato il suo pensiero.
«Qua, venite alla finestra» ella disse, additandogli uno di quei finestroni. «Guardate: è l’alba!».
Infatti l’alba era di già levata. La volta del cielo era tutta soffusa dell’essenziale luce del giorno, nitida ma ancora scolorita, e la valle sottostante era percorsa tutta da un grigio riflesso. Radi e lievi vapori stavano covigliati nell’insenature della foresta, o strisciavano via lungo il corso serpeggiante del fiume. Tutta la scena emanava un’ineffabile sensazione di pace che appena venne turbata quando i galli cominciarono a innalzare il loro canto dalle fattorie. E forse tra essi era quel medesimo compare che, mezz’ora prima, aveva gettato così orrido strido nell’oscurità della notte, e ora alzava più gaio il suo saluto ad accogliere la venuta del giorno. Fra gli alberi della vallata un venticello si levò tutt’affaccendato, vorticante. Poi, grado grado, dall’oriente, la luce venne inondando ogni cosa: finché diventò incandescente, e spremé fuori, rossa palla di cannone, il sole.
Denis guardava giù tutte quelle cose con un poco di brivido. Aveva preso tra le sue le mani della fanciulla e la ratteneva lì, quasi inconsciamente.
«Di già fa giorno!» ella esclamò; poi, alquanto incongruente:
«La notte è stata così lunga… Ahimè, che diremo allo zio quando ritornerà?».
«Ciò che vorrete» fece Denis, e strinse le piccole dita fra le sue. Ella taceva.
«Bianca…» egli ripigliò con un concitato incerto accento pieno di passione «avete veduto com’io temo la morte. Ora dovete saperlo bene che io sarei felice di gettarmi da questa finestra quanto lo sarei di mettervi pur un dito addosso senza il vostro consenso. Ma, se un poco vi date pena di me, non fate ch’io abbia a far getto della mia vita per un semplice equivoco; poiché io vi amo, Bianca, più del mondo intero; e, per quanto abbia caro morire per voi in tutt’allegrezza, mi parrebbe godere tutte le gioie del Paradiso s’io potessi continuare a vivere accanto a voi, dedicare la mia vita interamente a voi…».
Aveva appena cessato di parlare che, dall’interno della casa, una campana cominciò a rintoccare pesantemente, e un frastuono d’armati si sparse per il corridoio: il che attestava che le guardie ritornavano ai loro posti, e che le due ore eran scorse.
«Ebbene, avete sentito?» ella mormorò piegandosi verso di lui, tutta labbra e occhi.
«Non ho sentito nulla» rispose Denis.
Ella gli sussurrò all’orecchio:
«Il capitano si chiamava Florimond de Champedivers».
«Non l’ho mai udito nominare» egli rispose; e, pigliando fra le sue braccia l’elastico corpo della fanciulla, ricoprì di baci l’umido viso.
Dietro loro s’udì un melodioso gorgheggìo seguito da una risatina soffocata, poi la voce del Sire di Malétroit che augurava buon dì al suo nuovo nipote.