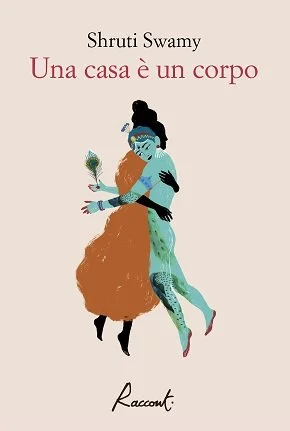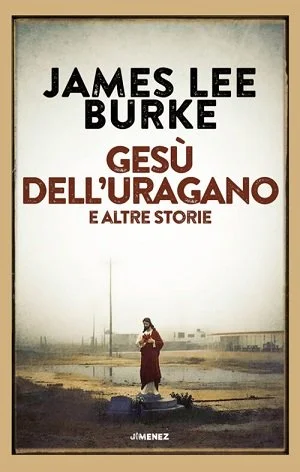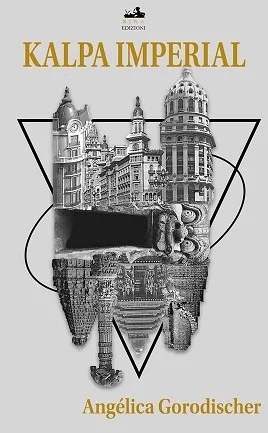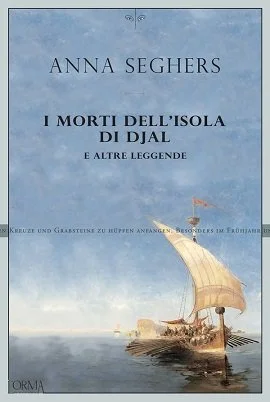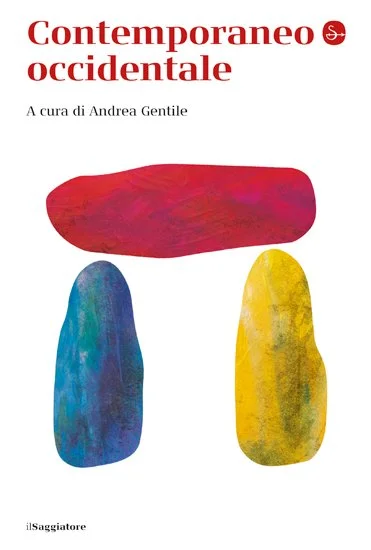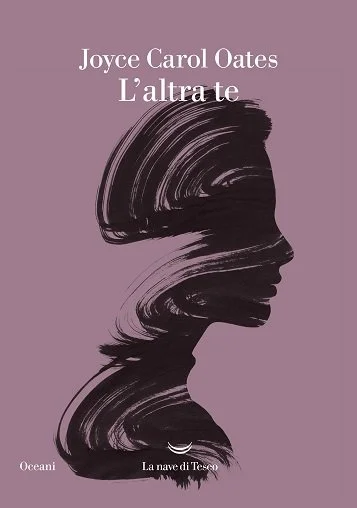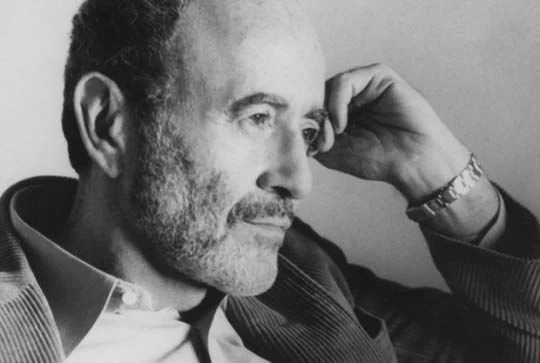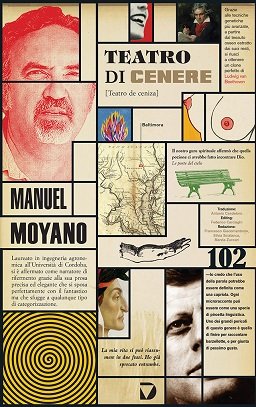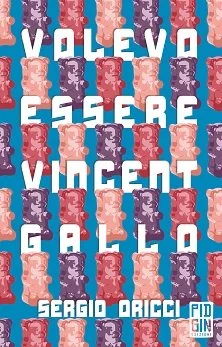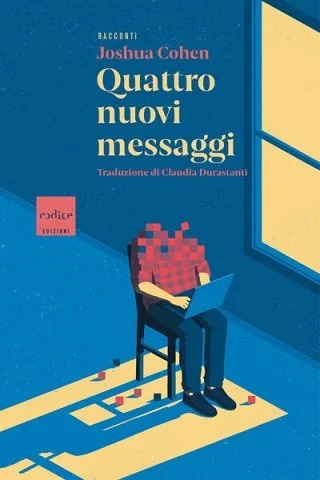Autore: Hassam Blasim
Titolo: Il Cristo iracheno
Editore: Utopia
Traduzione: Barbara Teresi
pp. 140 Euro 18,00
di Anna Lo Piano
Come si racconta la guerra? Non quella delle battaglie, delle ragioni politiche, e nemmeno quella della resistenza, dei vincitori e degli eroi, delle vittime e degli aguzzini, ma una guerra che va avanti da un tempo così lungo che intere generazioni non hanno mai conosciuto altro, il cui numero dei morti non impressiona più nessuno, nella quale la sofferenza ha smesso di essere associata a qualcosa di umano, e la violenza ha impregnato ogni frammento di quotidianità al punto da fondersi nella materia stessa di cui è fatto il paese.
“Guerre e le violenze erano diventate una macchina fotocopiatrice e tutti portavamo la stessa maschera, forgiata dal dolore e dal tormento”, dice uno dei personaggi de Il Cristo Iracheno, in cui Hassan Blasim racconta l’agonia dell’Iraq, dal conflitto infinito con l’Iran alla dittatura di Saddam Hussein, dall’arrivo degli eserciti occidentali a quello di Daesh, fino all’esilio forzato.
Pubblicata in Italia dalla casa editrice Utopia, con la bella traduzione di Barbara Teresi, la raccolta è ancora inedita in arabo, nonostante i singoli racconti siano circolati in vario modo attraverso il web.
Blasim non è un autore facile. La sua scrittura fonde poesia e turpiloquio, e sovverte ogni ordine prestabilito mettendo a nudo i tabù, travalicando ogni possibile autocensura.
Nato a Baghdad nel 1973, è finito sotto osservazione della polizia di Saddam Hussein fin da giovanissimo, quando era ancora uno studente della scuola di cinema e già si era fatto notare per alcuni cortometraggi poco compiacenti con la politica del regime. Costretto a fuggire, ha viaggiato per anni attraverso la Turchia e l’Europa per poi approdare in Finlandia nel 2003, dove gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico e ha ripreso a girare film e a scrivere.
Questi racconti sono stati scritti negli anni dell’esilio, e nella versione inglese del 2013 a cura della casa editrice Comma press, gli sono valsi l’Indipendent Foreign Fiction Prize. I personaggi che li animano hanno un’urgenza di parola che è dichiarata fin dalle prime righe:
La gente faceva la fila per raccontare la propria storia. Sul posto è intervenuta la polizia per garantire l’ordine. La strada principale su cui sorgeva la stazione radio era stata chiusa al traffico. Borseggiatori e venditori ambulanti di sigarette circolavano tra la folla. Tutti avevano paura che un terrorista si infiltrasse nella calca e trasformasse tutte quelle storie in una poltiglia di carne e fuoco.
Il motivo di un tale assembramento è il concorso “Storie in prima persona” bandito da Radio Memoria, in occasione della caduta del dittatore. Il rovesciamento del potere, pur senza interrompere la catena di orrori, è come la rottura di un argine, un via libera alle voci che cominciano ad accalcarsi. Se il premio in denaro fa gola a tutti, ciò che davvero in palio è il riconoscimento della propria sofferenza, la liberazione da quella maschera che, come una fotocopiatrice, li rende una massa informe senza alcuna traccia di individualità.
Cominciano allora ad accavallarsi le storie. Tutti, anche i morti, e forse soprattutto loro, brandiscono una storia vissuta, ascoltata, immaginata o letta, rivendicando il diritto a non essere solo vittime ma anche testimoni dell’orrore, di avere il coraggio di guardare e portarne addosso le tracce. Testimoni e martiri, nel senso più profondo della parola.
Il tema dello sguardo e degli occhi percorre tutto il libro. Ci sono occhi che lacrimano per fare apparire e sparire coltelli, ci sono gli occhi di Karima, tranquilli come la notte di un albero in primavera, e quelli della sua amica che “guardavano e rimpiangevano insieme a lei le ombre del tempo” (Non uccidermi, ti prego…questo è il mio albero!) e ancora occhi di ragazzi come lenti di ingrandimento che costruiscono un mondo immaginario sulla base di quello che vedono intorno a loro.
Ne “La finestra del quinto piano”, il narratore, chiuso in una stanza d’ospedale con due altri pazienti, legge “Palomar” di Italo Calvino e cita:
“Ma come si fa a guardare qualcosa lasciando da parte l’io? Di chi sono gli occhi che guardano? Di solito si pensa che l’io sia uno che sta affacciato ai propri occhi come al davanzale d’una finestra e guarda il mondo che si distende in tutta la vastità lì davanti a lui”.
Non è l’unica volta in cui Blasim fa riferimento a un’opera letteraria. In questi racconti i libri e i loro autori sono chiamati in causa di continuo, da Rumi a Borges a Kakfa, fino al poeta al Mutanabbi e alla strada che porta il suo nome a Baghdad, sede di un popolare mercato di libri, devastata da un’esplosione.
Ma quella di Palomar è l’unica citazione esplicita da un testo, e definisce una poetica.
I tre pazienti nella stanza d’ospedale sono malati terminali di cancro in una città devastata dalle bombe. La loro finestra, sempre chiusa, dà sul piazzale del pronto soccorso, dove le ambulanze e le scene di morte di susseguono. Passano il tempo a giocare a carte e raccontare storie, intrappolati tra i lamenti di un moribondo e quella vista che ha “un potere irresistibile”, “una forza gravitazionale che spinge a commettere un crimine”.
Nel momento in cui il narratore cita Calvino, gli altri due pazienti stanno confabulando fra loro, si stanno alleando per farla finita. Uno spinge l’altro, aprono la finestra, si buttano di sotto, mentre il narratore, affacciato alla propria finestra, li osserva impietrito come le statue di Baghdad.
Nel risvolto di copertina Gerardo Masuccio, editor di Utopia, scrive “chi fissa l’esistenza dritto negli occhi, fino a constatarne l’assurdità, si espone a rischi infausti”. L’orrore può essere pietrificante come uno sguardo di Medusa.
Come fa uno scrittore allora a maneggiare una simile realtà? In che modo può raccontare una storia che abbia senso in un mondo in cui la donna a cui un gruppo islamico ha rapito e torturato il marito viene derisa perché tutti hanno storie “più strane, più crudeli e più folli” della sua? Se il limite ultimo dell’orrore sembra spostarsi sempre più avanti la realtà comincia a sgretolarsi, a cedere e ricostituirsi in forme nuove e inedite.
Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, Daniel è un soldato cristiano che ha una particolarità. Ogni qualvolta è in pericolo di vita, sente un impulso inspiegabile, una voglia, un fastidio, un prurito imbarazzante, che gli suggerisce il posto più sicuro dove andarsi a rifugiare. Gli altri soldati lo seguono, e stando nella sua ombra protettiva si salvano la vita.
Gli eventi di quella guerra in compagnia di Daniel somigliavano alle storie dei cartoni animati. In un batter d’occhio la realtà diventava elastica, perdeva coesione, e il delirio aveva inizio.
(Il Cristo iracheno)
Se la realtà diventa elastica e perde coesione, può riformarsi in versioni parallele che hanno lo stesso diritto all’assurdità.
E quindi arrivano pozzi abitati da Jinn cannibali dove i visitatori “imparano molto presto a leggere e conoscere gli eventi del passato, del presente e del futuro”, conigli che depongono uova come avvertimento, alcune persone hanno il dono di far sparire coltelli e altre di farli apparire, ma niente di tutto questo significa qualcosa in modo esplicito.
Due anni prima mi era stato affidato il compito di leggere dei libri per capire il significato dei coltelli, ed ero facilmente giunto alla conclusione che fossero solo una metafora dell’orrore, degli omicidi e della brutalità del paese. Ma che valore ha una metafora? Cosa può fare in questo mondo?
(Mille e un coltello)
Il fantastico non è una metafora di una realtà, come tiene a precisare la narratrice di “Caro Beto”, una lupa che si scaglia contro le orride metafore degli umani:
Il loro linguaggio ci ha avvelenati. Dovremmo limitarci ad abbaiare, smettere di capire le loro parole. Tutte quelle figure retoriche e sciocche metafore (…). La vita è un libro, la vita è una galassia. La vita è una gabbia, insonnia, una croce (…)
Non c’è parola, qualunque sia la sua forma e qualunque cosa significhi, che non possa accompagnare il termine vita senza veicolare un’idea. O senza condurre all’essenza della vita. Perché la vita è spazzatura e fiore nello stesso spazio-tempo. E se ci fosse una sola parola che non si adatta alla vita, quella parola sarebbe la chiave per arrivare al segreto di questi umani.
Questa chiave, questo accesso segreto, è il desiderio più profondo dei narratori di questi racconti, che sono impegnati a decifrare libri, enigmi, la vita stessa.
Anche l’amore ha perso la sua forza, non è in grado di salvare nessuno, al contrario. Il Cristo iracheno, dopo aver messo tutti al riparo, cede al ricatto di un terrorista pur di salvare la madre. Una donna, pur di proteggere sua figlia da “i fantasmi” che potrebbero arrivare, la espone al sole fino a ustionarle la pelle per renderla meno attraente, e alla fine, in preda al terrore, la uccide prima che possano ucciderla altri.
L’unica via di uscita allora non è cercare di capire la realtà nella sua interezza, ma scomporla in minuscole parti, dedicarsi all’approfondimento di ogni singolo dettaglio, come fa il narratore de “Il coniglio della zona verde” che passa le sue giornate a leggere, scegliendo un dettaglio preciso e concentrandosi nella ricerca di altri contenuti su quel particolare, aggirandosi in una biblioteca di referenze labirintiche, nella speranza forse di trovare, in qualche segreto meandro, la fantomatica porta chiusa.
E torna allora il riferimento a Palomar, a questo personaggio che osserva tutto nei minimi dettagli.
Nella quarta di copertina del romanzo Palomar (edizione 1983), così Calvino descrive il protagonista:
Chi è il signor Palomar che questo libro insegue lungo gli itinerari delle sue giornate? Il nome richiama alla mente un potente telescopio, ma l’attenzione di questo personaggio pare si posi solo sulle cose che gli capitano sotto gli occhi nella vita quotidiana, scrutate nei minimi dettagli con un ossessivo scrupolo di precisione. Le esperienze di Palomar consistono nel concentrarsi ogni volta su un fenomeno isolato. L’oggettività e l’immobilità dell’osservazione si trasformano in racconto, peripezia, coinvolgimento della propria persona. Più Palomar circoscrive il campo dell’esperienza, più esso si moltiplica al proprio interno aprendo prospettive vertiginose, come se in ogni punto fosse contenuto l’infinito. Uomo taciturno, forse perché ha vissuto troppo a lungo in un’atmosfera inquinata dal cattivo uso della parola.
L’ultimo racconto di Palomar si chiama “Come imparare a essere morto”. È quello il suo ultimo fine esattamente come tutti i personaggi di questi racconti, che hanno già passato il confine, o si preparano a farlo, sapendo che anche oltre non scompariranno, ma continueranno a osservare ciò che avviene.
Essere morto non vuol dire non esserci, prima per mondo intendeva il mondo più lui, adesso si tratta di lui più il mondo meno lui.
Il mondo meno noi, “eliminata quella macchia di inquietudine che è la nostra presenza” ci fa osservatori esterni di qualcosa in cui non possiamo più intervenire, nella consapevolezza che “Tutto è calma o tende alla calma, anche gli uragani, i terremoti, l’eruzione dei vulcani”.
In questo tipo di osservazione è forse possibile raggiungere una forma di pace, convincersi che esiste una fine, basta scomporla in istanti e descrivere ogni istante fin nei minimi dettagli, fino ad esaurire tutta l’attesa
Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante – pensa Palomar e ogni istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine. Decide che si metterà a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti non penserà più di essere morto. In quel momento muore.
Allo stesso modo, in “Sole e Paradiso”, il narratore, dalla sua terrazza, è stato testimone muto della desolazione di una intera città, ha visto svolgersi il dramma di una madre angosciata per la figlia, ha assistito alla fine tragica di entrambe. Rimasto solo, continua a osservare ciò che accade, le truppe di regime che la prendono d’assalto, le forze di opposizione che ne riguadagnano il controllo, le organizzazioni umanitarie che contano le carneficine perpetrate da entrambe le parti come arbitri che contino i goal. E alla fine si ricorda che lui ha già perso la sua vita. Che è un martire, un testimone che porta su di sé le tracce della battaglia. I fratelli che organizzano le operazioni di trapasso gli hanno detto di aspettare finché non lo faranno passare dall’altra parte.
Il tempo passava e io continuavo ad aspettare. Giravo per la cittadina abbandonata. Osservavo i vestiti degli abitanti, le stoviglie, i giocattoli dei bambini e gli ossi degli animali domestici morti. Anche i campi di cotono erano morti. Mi annoiavo. Ma è stata proprio la noia a svelarmi i miei veri poteri. Ho cominciato a volare insieme agli uccelli tra i rami e sui tetti delle case. A ondeggiare insieme alle foglie che cadevano dagli alberi. A giocare con il vento, strisciare con i vermi e litigare con gli insetti. Potevo fare qualunque cosa, senza preoccupazioni, né fame, né paura. La solitudine aveva smesso di essere un peso e gli ultimi ricordi della mia vita passata stavano ormai svanendo.
E una mattina, mentre me ne stavo seduto sul melo in casa di Sawsan e sua madre, mi è passata per la testa l’idea che ha inferto il colpo di grazia al senso della mia attesa: che sia questa cittadina abbandonata, il paradiso?
Le citazioni da Palomar sono prese dall’edizione Einaudi 1983