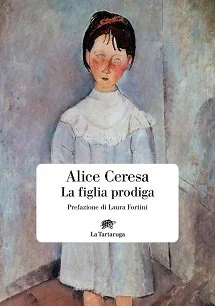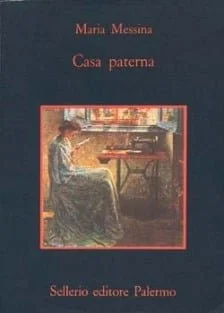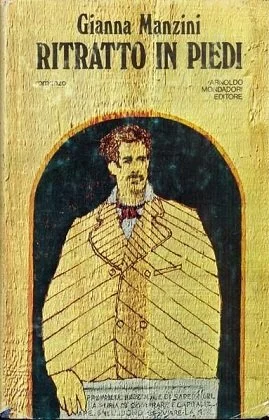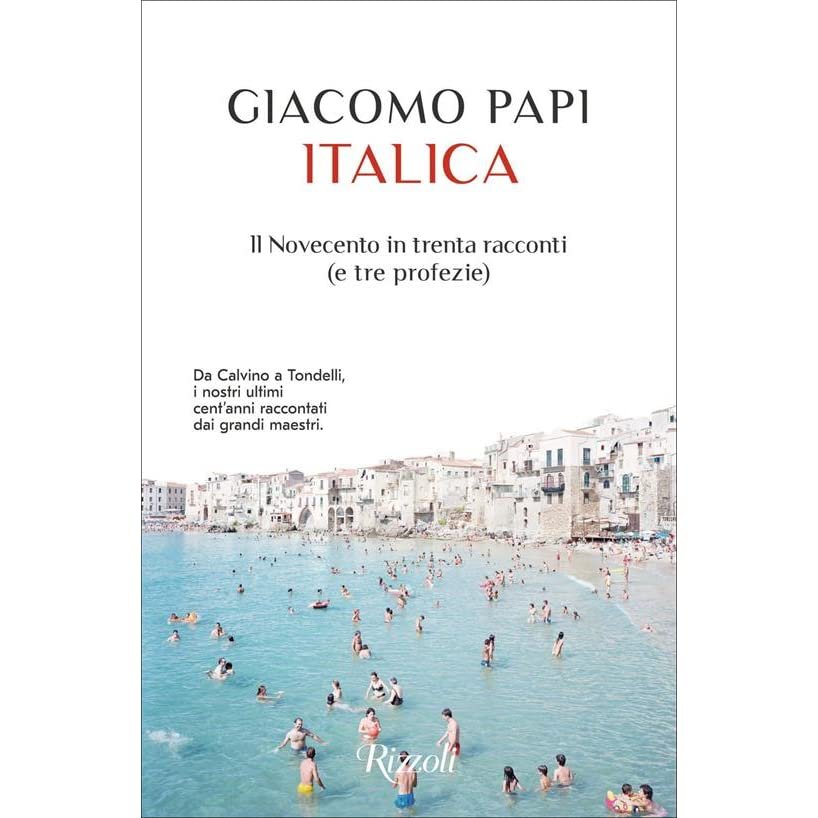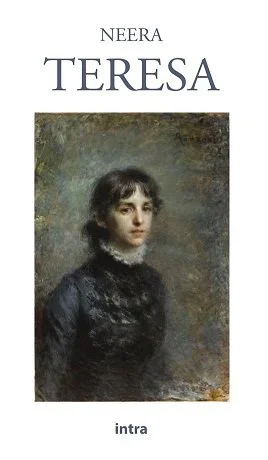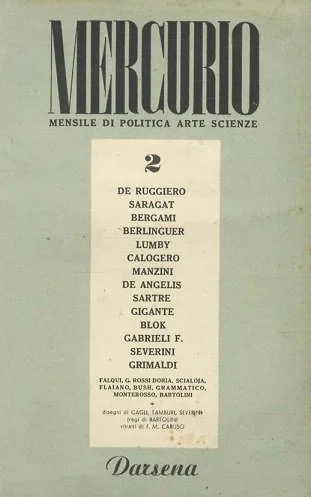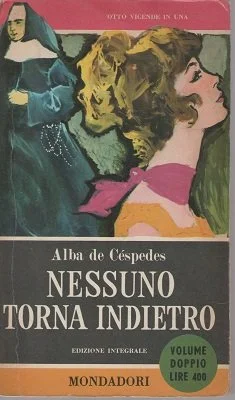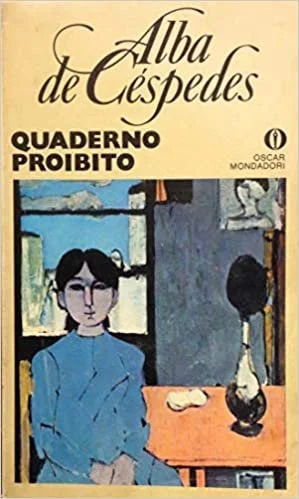di Anna Lo Piano
Nella sua lunga e fortunata carriera di scrittrice Annie Vivanti è stata molte cose: drammaturga, opinionista, romanziera. Ha scritto bozzetti di costume per le riviste più lette dell’epoca, reportage di guerra e di viaggio, editoriali politici, raccolte di racconti (Zingaresca, Gioia!, Perdonare Eglantina) e romanzi popolari in cui si sentono le influenze decadenti e il mito della donna fatale ( Naja Tripudians, Sorella di Messalina, Circe ). Ha fatto parte di quella schiera di donne che a cavallo dei due secoli, in Italia, conquistano una voce e uno spazio per farsi sentire. Immerse nella vita del paese, sono le influencer dell’epoca, portatrici di uno sguardo nuovo sui temi della modernità. Scrivono romanzi “di intrattenimento” che hanno il difetto di essere incredibilmente popolari, e spesso nella narrativa trattano questioni sociali, pubbliche e private, dalle condizioni di lavoro ai matrimoni forzati. Eppure tra gli anni ‘30 e il dopoguerra su di loro scende l’oblio, e come ha messo bene in evidenza Antonia Arslan, vengono escluse dal canone ufficiale, finendo per essere relegate ai margini della galassia letteraria e poi sommerse. La stessa Vivanti, che nei suoi scritti ha trattato, con l’ironia leggera e sferzante che le era propria, il matrimonio, la maternità, l’aborto, la guerra, gli stupri, la convivenza, la sudditanza coloniale, finisce per essere ricordata come la giovinetta che fece innamorare Carducci, la figurina gioiosa ed effimera di una scrittura seduttiva che mima uno stile di vita, e che verrà definita vivantismo.
Scrive di lei il critico Anton Giulio Borgese, nel terzo volume della raccolta di saggi letterari La Vita e il Libro, edito da Zanichelli: “Annie Vivanti scrive capolavori senza volerlo e senza saperlo” riaffermando, pur nell’apprezzamento, il giudizio di tanta critica novecentesca sulla scrittura femminile, nella quale è l’istinto e il sentimento che guida la penna, più che la capacità consapevole.
Ma lei, pronta alla battuta, in una lettera all’editore Mondadori risponde: “forse in questa affermazione ci sono tre errori, ….ma due certo” e continua:
“in arte nulla richiede maggior fatica che quella apparente spontaneità che il gentile commentatore ammira; come la semplicità in arte non si ottiene che con aspro e spietato e complesso travaglio...Forse i critici non sanno che è facile essere pedanti, pesanti e ampollosi, ma che per scendere con leggerezza negli abissi e illuminarne vividamente le profondità, ci vuole l'alato scintillìo del genio”.
Senza spingersi a indagare l’effettiva presenza o meno del genio, è chiaro che Vivanti è ben consapevole di quello che sta facendo. E il pubblico e anche tanta stampa dell’epoca, sia italiana che straniera, riconosce il suo talento, perché ogni suo libro è un best-seller. Matilde Serao prima e Benedetto Croce poi, le riconosceranno una qualità “virile” della scrittura, che è uno dei massimi riconoscimenti a cui una scrittrice dell’epoca può aspirare in Italia. Rispetto alle autrici a lei contemporanee, Vivanti porta uno sguardo cosmopolita e indipendente. Nata a Londra nel 1866 da Anselmo Vivanti, esule mazziniano, di origine ebraica, e da Anna Lindau, intellettuale tedesca, ebrea anche lei di origine ma convertita al protestantesimo, cresce fra diverse lingue, culture e religioni. Alla morte della madre, che le aveva fatto scoprire la poesia tedesca, studia in Svizzera, segue il padre negli Stati Uniti, poi si mantiene da sola cantando. Dopo il successo di Lirica, conosce John Chartres, un avvocato e giornalista irlandese, poi diplomatico e membro del Sinn Féin, e lo sposa. Dal matrimonio nasce Vivien, che agli inizi del ‘900 diventerà un prodigio del violino, costringendola a viaggiare di teatro in teatro per l’Europa, e a fare i conti con il difficile rapporto tra maternità e arte. Se c’è una qualità propria ad Annie Vivanti, è quella di saper stare nel suo tempo, di coglierne i movimenti e le tendenze, di sapersi anche adattare, ma con uno sguardo sfalsato, fuori posto, che le permette di avere una visione decentrata, che è propria di chi appartiene a diversi paesi e culture, e sa come si costruiscono gli stereotipi, perché li ha vissuti su di sé in prima persona. In questo contesto è interessante rileggere i quattro racconti che scrisse tra il 1896 e il 1899, quando la figlia era ancora piccola e lei viveva negli Stati Uniti, e anche The true Story of a Wunderkind told by its mother, Annie Vivanti, che è del 1905. Pubblicati sulle riviste americane del tempo – Cosmopolitan, The Idler, Mousey’s Magazine, Pall Mall Magazine, Leslie’s Weekly , sulle quali potevano leggersi anche le firme, tra le altre, di Jerome K. Jerome, Conan Doyle, Mansfield - sono scritti direttamente in inglese, la sua lingua madre.
Di questi solo l’ultimo viene tradotto dalla stessa Vivanti e inserito nella raccolta Zingaresca con il titolo Storia di Vivien. Gli altri, invece, rimangono inediti in Italia fino al 2005, quando Carlo Caporossi, impegnato da tempo in un’operazione di recupero della scrittrice, li traduce per Sellerio, raccogliendoli sotto il titolo di Racconti americani, con una sua introduzione e una post-fazione di Anna Folli.
Il racconto che apre la raccolta è Perfetta (Perfect). Qui conosciamo subito Karl “un bel tedesco, noioso e sentimentale, con gli occhi dolci e l’animo parsimonioso”. Bastano pochi tratti a Vivanti per anticiparci i movimenti del suo personaggio. Come molti suoi connazionali, Karl è arrivato in Italia per imparare il bel canto (e far finire i suoi talleri nei portafogli profondi ma pur sempre professionali dei più importanti maestri). Ma, soprattutto, per cercare di ritrovare quella qualità italiana di natura, atmosfere, arte, pittoresco, che è in parte reale e in parte creazione del racconto collettivo fatto dai viaggiatori del Grand Tour a partire dal ‘700. Vivanti è estremamente cosciente di questa ricerca di pittoresco che opera il Nord rispetto al Sud, che coglie della realtà solo ciò che corrisponde alle proprie aspettative. Karl viaggia in Italia “con i suoi sogni” e una valigia gialla che contiene libretti d’opera, camicie di flanella e un sapone fatto in casa per lui dalla madre e dalle sorelle. Un vero e proprio bagaglio mentale. A Firenze, in una delle sale della Galleria Pitti, conosce Francesca Verdon, che gli appare tra le figure angeliche, simile a una Madonna del Murillo. La loro amicizia si snoda tra versi di Dante e suggestioni letterarie, rimanendo giocosa e casta. La perfezione di Francesca, enunciata nel titolo, è infatti quella di avere a New York un marito e una figlia. È dunque una donna affettivamente completa, che non sente l’esigenza di avere altro nella vita, e questo la rende agli occhi di Karl quanto mai desiderabile. Tornati i due giovani alle rispettive patrie, comincia un secondo movimento del racconto. Karl non riesce a dimenticare il suo amore italiano, e decide di sfidare la famiglia e raggiungerla a New York, con un viaggio in nave per lui costosissimo. Se le prime pagine sono punteggiate da espressioni in italiano e citazioni in tedesco, adesso predomina l’inglese. Vediamo Francesca muoversi a suo agio nella bella casa borghese di New York, e la notizia la stupisce ma non sembra scombussolarla troppo. Il marito stesso, con un fare pragmatico e un certo understatement, si rassegna ad accogliere l’amico della moglie. Man mano che il giorno dell’arrivo si avvicina, però, Francesca comincia ad agitarsi. Capisce che il suo equilibrio è in pericolo e cerca di aggrapparsi a un’immagine di perfezione femminile e familiare da esibire come uno stendardo.
“Ti amo perché tuo marito ti adora, perché ami la tua bambina, perché la tua vita familiare è felice e completa”…era questo l’ideale che lui aveva nella mente e nel cuore, questo accordo perfettamente armonioso, come aveva detto una volta, di tre belle note: il basso forte, profondo e dolce, dell’uomo; il soprano tremulo della bambina;
e quella serena placida nota di mezzo che sa armonizzare le due precedenti…lei.
Così lui la sognava, così l’avrebbe dovuta trovare…dovevano andare tutti e tre a incontrarlo alla nave.
Comincia allora da parte di Francesca un gioco di travestimenti, un’attenzione spasmodica al singolo dettaglio per come la famigliola dovrà apparire all’arrivo della nave al porto, però niente funziona. La bambina piange, sono in ritardo e sudati, mangiano uno “spaventoso sandwich” in un postaccio lungo la strada.
Ed è qui, sul molo, nel tempo nervoso dell’attesa, che avviene il passaggio al terzo movimento del racconto, in una composizione di scenari che fa da contrappunto al triangolo amoroso.
Dalla nave Karl cerca la donna che gli ha rubato il cuore. Si avvicina alla terraferma in una successione di sguardi sempre più ravvicinati, come lo zoom di una cinepresa.
“Karl era sul ponte, col vento tra i capelli…prese il binocolo dalla custodia a tracolla e guardò l’immagine grave, engoncé, della Libertà, I suoi drappeggi, e lo stupefacente ponte di Brooklyn. Poi mise a fuoco la banchina - la banchina numero 40 – una piccola zattera rotonda, di legno, brulicante di piccoli esserini. Era laggiù lei?”
Cerca Francesca tra la folla, la confonde con altre donne, fino a metterla a fuoco, ed è a quel punto che gli appare nella sua realtà.
“La nave approdò, finalmente, e fra l’ondeggiare di tutti quei fazzoletti e quei cappelli, improvvisamente la vide. Era vicina a un uomo grasso, tozzo, che si stava asciugando il viso col fazzoletto, e teneva per mano una bambina…un gruppo di famiglia,
come altri due o tre vicini loro”.
Da questo momento gli equilibri cambiano. Cosciente di essere caduto nella trappola di un’illusione, Karl si mostra sempre più freddo, mentre Francesca, diventata improvvisamente una timida ed elogiata “padrona di casa” comincia a rimpiangere di non aver ceduto alle avance del giovane nella cornice romantica di Rimini. Intanto lui, diviso tra il sentimento e la parsimonia, recita Heine e fa i conti di quanto gli è costata questa pazzia. Poi riparte per la Germania congedando l’amica con un dialogo speculare a quello che aveva segnato il loro primo addio in Italia.
“Non ti vedrò mai più?” “Perché no?” disse Karl distrattamente “Il mondo è così piccolo”.
Non è l’unico racconto in cui Vivanti ironizza sull’immaginario “esotico”. Nel Fascino delle solitudini, contenuto in Zingaresca, si prende gioco della propria voglia di spazi aperti e spirito selvaggio, narrando con grande humour l’arrivo di una se stessa mondana e festaiola in mezzo alle scomodità del vero Far West. E la ricerca del pittoresco torna ancora nel racconto Un capriccio (A Fad), in cui però l’ironia si tinge di toni più aspri e il contrasto di due mondi inconciliabili ha un esito drammatico. La storia è quella di Cicillo, ragazzino napoletano, che insieme al padre sbarca il lunario posando come modello per i numerosi artisti che affollano la regione in cerca di ispirazione, o facendo da guida alle turiste della buona società inglese. Sveglissimo e bello, sa come trattare con gli stranieri, sa quello che si aspettano da lui, quello che cercano, e lui si comporta da guitto, interpretando la parte richiesta. C’è in queste descrizioni un esempio dell’ironia graffiante di Vivanti, che mette in luce la violenza implicita nel modo in cui gli Americani si avvicinano a Cicillo. Lo toccano e lo scrutano come un animale, una creatura che non ha dignità propria.
“Gli americani rimasero deliziati. Lo fecero mettere in tutte le pose, gli fecero suonare la chitarra e gli chiesero di cantare, lo riempirono di carezze e di soldi e infine vollero farselo prestare da Mrs Van Cleef. La consigliarono anche di portarlo in America: “Diventerebbe la moda, il capriccio del momento!” dissero le signore. “La gente verrebbe ai tuoi ricevimenti per vederlo, proprio come vanno ai concerti di Paderewski. Vale tanti dollari quanto pesa!”
Leggendo, non posso non pensare agli zoo umani di fine ‘800, in cui donne e uomini di etnie considerate esotiche e inferiori venivano esibiti per il divertimento degli spettatori, o presentati in quadri viventi che esaltavano i meriti del colonialismo. Come anche, nel modo in cui i viaggiatori stranieri di Vivanti cercano in Italia l’immagine sognata attraverso l’arte, ritrovo il processo di appropriazione nei confronti di un Oriente sognato e rimasticato attraverso il filtro occidentale che Edward Said svelerà in Orientalismo. Non certo perché Vivanti potesse avere consapevolezza di quei meccanismi secondo parametri a noi contemporanei, sarebbe anacronistico. Ma certo è stata capace di cogliere le contraddizioni del tempo, intuire le implicazioni dello sguardo coloniale e muoversi in un certo relativismo culturale. Certo per ragioni di fede politica è stato per lei più facile svelare le prepotenze inglesi. Intorno al 1925 scrive un reportage di viaggio dall’Egitto, pubblicato a puntate su La Stampa e poi in volume con il titolo di Terra di Cleopatra, in cui si prende gioco dell’atmosfera sognante rispetto all’Oriente, della passione per le mummie e le piramidi, e lancia sferzate verso il colonialismo (inglese). Un’eco della curiosità morbosa e sensuale per l’esotico si trova anche nel racconto Un tenebroso amore, contenuto nella raccolta Gioia!. Qui, una figura di donna, esibita a teatro come Quadro allegorico vivente della guerra insieme a cani ammaestrati, prestigiatori cinesi e baritoni francesi, solletica le voglie di un marito borghese. È vero, come confessa all’amico, che ha avuto tante amanti, ma quelle erano tutte bianche, mentre lui rimpiange di non aver approfittato dell’occasione di sperimentare qualcosa di diverso quando era in Libia.
“Tu sai che quando ero in Libia le donne indigene, per me.... posso dire che non esistevano. Le avevo in orrore colle loro forme nere e le loro chiome lanose.... Ebbene, strano a dirsi, partendo, quasi non ero ancora a bordo che già provavo come un senso di rammarico.... che so io!, di rimpianto; come se avessi mancato qualche cosa, come se fossi passato accanto a un fiore senza coglierlo, a una sensazione senza provarla…”.
L’ironia qui si trasforma in grottesco attraverso la tecnica del rovesciamento, a cominciare da un’inversione dei capitoli nella progressione del racconto, per cui l’epilogo arriva poco dopo l’introduzione. L’intento non è quello di prendere le difese dei popoli colonizzati, ma di mettere in ridicolo la costruzione di un fantasma del desiderio che non ha nulla a che vedere con la persona reale. Nel racconto questa finzione è messa in evidenza dal fatto che la donna che fa perdere la testa al marito è in realtà un’attrice italiana, che ogni sera si tinge la pelle con un preparato speciale che può essere tolto solo da un altro preparato altrettanto speciale. Ossessionata a sua volta dall’Africana, con la quale si confronta, la moglie coglie al volo l’occasione di sostituirsi alla rivale sul palco, usando il famoso preparato. Il suo tentativo di affascinare il marito sortisce l’effetto contrario. Il pubblico ride, il marito si chiede come ha fatto a lasciarsi incantare, e lei finisce, per un errore, col doversi tenere addosso quella tinta, che non va più via, ma al massimo sbiadisce leggermente.
Se in Tenebroso amore prevale l’aspetto della satira di costume, e in Terra di Cleopatra è soprattutto il suo spirito anti-inglese a parlare, in Un capriccio Vivanti riesce a toccare una verità più profonda. C’è davvero qualcosa di struggente nella consapevolezza di Cicillo che spiega a Lucy perché il loro amore è impossibile:
“Ti stancheresti del mare e di Cicillo, il tuo Cicillo di nuovo con abiti vecchi, scuri, col cappellaccio e gli stivali rotti. Eh, lo vedi, non ti piace già più…”Cicillo non esiste Lucia” disse, chinandosi su di lei e baciandole i capelli.
“Cicillo è vissuto soltanto per essere guardato e ammirato”
Il vivere per lo sguardo dell’altro è anche il tema del racconto Houp-là.
Mrs Berman è costretta dal marito, impresario teatrale, a impersonare di volta in volta diverse figure, dalla Parisian coquette alla spagnola misteriosa, secondo gli spettacoli in cartellone. Come se il teatro estendesse il palcoscenico anche dentro casa, lei e la figlia Elsie si costringono in abiti e maquillage che ne mascherano la figura, e arrivano anche a cambiare il modo di parlare, in un pastiche di parole prese a prestito da varie lingue, non sempre in modo opportuno, con un effetto a tratti decisamente comico:
“Bien, bon bien, la mia farm – sai che questa parola vuol dire moglie in francese – e la mia onfong e questa sei tu, bambina – vengano qui e abbraccino il loro pair.
Pair, per indicare me, è francese, sai…è pronta la cena?”
Durante una delle loro serate ricevono come ospite un certo Herr Müller. Tra lui ed Elsie nasce un sentimento immediato che però sembra non trovare mai una corrispondenza. È come se i due giovani non riuscissero mai a vedersi veramente per come sono, e il racconto si costruisce per contrappunti, riuscendo a rendere, con un gioco di sovrapposizioni di immagini, la sensazione di due sguardi che proseguono in parallelo senza mai fare un vero sforzo per incontrarsi.
“Herr Müller tornò a casa coi capogiri. Tutte le dolci ragazze tedesche che aveva visto e a cui aveva pensato sfollavano ora dalla sua mente – una schiera di tüchtige Hausfrauen bionde, dai volti miti – lasciandogliela vuota per questa giovinetta nuova e selvaggia (…) era diversa da tutto e da tutti, era come la pagina di un romanzo, il fantasma uscito da un sogno(…) Elsie inanto, con le mani sul volto, giaceva al buio, nella sua stanza. Onde grandi di vergogna e di mortificazione le si frangevano nell’anima. Si vergognava di una madre vestita con quel bolero e con in testa il pettine spagnolo, si vergognava di se stessa e della sua chitarra, e anche del signor McCann e di tutti gli attori, e di tutti quegli amici cenciosi. Le bottiglie e I bicchieri che bighellonavano qua e là per la stanza, i sandwich indifferenti, l’inflessibile scatola di sardine, tutto danzava con beffarda atrocità davanti ai suoi occhi chiusi, alternandosi alla visione del volto biondo della sua nuova conoscenza”.
Lui rinnega le ragazze bionde, lei rinnega se stessa. Cercando di togliersi il travestimento da Houp-là, figurina del teatro e della finzione, assume quello, presunto, di un’ideale casalinga tedesca. Quando Müller tornerà per chiederle la mano, finalmente i loro occhi si incontrano:
“I loro occhi si incontrarono, dritti e crudeli. Era questa la piccola Houp-là, la piccola selvaggia, affascinante Houp-là per sposare la quale lui aveva percorso tremila miglia…questa sporca, brutta copia delle api industriose di casa sua?”
Elsie, per salvarsi dall’umiliazione, finge di essere la cameriera, e prende il messaggio del giovane pretendendo che la famiglia è fuori casa. Malgrado tutto, prevale il lieto fine. Tranne che in Un Capriccio, che termina con il suicidio di Cicillo, i personaggi di Vivanti si salvano da un destino tragico grazie alla capacità della loro autrice di farli rientrare nei ranghi del buon senso. Francesca di Perfetta non si dispera troppo a lungo per la partenza di Karl, e nella carrozza che la riporta a casa, prende la mano del marito in un gesto consueto di affetto. Elsie di Houp-là è ben contenta, una volta diventata Frau Müller, di aver svelato in tempo l’inganno, non dover essere costretta a sostenere il travestimento e l’opera forzata di seduzione, e poter ingrassare in pace. Questo sguardo disincantato e benevolente nei confronti del matrimonio borghese, e dell’amore in genere, si ritrova anche nel racconto Il segreto della Felicità (Zingaresca), in cui elencando i vari tipo di mariti in cui una donna può incappare, si conclude che il migliore è quello del “marito solito”, di cui si conoscono a menadito vizi e virtù. Non c’è però rassegnazione o senso del limite, quanto una consapevolezza ironica rispetto alle illusioni che noi stessi ci creiamo.
Nelle lettere a Carducci, come nel ritratto che ne dà in Apollinea Fiera, ma anche nei bozzetti di vita familiare che restituisce nei racconti dove mescola finzione e autobiografia, si capisce che per lei l’affetto profondo non può essere disgiunto da una bonaria derisione, che l’amore vero confina con un compagnonnage basato sulla capacità di prendersi in giro reciprocamente. D’altronde lei è stata capace di trattate con ironia anche il sentimento più sacro e ammantato di tabù che conosciamo, ovvero la maternità. The true Story of a Wunderkind told by its mother, Annie Vivanti, rivela già nel titolo un paradosso. È la storia vera di una bambina, ma raccontata da sua madre, ovvero con un occhio parziale. Fin dall’inizio riconosciamo la capacità dell’autrice di prendersi gioco di tutto. Dei modi capricciosi e geniali della bambina, delle opinioni delle persone e delle loro reazioni di volta in volta esagerate, ma anche di se stessa, che per prima ha un rapporto ambivalente con il genio. Non vorrebbe che sua figlia diventasse come uno di quei bambini prodigio che le appaiono come scimmiette ammaestrate, eppure è lei stessa che la spinge verso il violino, che le inculca l’idea che nello strumento ci sia un mondo fatato da scoprire. Quello che è certo è che il talento della figlia fa emergere una verità innegabile eppure spesso taciuta: i figli non ci appartengono del tutto, perché geni o no, tutti hanno prima o poi “occhi profondi e solenni con i quali contemplano cose che le madri non riescono a vedere”.
Da questo racconto Vivanti trae un romanzo, sempre in inglese, che sulla scia del successo internazionale traduce anche in italiano con il titolo I divoratori, facendo un secondo ingresso trionfale nel panorama letterario nazionale. Questo processo di autotraduzione non era inconsueto per lei, e anzi lo affronta con la consapevolezza di chi sa che muoversi tra diverse lingue vuol dire anche muoversi tra diverse visioni del mondo.
Nella prefazione al libro scrive:
“quando scrissi il mio primo romanzo in inglese, e me lo vidi dinnanzi, lungo e corretto sotto il suo titolo “The Devourers”, mi dissi: “Ma io ho sbagliato! Questo è un libro italiano!” mi pareva di vedere, sotto al severo abito del linguaggio inglese, spuntare due piedi nudi, memori di tarantelle; sotto al britannico cappello del titolo girare due occhi meridionali, cupi e focosi e, chiuso sotto la rigida copertina anglosassone, udivo battere il turbolento cuore latino, che i miei padri hanno lasciato – eredità preziosa – nel mio petto.”
Se questa introduzione è in parte una teatrale captatio benevolentiae, ecco che qualche riga dopo entra più nel dettaglio:
“Eccolo ora adorno di sonanti aggettivi latini, cinto dell’ampio fraseggiare italico come da una sciarpa vermiglia. Lucide similitudini gli pendono come anelli d’oro dalle orecchie, e il titolo feroce gli è piantato come un cappello da brigante in testa. Eppure, ora che lo vedo così, mi pare che somigli un poco a un inglese travestito da ciociaro. Perché? Forse perché fu pensato e scritto lontano dal vivido sole italico che illuminò la mia infanzia, lontano dalle tempeste che cinsero di fulmini e di fragori la mia adolescenza. Forse, mentre lo scrivevo nella Casa Grigia del lontano Hertfordshire, le tinte calme del paesaggio inglese sono penetrate nelle pagine, smorzandone i colori troppo vivi, le voci troppo alte.”
Vivanti era ben consapevole delle richieste della lingua, e anche della necessaria distanza che serve a volte alla scrittura.
Se alcuni temi dei Racconti americani si ritrovano anche nella produzione successiva, se la Storia di Vivien appare in varie forme, come se il nodo di questo rapporto avesse bisogno di ulteriori passaggi prima di potersi dichiarare chiuso, è certo che non cerca di riproporre questa produzione in Italia, malgrado le insistenze dello stesso Carducci. Mancano dei documenti che ne spieghino la ragione, ma possiamo supporre che pur potendo farlo, non abbia voluto. Forse sentiva che la traduzione le avrebbe richiesto uno sforzo eccessivo, che avrebbe dovuto cambiare qualcosa. Quel che è certo è che questi racconti sono piccoli gioielli che è bene aver recuperato. Come è bene recuperare anche la voce di Annie Vivanti, tra le altre, per il suo modo modernissimo di essersi saputa interrogare su tutto e aver risposto con ironia, prendendosi gioco, fino alla fine, anche del personaggio che lei stessa aveva creato, e, cosa difficilissima, della sua stessa scrittura. In diversi racconti dialoga con l’io narrante, racconta le difficoltà della composizione, dell’urgenza, gioca con la dispersione che prende lo scrittore nel cercare l’argomento, per cui il soggetto dell’articolo diventa la difficoltà stessa di trovarne uno, in un guazzabuglio di incipit e articoli scritti a metà (La scelta dell’argomento, in Zingaresca). Fino ad arrivare, proprio nella prefazione ai Divoratori, a una poetica dei personaggi che sembra riecheggiare Pirandello, impegnato negli stessi anni nell’elaborazione del rapporto dialettico tra creature e autore, tra verità e finzione:
“In breve le mie creature non mi disubbidirono soltanto: divennero i miei padroni. Mi tormentarono, mi rattristarono. Morivano quando non volevo, si innamoravano della gente sbagliata. Quelli che dovevano essere semplici comparse erano sempre lì, parlando forte, imponendosi; mentre quelli che io avevo destinato alle parti principali sparivano, si tenevano nascosti per degli anni e capitoli interi, poi tornavano fuori quando io non li volevo più”
Il risvolto di questa presa di coscienza dei personaggi è che distruggono la “tesi dello scrittore”, sacrosanta e intangibile, che finisce per essere divorata dalla Verità della finzione, in un ribaltamento che è anche filosofico, esistenziale:
“Talvolta ho pensato che anche al Maggiore degli Autori deve far pena vedere noi – noi inconsci della cordetta che abbiamo infilata nella testa – correre per vie traverse, recitar parti non destinate a noi, guastare le situazioni, precipitare le catastrofi,
volgere in tragedia o in farsa la Grande Narrazione che egli aveva ideata perfetta”.
E a rileggere queste righe appare ancora più evidente la sua consapevolezza, quando rispondeva a Borgese, che l’ironia leggera che ha disseminato in tutta la sua scrittura è davvero frutto di un aspro e tormentato travaglio, un lavoro continuo di scavo nella profondità dell’esistenza.