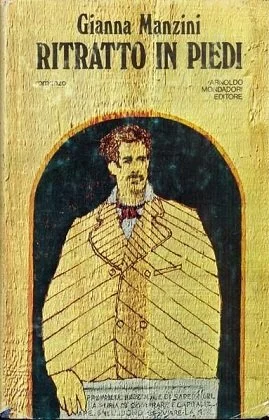di Beatrice La Tella
«Un tempo li guardavo sorridendo, e nel piacere di quel sorriso palpitava quasi una larva di complicità, una specie di festosa ammissione; ora li guardo con un turbamento che non ha nulla a che fare con l’intesa facile di allora».
La prefazione della scrittrice Gianna Manzini in apertura della sua raccolta Arca di Noè distingue con luminosa precisione le due anime che ne tendono l’intreccio, biforcazione di un rapporto ambiguo e mai pacificato con l’animalità.
Il libro è tornato sugli scaffali italiani alla fine di marzo, settimo volume della collana Libertarie che Rina Edizioni dedica al recupero di autrici sommerse della nostra letteratura, e raccoglie ventitré storie differenti tra loro per lunghezza, periodo di stesura e approccio, ma tutte accomunate dalla presenza centrale (cruciale, in effetti) di uno o più animali.
Gianna Manzini nasce a Pistoia nel 1896. Esordisce nel 1928 con il romanzo Tempo innamorato, entra a far parte della rivista «Solaria» e vince il Premio Campiello nel 1971 con Ritratto in piedi. Continuerà a scrivere e frequentare l’ambiente letterario fino alla morte, avvenuta nel 1974.
Tarlo e ossessione della sua ricerca letteraria resterà sempre «il tema degli animali», inesauribile fonte d’ispirazione, oggetto di scrittura irrinunciabile: «Eh, questo, no; questo no. Questo lo salvo e lo salverò finché campo. È un regno. Non si può passarsela d’un regno». Ed è questo il reame che Manzini esplora in declinazioni ricche e multiformi nel corso di tutta la sua carriera di autrice, riunendone le narrazioni in raccolte, continuando a ragionarle, a densificarle, interrogandosi senza risposte definitive in un rapporto impossibile da ritenere finalmente stabilito – fisso come in una cornice, o in uno stemma araldico, tanto presente nell’opera stessa – ma sempre cangiante.
Arca di Noè è in primo luogo un “bestiario di epifanie”: l’incontro con la fauna è sempre pietra di inciampo per una riflessione inattesa, in linea con l’assioma di Levi-Strauss per cui tutti gli animali sono «buoni per pensare». I modi in cui però Manzini articola le sue storie sono estremamente diversi, talvolta persino contraddittori. Vi sono racconti dall’approccio più innocuo, come ad esempio “Un cavallo”, laddove con innocuo non si intende affatto meno doloroso – “Un cavallo” è infatti una storia triste e cruda – ma semplicemente meno propenso a riconoscere lo scarto ineludibile che separa l’autrice dalla bestia, che viene infatti letta in chiave antropomorfa; o “I passerotti”, basato sul parallelismo tra la leggerezza di un danzatore e quella apparente degli uccelli; o ancora “Amicizie pericolose”, racconto ironico incentrato sulla quieta pace che intercorre tra un gatto e due topolini, autentici personaggi favolistici dai tratti umanizzati. L’animale svolge in questi casi un ruolo metaforico, si fa simbolo di stati d’animo, rimpianti, idiosincrasie, proiezioni di emotività che l’autrice ben conosceva. Esempio particolarmente riuscito è senz’altro il racconto “Il falco”, in cui l’uccello ferito costretto a un’indignata immobilità incarna la frustrazione della protagonista bambina, impotente in quell’età di mezzo che non è ancora adolescenza, fitta del peso insostenibile di una nobiltà umiliata. Un processo analogico raffinato e insieme opprimente, esaltato da scelte lessicali levigate che non sottraggono nulla alla carica emotiva della narrazione.
Interessante è poi “Una vacca”, racconto di un idillio campestre dalla conclusione cruenta, in cui lo scarto col pensiero animale trova una dimensione diversa, arrivando a una forma di panteismo peculiare, che paragona la placidità del bovino a una fusione con l’ambiente:
Essa era dunque anche il prato; ma di più aveva vicina la vita dell’albero,
percorso e nutrito dalle radici alle foglie.
Mentre intorno alla bestia esplodono morte e violenza nulla scalfisce il suo serafico stare al mondo, adesso inaccessibile all’autrice.
Manzini comincia così a esplorare una dimensione di ignoto contenuta e scatenata dall’animale, ciò che dal «sorriso» la conduce al «turbamento»: non scorge più negli occhi di civette, gatti, serpenti, solo un senso di «complicità», ma qualcosa d’altro, che non è più fonte di tenerezza ma, al contrario, spaura, «l’impressione che gli animali, sul conto nostro, la sappiano più lunga di noi, sul conto loro». Il bestiario manziniano svela così il suo secondo volto: gli animali sono sì specchi, metafore, riflessi dell’umano, ma possono anche farsi testimoni di un’alterità assoluta e preclusa, un’alterità carica di saggezze serbate da becchi, artigli e spire, forze misteriose cariche di un senso di minaccia.
Scrutando nello sguardo di un rapace nel racconto “La civetta”, la voce narrante è assalita da una sensazione inedita:
All’istante, t’accorgevi d’aver subito una violazione, d’essere senza riparo, d’averle fatto toccare un fondo segreto, insomma di trovarti in sua balìa.
L’animale si trasforma ora in soggetto attivo: non più oggetto risemantizzato dalla scrittura ma entità che sfugge alla scrittura stessa, che scandaglia di rimando l’occhio di chi lo osserva, che impartisce insegnamenti. Maestri sono non solo le bestie selvatiche ma anche quelle percepite nell’immaginario collettivo come domestiche: nel racconto che Manzini dedica alla memoria dei suoi gatti – «Sapeva tutto di me; e io quasi nulla di lui; di qui ha origine la mia schiavitù al suo ricordo» – non mancano scoperte:
Imparo molte cose: per esempio che non ci si deve mai burlare di ciò che si ama. Io spesso mi burlavo di lui. Lui di me, mai. È la lezione d’una animale. Ne terrò conto.
I soggetti-animali acquisiscono un’austerità che non intacca i legami affettivi che li stringono all’autrice, li rende semmai più grandi e articolati. Si esce dalla logica binaria di un rapporto verticale in cui l’umano è posto sopra l’animale, per approdare a una dimensione reticolare di connessioni in cui non vi sono egemonie di sorta.
Tornando a guardare Arca di Noè nel suo complesso la si può guardare come a una raccolta di miniature: i racconti sono cesellati, la ricerca stilistica dell’autrice condensa una lingua lirica e a tratti sovrabbondante, fortemente poetica, evocativa senza essere leziosa, come quell’ «accordo dell’inverno con gli uccelli, rapidità senza peso, e con i gatti che mandano a spasso il proprio fantasma». È un trionfo di astrazione, di corrispondenze e tentativi di approdare a nuovi significati, illuminazioni a partire da quel «piccolo e segreto» tanto caro ad Anna Maria Ortese, che con Manzini condivide la riflessione di una vita sull’animale. Lo sguardo arriva fino al microscopico, al sottomondo degli insetti: “Una larva” e “Un bruco” sono racconti brevissimi, quasi a ricalcare le dimensioni dei loro personaggi, in cui però il senso di minaccia e violenza lambisce la pagina fino a ingigantirla. Emblema di questo slittamento sono anche i due racconti dall’espediente biblico “Il sangue del leone” e “Il cavallo di San Paolo”, reinterpretazioni argute di episodi celeberrimi che scalzano la centralità dall’uomo protagonista in favore dell’animale che ne accompagna l’impresa.
La voce di Manzini rende la raccolta accesa e vivissima, lasciando intravedere il suo costante lavorio interiore. Una sensibilità profonda e spiccata aleggia su tutte le storie, accomunandole in una συμπάθεια ora crescente, ora nascosta, ma che non manca mai e scaturisce anzi dall’atto narrativo stesso, al punto che la visione di una trota pescata spalanca le porte all’atto immaginativo e di conseguenza al dolore:
Smisi di raccontarmi il probabile romanzo di ogni trota, perché quella lì, moribonda e meno che mai rassegnata, intimidiva e faceva ripiegare la mia immaginazione.
Accogliere l’alterità attraverso il racconto equivale ad accoglierne l’ingiustizia subita: «Anche a considerare una pianta mi pareva di trovar subito una storia vera di che soffrire».
Il mondo animale viene dunque a configurarsi per Gianna Manzini come il fondamento della sua poetica e, per estensione, del suo intero immaginario. Un mondo immenso, labirintico, fitto di arcani e di violenza, ma anche di ironia e legami empatici inspiegabili. La voce dell’autrice si sporge sulla soglia dello sconfinamento oltre l’umano, senza mai attraversarla del tutto, ma intuendone tutta la vertigine, la perturbante eco che risponde al richiamo. I racconti sono figli del loro tempo, ne recano i connotati linguistici, l’impronta a tratti antropocentrica, ma sono anche invasi da una modernità sconcertante, impercettibile in superficie, enorme e innegabile una volta che la si è intravista. Nel suo sguardo timido e grondante di immedesimazione, Arca di Noè cova il germe brulicante e profondo di inquietudini future.
«Ma se la bestia fisserà libera davanti a sé, sento che avrò paura».