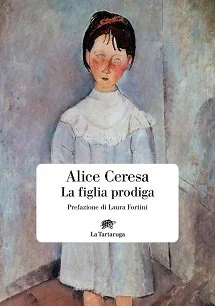di Anna Ditta
Esistono due racconti quasi omonimi di due scrittrici italiane, entrambe emigrate da un’isola: il primo è “La casa paterna” della Premio Nobel Grazia Deledda (Nuoro, 1871 – Roma, 1936) pubblicato nel 1890 nella prima raccolta dell’autrice, intitolata “Nell’azzurro”; il secondo è “Casa paterna” dell’autrice siciliana Maria Messina (Palermo, 1887 – Pistoia, 1944), rimasto inedito e pubblicato postumo da Sellerio nella raccolta omonima del 1981. Seppur declinato in maniera diversa nei due racconti, il ritorno alla casa abitata un tempo insieme alla famiglia d’origine è il centro intorno al quale ruotano le vicende delle due protagoniste, così come è comune nei due testi, nonostante il diverso intreccio narrativo, il contrasto tra la memoria dei luoghi e degli affetti da una parte e la realtà inappagante del ritorno dall’altra. Sugli stessi temi, alcuni anni più tardi, è tornata una terza scrittrice, stavolta non isolana ma a tutti gli effetti “straniera”. Alice Ceresa (Basilea, 1923 – Roma, 2001) nata in Svizzera e trasferitasi a Roma nel 1950 ha dedicato al nostos femminile il suo romanzo d’esordio “La figlia prodiga”, pubblicato per la prima volta nel 1967 da Einaudi, vincitore del Premio Viareggio Opera Prima, e tornato in libreria lo scorso anno con La Tartaruga e la prefazione di Laura Fortini. Ma anche il racconto lungo “La morte del padre”, uscito per la prima volta su Nuovi Argomenti nel 1979 e ripubblicato da La Tartaruga nel 2022, con un ritratto dell’autrice a cura di Patrizia Zappa Mulas.
Troverete in questa sezione la seconda parte di questo percorso, con un focus su Alice Ceresa e Anna Banti.
La prima parte di questo saggio, con il focus su Grazia Deledda e Maria Massina, potete trovarla QUI
I ritorni di Ceresa: “La figlia prodiga” e “La morte del padre”
Rispetto all’esplorazione stanza per stanza della Jole di Grazia Deledda, scritto in forma diaristica, e al racconto con una trama lineare come quello di Maria Messina, i due ritorni di Ceresa (il romanzo La figlia prodiga e il racconto lungo La morte del padre) appaiono molto distanti non solo per l’epoca di redazione ma anche per il contenuto originale e per la forma sperimentale. Nel suo romanzo d’esordio del ’67 Ceresa ribalta la tradizionale parabola biblica del figliol prodigo (il ritorno per eccellenza) declinandola al femminile. Torna la dimensione “economica”, ma lo sperpero, in questo caso, riguarda il patrimonio patriarcale della famiglia, con il suo insieme di doveri, tradizioni, costrizioni. E per la figlia “degenere” non esiste un ritorno possibile perché: “si vedono male le figlie sperperare patrimoni paterni, precipitare nella desolazione una casa per via della loro defezione e riguadagnare infine / il posto d’onore / nella famiglia previamente abbandonata / per il semplice fatto di avervi fatto ritorno”.
Ne “La morte del padre” la dimora paterna è ritrovata, a differenza dei racconti di Deledda e Messina, non per scelta o nostalgia, ma per la prassi inesorabile del lutto. Ceresa compie uno scandaglio degli spazi esteriori ma soprattutto delle “geografie personali” dei tre figli tornati nella casa paterna alla scomparsa del padre. La figlia maggiore, la figlia minore e il figlio sono i tre personaggi (tutti senza nome) che nel breve testo si confrontano con la morte del padre in tutta la sua materialità e nel suo valore simbolico. La dimensione spaziale è ancora una volta fondamentale: c’è quella delle rispettive camere, dove vengono passati in rassegna i pensieri notturni, ma anche quella della casa, che diventa zona di metamorfosi e mutamento proprio come accade al corpo del padre: nel capitolo quattro “il padre lentamente si sgretola” e la casa con lui (“la casa in questa seconda notte per esempio non può vivere e lievitare pur qua e là aprendosi in minuscole frane concentriche di sabbia che piano piano faranno sprofondare nel nulla ogni centimetro quadrato di superficie e ogni cubatura di volume, se non nell’avvertimento che ne può fornire il mondo circostante”).
C’è, infine, la “posizione topografica per rapporto al padre” (il virgolettato è dell’autrice) con cui durante le due notti prima del funerale i tre figli “attraversano” il distacco definitivo dalla figura paterna, con le proprie personali conseguenze. Si potrebbe obiettare che la presenza del figlio maschio nel racconto sposti in qualche modo l’attenzione dai due personaggi femminili, ma in realtà la reazione del figlio alla morte paterna prende una direzione così diversa da mettere in risalto quella delle due sorelle. Il figlio, infatti “ha già chiuso i suoi conti con il padre e a poco servirebbe adesso riaprirli se non forse sul piano della ragionevolezza” e “nel rapporto dialettico con il padre non ha quindi senso ritornare sui propri passi quando colpe e giustizia ogni giorno riaffiorano nel presente non consentendo comunque soluzioni definitive”. Un quadro ben distante sia dalla situazione della figlia maggiore, con la sua incorporazione e “digestione” paterna, sia da quella della figlia minore, intenta a sezionare e tagliare “nel proprio interno” la propria infelicità e fa i conti con una “avvenuta sostituzione del padre vivo con il padre morto che d’ora innanzi l’accompagnerà” e con “un altro abbandono e un’altra solitudine”.
Ritorni distopici: un cenno a “Le donne muoiono” di Anna Banti
Un ritorno sui generis, in quanto distopico e collettivo, ma che si può comunque porre in dialogo rispetto a quelli realistici esplorati finora, è quello delle donne che non hanno ricevuto il dono della “seconda memoria” nel racconto di Anna Banti che chiude la raccolta “Il coraggio delle donne” (La Tartaruga, 1983) e che si uniscono alle comunità femminili che cercano di perseguire tale capacità. Estromesse dall’immortale memoria di cui possono godere gli uomini riguardo alle loro vite precedenti, le donne del racconto di Banti si rifugiano in “certi istituti fra il collegio e il club” con “norme speciali di vita e di contegno, sorta di chiese senza confessione” in cui portano “tutte sul capo un velo nero, come le antiche monache: e molte eran quelle che dopo averle frequentate con assiduità, lasciavano definitivamente la casa paterna” .
“Il mito arcaico di Eva colpevole e punita vi serpeggiava”, scrive Banti, “a insinuare che certo la donna aveva peccato più dell’uomo, con maggior coscienza, e bisognava dunque che più dell’uomo soffrisse per meritare l’eternità del ricordo”. Ancora una volta, dunque, il senso di colpa è connaturato al percorso delle donne (stavolta di tutte le donne come collettività). In questi istituti, le adepte si esercitavano in “una ginnastica della memoria portata fino all’esasperazione mentale” e talvolta si diffondeva la notizia di un caso di comparsa di seconda memoria, che però puntualmente finiva nella scoperta di una “innocente mistificazione”.
In questi casi, dopo essere stata “messa a letto, sopita con forti calmanti”, la ragazza veniva “restituita alla famiglia”. Un ritorno, tuttavia, decisamente insoddisfacente, al fianco di “madri taciturne o svaporate, padri e fratelli insensibili, tutti presi dal senso di una vita vissuta minuto per minuto, senza pensiero del futuro, senza ombra di tenerezza e di melanconia”. Una disgregazione familiare cui Banti fa seguire nel racconto la graduale concezione dell’esistenza in comune femminile come “difesa” ma anche come “libertà di consegnarsi ognuna al proprio istinto, alla propria inclinazione naturale” e dunque la nascita della “prima generazione di quelle grandi poetesse che, a tutt’oggi, si ammirano alla pari col leggendario Omero”, in grado di mettere in pratica una “straordinaria innocenza di riflessi” e di produrre armonie “d’una nitidezza incrinata” che gli uomini difficilmente potevano sopportare.
In conclusione
Scriveva Alice Ceresa: “L’ordine delle famiglie, è risaputo, non prevede le figlie prodighe. Non tanto perché infatti non è mai stato invogliato a codificarle in una storia, dato che di storie non raccontate ne esistono altre e di peggiori quanto più sottilmente perché non appena sono prodighe le considera figlie degeneri o figlie sbagliate e dunque figlie solo fino a un certo punto”.
Le protagoniste che abbiamo passato in rassegna e che ritornano alla casa paterna sono tutte in qualche modo “degeneri” o “sbagliate”, difformi rispetto alle aspettative familiari e sociali. Jole è condannata per la sua vanità e sperimenta le risa e le maldicenze dopo le sue prime pubblicazioni; Vanna lo è per la sua povertà ma soprattutto per il suo “cervellino romantico”, espressione con cui i familiari inquadrano il suo desidero di una vita felice o almeno non tormentata dal marito. Entrambe, come progenitrici della figlia prodiga di Ceresa sono anime inquiete che hanno osato sperare e sperperare, seppur con intensità differente. Le due figlie de “La morte del padre” non sono diverse: hanno sperimentato l’uscita dal nucleo familiare e fanno i conti di ciò che resta della propria prodigalità dopo che il patriarca è venuto a mancare. Distacco, abbandono, ritorno, colpa, sono dimensioni con cui ciascuna di queste protagoniste si trova a fare i conti. Mettersi sulle loro tracce è stato un viaggio piacevole e il merito è forse di quella “prima generazione” di “grandi poetesse” (o meglio, di scrittrici) di cui parlava Banti e che lungi dall’appartenere a un futuro distopico e di là da venire, già ci accompagna.