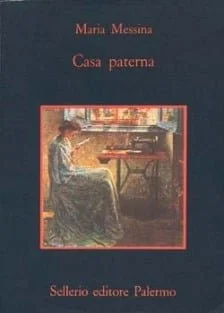di Anna Ditta
Esistono due racconti quasi omonimi di due scrittrici italiane, entrambe emigrate da un’isola: il primo è “La casa paterna” della Premio Nobel Grazia Deledda (Nuoro, 1871 – Roma, 1936) pubblicato nel 1890 nella prima raccolta dell’autrice, intitolata “Nell’azzurro”; il secondo è “Casa paterna” dell’autrice siciliana Maria Messina (Palermo, 1887 – Pistoia, 1944), rimasto inedito e pubblicato postumo da Sellerio nella raccolta omonima del 1981. Seppur declinato in maniera diversa nei due racconti, il ritorno alla casa abitata un tempo insieme alla famiglia d’origine è il centro intorno al quale ruotano le vicende delle due protagoniste, così come è comune nei due testi, nonostante il diverso intreccio narrativo, il contrasto tra la memoria dei luoghi e degli affetti da una parte e la realtà inappagante del ritorno dall’altra. Sugli stessi temi, alcuni anni più tardi, è tornata una terza scrittrice, stavolta non isolana ma a tutti gli effetti “straniera”. Alice Ceresa (Basilea, 1923 – Roma, 2001) nata in Svizzera e trasferitasi a Roma nel 1950 ha dedicato al nostos femminile il suo romanzo d’esordio “La figlia prodiga”, pubblicato per la prima volta nel 1967 da Einaudi, vincitore del Premio Viareggio Opera Prima, e tornato in libreria lo scorso anno con La Tartaruga e la prefazione di Laura Fortini. Ma anche il racconto lungo “La morte del padre”, uscito per la prima volta su Nuovi Argomenti nel 1979 e ripubblicato da La Tartaruga nel 2022, con un ritratto dell’autrice a cura di Patrizia Zappa Mulas.
Troverete in questa sezione una prima parte di questo percorso, con un focus su Grazia Deledda e Maria Messina.
La seconda parte di questo percorso, con il focus su Alice Ceresa e un breve cenno ad Anna Banti, sarà pubblicata il 14 Ottobre sempre in questa rubrica.
L’esplorazione del passato ne “La casa paterna” di Grazia Deledda
Il racconto “La casa paterna” di Grazia Deledda è composto da attraversamenti incrociati di spazi — passati e presenti — e di tempi ormai perduti. Il testo, inserito nella prima raccolta di racconti pubblicata dall’autrice sarda e dunque ancora acerbo rispetto alle narrazioni della maturità, è un resoconto in forma diaristica del ritorno della protagonista, Jole, a “R…” che lei definisce “mia piccola città natia”. Sin dalle prime righe sappiamo che Jole prova una “strana impressione” nel rivedere, dopo molti anni di lontananza, quelle che lei definisce “le mie campagne, la mia valle, il mio cielo”. La felicità di tornare a casa si affianca però al dolore e alla nostalgia di ciò che è perduto
“mi sentivo infinitamente triste: ricordavo i miei primi anni passati in quei luoghi, ricordavo i miei parenti morti, la mia mamma, il mio babbo, morti, dormenti nel cimitero che vedevo biancheggiare sull’orlo della valle, il mio fratello lontano, le mie amiche che non avrei ritrovato, che non avrebbero più riconosciuto nell’alta, elegante e ricca signora che veniva dalla capitale, la loro piccola e allegra amica d’un tempo!”
Gli stessi sentimenti contrastanti la accompagnano alla visita, pochi giorni dopo, della via e della casa paterna: da una parte la gioia del riconoscimento, dall’altra la consapevolezza che ciò che era non potrà più essere irrimediabilmente uguale al passato
“È bella, bella, non c’è che dire, ma come avrei preferito trovarla come la lasciai, vecchia, bruna, modesta. Oh, se dentro è lo stesso, irriconoscibile, a che mi serve entrare? Sono tentata di tornarmene indietro: ma no, ecco tre cose ancora nel loro primo stato: mille ricordi, un palpito del mio cuore!”
Dalla vista della vecchia porta d’ottone giunge, come una memoria involontaria proustiana, un ricordo che riguarda il padre e le lezioni di latino che decise di far prendere a Jole durante le vacanze. “Le lezioni le pigliavo da un professore nostro vicino, ma sin dai primi giorni provai una noia, un’uggia tremenda nell’apprendere quella lingua gloriosissima, antichissima, famosissima, ma anche noiosissima”, ricorda la protagonista. “Tuttavia, non volli dispiacere al babbo col rinunziare, però dal fondo del mio cuore, coi miei fervidi voti, affrettavo la fine delle vacanze, contavo i giorni, e per essere più sicura che essi passavano li segnavo... sulla porta! Eccoli ancora lì: sono quasi novanta forellini, fatti con la punta delle forbici, lungo l’estremo limite della porta”. Lo scorrere del tempo percepito come troppo lento, da ragazzina, e il desiderio di sfuggire alle imposizioni paterne mal sopportate incontrano nel presente di Jole il sentimento opposto: nel suo viaggio verso casa il desiderio è quello che il tempo si dilati (“E il treno correva, rapido, e rumoroso, adempiendo il suo dovere di «bello e orribile mostro» che I monti supera,/Divora il piano, mentre io avrei voluto che andasse lentamente, per lasciarmi rivedere bene, palmo per palmo, le mie ubertose campagne, la pianura arsa dal sole, la valle da cui salivano i primi profumi delle notti di estate, le montagne ergentesi al cielo, verdi e scoscese, i boschi scossi dalla brezza...). Nella citazione poetica tratta da “Inno a Satana” di Giosuè Carducci è possibile cogliere il riferimento a un progresso che si preannuncia come vittorioso ma che, nel caso di Jole, si lascia dietro l’amarezza della perdita del mondo passato.
Dal momento dell’ingresso in casa, prima nel giardino e poi nelle stanze, il percorso di Jole diventa un’esplorazione graduale degli spazi e dei rispettivi ricordi familiari. L’aiuola le riporta alla mente il proprio piccolo giardino coltivato con passione, la sala da pranzo le ricorda il canarino Pipy, morto dopo la partenza di lei. (“Lì, in una di quelle finestre era appesa la piccola gabbia azzurra di Pipy, il mio canarino, il mio piccolo amico gentile, morto per me, sì per me — perché, qualche tempo dopo la mia partenza, Franceschino in una sua lettera scriveva: «Pipy è morto! Dopo la tua partenza era sempre malinconico, non cantava più, e ieri mattina lo trovai morto, stecchito nella sua palazzina azzurra. Che sia morto di dolore o di vecchiaia? L’avevamo da quasi dieci anni; non è vero?». «Di dolore o di vecchiaia? Né per l’uno né per l’altra; forse — gli risposi — sarà morto di fame o di sete, perché non vi curavate di lui». E credo d’aver pianto...”). A partire da questo doppio ricordo (Pipy vivo e poi l’annuncio della sua morte) l’animale e il suo portato di malinconia diventa quasi il correlativo oggettivo del senso di abbandono vissuto da chi resta e, per converso, del senso di colpa vissuto da chi ha scelto il distacco e ne affronta le conseguenze.
Il salotto di casa è permeato di oscurità e abbandono e la sua vista provoca a Jole pena e rimorso
“Tutto è desolazione, oscurità, tanfo in questa stanza, una volta sì gaia, sì ricca di luce e di fiori (…). Ma perchè i padroni lasciano così deperire questa casa? — (…) Oh, se la mamma, se il babbo rivedessero in questo stato il salotto si caccerebbero le mani nei capelli: a me questa devastazione pare un sacrilegio. Ah, Franceschino, Franceschino, non avrei mai creduto che la vendita della nostra casa dovesse recarmi tanto dolore...”.
Doloroso è il ricordo dei genitori perduti, cui si affianca anche — in un modo che richiamerà il fratellino scomparso di Ceresa — quello di Annina, una sorellina morta da tempo (“ era così buona, così carina, e la mamma l’amava tanto che alla sua morte quasi impazzì dal dolore”). Con la vista dello specchio della camera nuziale torna il riferimento alla colpa da espiare: stavolta non la lontananza, ma quella “innocente vanità di bimba” che ama osservare i vestiti nello specchio. Deplorata sia dalla madre sia dal fratello Franceschino e poi dal confessore don Antonio, questa abitudine diventa motivo di inquietudine e poi di rimorso (“Non vorrete crederlo, eppure vi assicuro che da quel giorno, per tre mesi almeno... non gettai sullo specchio che qualche sguardo fuggitivo”).
Persino il muro che per Jole era sinonimo della scansione del tempo è scomparso, sostituito da “una casa nuova, alta, bianca, abbagliante, che m’impedisce di vedere oltre”, a riconferma dell’impossibilità per lei di ritrovare il tempo perduto. La camera della madre ricorda nascite e morti, avvenimenti che acquistano adesso centralità per Jole, mentre quelli della sua vita dopo la partenza le appaiono rimpiccioliti, se non spariti dalla sua mente. “Ed è possibile che tutti ricordino con le stesse impressioni che provo io, la casa paterna?”, si chiede senza riuscire a darsi una risposta.
Lo studio del padre è invece lo spazio del ricordo della vita di lui, medico buono e instancabile, e dell’abitudine di Jole di decorare la stanza con dei fiori freschi del suo giardino: un gesto di tenerezza che le riporta alla mente anche il momento del distacco
“il giorno innanzi che lasciassi per sempre la nostra casa, nel farvi l’ultima visita, nel portarvi l’ultimo mazzo di fiori, egli mi disse con un mezzo sorriso: — E d’ora innanzi chi fiorirà il mio studio? Anch’io sorrisi. Ahimè, le nostre labbra sorridevano: i nostri cuori piangevano!...”.
Proseguendo con la linea dei doppi ricordi, la stanza di Giannina, balia e governante, si lega ai racconti de Le Mille e una notte che lei conosceva a memoria e che raccontava a Jole davanti al camino, ma anche a quello della delusione dopo la prima pubblicazione di Jole a causa delle “risa, la maldicenza, la censura di tutti e soprattutto delle donne”.
Il racconto di Deledda culmina con la visita di Jole nella sua vecchia cameretta. Qui è la misura degli spazi a sorprenderla (“Hanno forse rimpicciolito la mia camera? No, sono io che sono cresciuta”) e lei si lascia prendere dalla contemplazione del paesaggio fuori dalla finestra, che pur non avendo niente di speciale, spinge Jole a invocazioni di manzoniana memoria e a un senso di inenarrabilità che la travolge (“O mio cielo! O miei monti! O notti passate a questo davanzale, quando La notturna reina alto levando/ In nubilosa maestà la fronte, /La sua discopre incomparabil luce/ E dispiega sull’ombre un vel d’argento... O giorni trascorsi fra lo studio e il lavoro — o sogni — o realtà — o gioie e dolori — vi ricordo tutti: — perché egualmente non posso raccontarvi?”). Il percorso termina al tavolino per scrivere, che si personifica e diventa un interlocutore immaginario per Jole: “Allorché mi assidevo innanzi a te scordavo tutto il resto del mondo che mi circondava: tu eri il mio confidente, il mio inspiratore, il mio compagno di studio e di lavoro, ed io t’amavo come un amico d’infanzia, come un essere vivente... Sparito anche tu! Ove sei? Ove sei?”.
Col giungere del buio la protagonista evoca infine la prima notte trascorsa nella sua cameretta e scorge tra le ombre “mille fantasmi, mille figurine che vi si muovono, palpitano, vivono, sorridono e piangono — vestite di bianco, vestite d’azzurro, vestite di rosa — che mi protendono le braccia, mi sorridono, danzano intorno una fantastica carola, dicendomi con dolcezza: — Siamo Jole, la piccola Jole; Jole che visse tanti anni felice in questa cameretta azzurra e profumata”. Tanti piccoli fantasmi sono ciò che resta di un tempo perduto e inaccessibile, di cui la casa rappresenta ormai solo un guscio vuoto.
Il ritorno impossibile di Vanna in “Casa paterna” di Maria Messina
La “casa paterna” del racconto di Maria Messina è tutt’altro che deserta e abbandonata: è ancora popolata dalla famiglia di Vanna, la protagonista della storia. Anzi, gli spazi si sono ingranditi con l’acquisto del “quartierino” attaccato all’abitazione, e sono arrivate anche alcune “facce nuove”, le nuove cognate Viola e Remigia, che hanno sposato rispettivamente Luigi e Nené e di fronte alle quali Vanna si sente in “soggezione” perché “alte e robuste”, mentre lei è “bruna e gracile”. Al contrario Maria è “la dolce cognata venuta molti anni innanzi nella casa paterna”. Piccola e bruna anche lei, Maria ricorda a Vanna “i bei giorni dell’adolescenza” ed è l’unica persona a cui la protagonista racconta i motivi che l’hanno spinta dopo tre anni di matrimonio ad abbandonare il marito Guido, vendere dei gioielli e imbarcarsi per tornare alla casa paterna. Vanna racconta a Maria la solitudine e la malinconia della sua vita coniugale, sulla quale sia lei sia il marito si erano fatti illusioni sbagliate («Non è colpa sua. Non è colpa mia. S’è ingannato. Ci voleva un’altra moglie»).
Ma se la casa è ancora popolata non vuol dire che sia più accogliente. Vanna percepisce dall’inizio l’ostilità delle cognate e la perplessità dei propri fratelli e della sorella minore, Ninetta, ma anche l’assenza di una calda accoglienza da parte dei genitori, ormai in balìa di Viola e Remigia perché non in grado di sostenersi adeguatamente con la sola pensione del padre. L’elemento economico, legato alla condizione femminile, torna a più riprese nel racconto sia per la mancata possibilità di provvedere a una dote adeguata per Ninetta, sia come fattore cruciale nella subalternità di Vanna nei confronti del marito («Certe cose bisogna capirle!» diceva Viola. «Quando non si porta un soldo di dote non si possono avere tante fisime!»). Di questa condizione è pienamente cosciente anche Vanna, che a Maria confida: «…Un giorno ho venduto l’orologino d’oro, una cosa inutile per me, e mi son comprato un vestitino azzurro bell’è fatto. Gli è piaciuto, e mi ha condotto a teatro, una volta (lui ha la Poltrona gratis). Allora ho provato una gran pena, perché ho capito che lui sarebbe quasi affettuoso se io non fossi così povera»). Lo stesso motivo ritorna sul finale quando, dopo essere stato richiamato da Vanna – estenuata dalle insistenze e dalle pressioni dei familiari – con una lettera di scuse, Guido rifiuta di pagare alla moglie il viaggio di ritorno verso Roma («Son venuto perché l’hai voluto tu. Io non sentivo alcuna necessità…di partire. Non sapevo di dover pagare anche il viaggio per te»).
Nel crescendo di respingimento che viene messo in atto dai familiari, a un certo punto Vanna sente che è la stessa casa paterna “mutata, trasformata” a rifiutarla ed espellerla, al suono di un reiterato «Non si torna indietro!» ripetuto delle “rose molli e profumate” del terrazzo e poi dal mare veduto dalla terrazza tanto amata, fino a un definitivo «Non si torna. Tutto cambia. I fratelli hanno un altro viso. La madre ha un’altra voce. Altre donne hanno occupato il tuo posto mentre eri lontana. E ciascuno ti accoglie, come s’accoglie una straniera di passaggio». È questo il momento in cui Vanna capisce che la casa paterna dei suoi ricordi, quella in cui aveva attribuito un nome a ogni stanza e in cui la madre era in grado di penetrare i suoi pensieri più profondi è ormai perduta, e si decide a scrivere a Guido.
La durezza e la freddezza di lui, che pure a parole dice di essere pronto a riaccoglierla in casa, spingono Vanna verso quell’unico elemento che veramente l’ha fatta sentire accolta e che è tornato in vari momenti del racconto: il mare che le richiama alla mente la sua fanciullezza e a cui aveva rivolto un’ultima invocazione: «Io t’ho passato due volte col cuore gonfio di speranze. Quando ho lasciato la mia casa e quando vi son tornata. O mare! Tu solo m’hai fatto festa la notte del mio ritorno… Potrò ripassarti con un po’ di fede nel cuore?». Fallito anche l’ultimo tentativo di riappacificazione col marito, Vanna sceglie di affidarsi al mare, riconoscendolo ormai come sua unica vera casa.