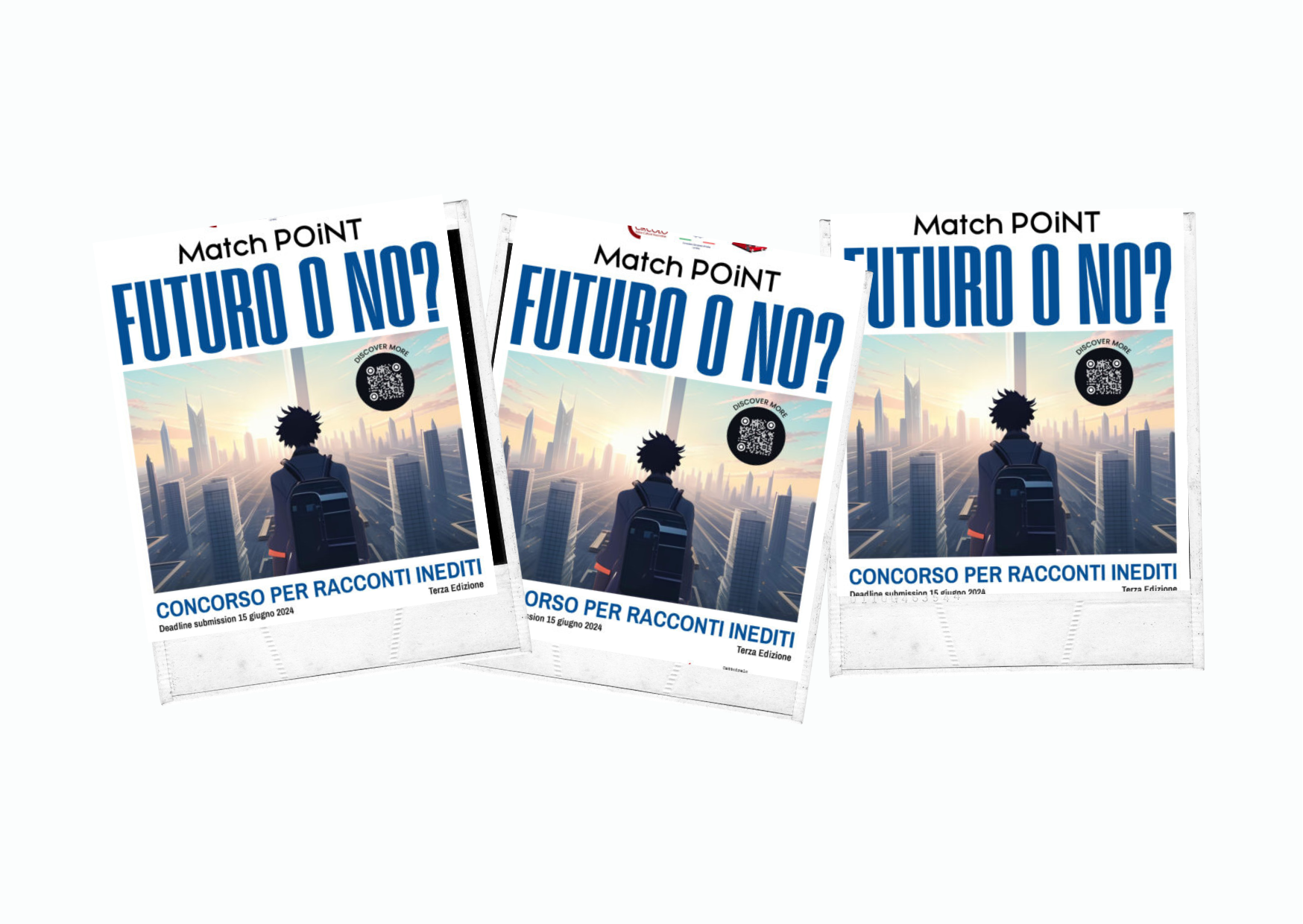Primo classificato
In Rabbia, l’autrice mette in scena la distopia con un racconto apocalittico e delicato. Dalla finestra si guarda un mondo desolato dove vagano i cani. Lo scandire del tempo è dettato dal prosciugarsi del lago e ne rimane poco. Ma la promessa fatta a un bambino di finire di illustrare una fiaba va mantenuta. Tutto il racconto è permeato dalla scrittura precisa, dal tono bilanciatissimo e da un senso di premonizione, mai dichiarata, eppure molto profonda.
RABBIA
di
Flavia Catena
3 aprile
L’ultimo airone ha lasciato l’isola ieri. Sono migrate le anatre mandarine e le oche canadesi. Non vedo un cigno da settimane e il bianco che fa capolino dal canneto è quello delle folaghe con i loro becchi curvi e gli scudi cornei.
L’acqua del lago si è ritirata ancora di cinque o sei metri, svelando un fondale di sassi e spazzatura, tappi di bottiglia arrugginiti, ami, qualche straccio di rete. La luce densa che guizza sulla terra scoperta, tra le celle fangose e le crepe, mi riporta alla mente le carpe che mio padre pescava quand’ero bambino. Mi facevano paura le loro bocche enormi, spalancate da una preghiera silenziosa, e i loro occhi inespressivi, la sclera larga, la pupilla ridotta a un punto.
«Provano dolore?» chiedevo a papà, sempre con la stessa voce bassa e lo sguardo che sfuggiva agli scatti delle pinne, al rumore dei corpi che sbattevano contro le pareti del secchio.
Lui, non sapendo mentirmi, rispondeva: «Sì, ma dura poco.»
5 aprile
«Quanto tempo ci resta?» mi ha chiesto Luisa stamattina, a letto.
Fino a pochi anni fa aveva l’abitudine di dormire distesa sulla schiena, un cuscino sotto i piedi gonfi e due sotto la testa; adesso la trovo sempre rannicchiata, le ginocchia spinte contro il petto, il corpo adagiato sul fianco. Dal lenzuolo emergono solo i suoi capelli bianchi: mi tocca sollevarlo per vederla e farmi vedere.
«Forse un paio di mesi, al massimo tre», le ho risposto, facendo un calcolo approssimativo della velocità a cui l’acqua è evaporata nelle ultime settimane.
«Allora dobbiamo finire il libro il prima possibile.»
Ho guardato le carte accumulate sulla scrivania, pile che si macchiano di caffè annacquati e ore lente, prima di tornare alle mie operazioni mentali, nella speranza di essermi perso qualche numero, qualche giorno prezioso.
«Glielo abbiamo promesso», ha aggiunto Luisa.
Non lo dice ma teme che mi fermi, che mi arrenda. E a volte penso che dovrei, che sarebbe tutto più facile.
Il resto della giornata lo abbiamo trascorso in silenzio a combattere contro la fame, la stanchezza e le troppe pagine ancora vuote.
10 aprile
«Senti? I cani... se ne sono andati?»
Luisa mi ha svegliato alle quattro del mattino, scuotendomi. Non ricordo che cosa stessi sognando, ma era un bel sogno, di quelli che ti lasciano addosso una leggerezza piacevole. Ho acceso la lampada sul comodino e mi sono messo in ascolto.
Il vento frustava i rami del gelso, facendone battere le estremità contro il vetro della finestra. Alla sua voce si aggiungeva a tratti un cigolio ripetuto, che variava di intensità a seconda della direzione in cui tendevo l’orecchio. Forse era il cancello che si apriva, la banderuola che ruotava. Mi ci è voluto qualche istante per sentire oltre quel rumore.
«Sì, sembra che se ne siano andati».
Dalla terraferma e il vecchio paese si sollevava un silenzio spettrale. Era come se il vento soffiasse solamente sulla nostra isola; intorno il mondo era zitto, vuoto e immobile. Nelle case, voragini buie abbandonate da mesi in cui non entrava neanche un raggio di luna, le porte socchiuse non sbattevano né stridevano più.
«E se...»
Non gliel’ho lasciato dire e ho pregato che cancellasse dalla mente l’immagine a cui si era già aggrappata.
«Dormiamo ancora un po’, vuoi?»
Ci siamo stretti sotto il lenzuolo. Il battito del suo cuore ha coperto ogni altro suono e la sua assenza.
17 aprile
I cani sono riapparsi stanotte e ci hanno svegliati con il più acuto dei guaiti. Fanno da guardiani al confine, sulla terra da cui il lago ci separa. Una decina tiene d’occhio la sponda a est, venti sono radunati a ovest, due soltanto vegliano sul bosco a nord, mentre un gruppetto di cinque o sei mantiene il controllo della zona sud, dov’era il porto.
Il binocolo usato un tempo per osservare gli uccelli, adesso mi aiuta a vedere loro. È così che li distinguo e li seguo.
Hanno tutti la bava alla bocca e si muovono a scatti, sferzando l’aria con la coda, grattando la terra con zampe robuste, irrequieti quasi bruciassero avvolti da una fiamma invisibile. Anche da fermi i loro corpi sono squarciati da convulsioni improvvise.
Poco fa ne ho visti due sulla sponda est che si assalivano, mentre uno di quelli a nord si avvicinava all’acqua, come se non distinguesse più le onde dai solchi del terreno. Quando se n’è accorto ha fatto un balzo all’indietro.
«Rabbia?»
È stata Luisa a pronunciare per prima quella parola. Io me l’ero rigirata in bocca decine di volte, per poi ingoiarla e trovarmi la gola graffiata dall’orrore.
«Rabbia», ha poi affermato. «Hanno paura dell’acqua».
È questo che, fino ad ora, ci ha salvati. Ma l’acqua si ritira in fretta e loro lo sanno.
23 aprile
Luisa ha aperto l’ultimo barattolo di gelatina di mele preparata l’anno scorso. Ce ne siamo concessi due cucchiai ciascuno su una pagnotta rafferma. Era così dolce da farmi arricciare il naso.
«Non ti piace?»
«È buonissima.»
Non mentivo, e Luisa lo sapeva. Abbiamo sorriso l’uno all’altra, le labbra impiastricciate come se fossimo bambini. Poi io mi sono messo a lavorare alle mie bozze, lei ai suoi disegni.
«Glielo abbiamo promesso», ha continuato a ripetermi. «Non possiamo fermarci.»
Nostra figlia Cecilia aveva sette anni quando siamo venuti in vacanza al lago per la prima volta, dodici quando abbiamo comprato questa casa, e quindici quando Luisa ha iniziato a illustrare libri per bambini.
«Perché non scrivi una storia per la mamma?»
Mi ricordo ancora con che occhi brillanti mi è venuta incontro un mattino, adolescente pallida, le guance gonfie delle canzoni che fischiettava per ore, dopo averle ascoltate alla radio.
«Che tipo di storia?»
«Una che parli di uccelli... gli uccelli del lago.»
«Ne hai uno preferito?»
«La folaga.»
«Un nome?»
«Oscar.»
Ed eccolo, qui accanto a me, Oscar, che zampetta sul bordo della pagina. Luisa si è concentrata su di lui oggi. Gli ha fatto aprire il becco, poi gliel’ha chiuso; ha lavorato sulle sue piume, sulle ombre e le luci che le frastagliano, sull’espressione che fa quando stringe gli occhi e quella a cui accompagna le sue parole.
A Cecilia sarebbero piaciute la sua curiosità e la malinconia, il suo modo di camminare, sempre sbilanciato un po’ in avanti, e l’abitudine di mettere una zampa sull’altra quando avvicina il becco a quello della compagna Aurora.
I suoi amici uccelli si chiamano Corrado (lo svasso) e Libero (il martin pescatore). Col primo nuota fino alle estremità del lago, col secondo saltella sulla sponda e parla di filosofia e religione. Oscar crede nel potere degli spiriti che si staccano dalle fronde dei salici al soffiare del vento, di quelli che aprono gli occhi sui fiori in boccio e che ridono sulla schiuma dell’acqua. Libero, invece, crede nelle divinità nascoste tra le stelle. Gli spiriti dei salici e dei fiori non hanno alcun potere, gli altri, invece, pare ne abbiano di infiniti.
“Rivolgiti a loro”, lo esorta infatti il martin pescatore, perché Oscar ha un desiderio che gli spiriti non hanno ancora esaudito: vuole diventare papà e vuole che la sua Aurora diventi mamma.
Hanno già perso ventisei delle uova deposte. Il delitto lo ha compiuto una volta una banda di ragazzini, un’altra una tempesta, un’altra ancora la cornacchia ferita a cui Oscar aveva prestato soccorso.
«Allora, l’hai scritta la preghiera?» mi ha chiesto Luisa, quando ci siamo messi a tavola.
Il momento in cui Oscar decide di pregare le divinità che abitano tra le stelle è uno dei più importanti del libro.
«Sì, ma non mi piace abbastanza.»
«Vuoi leggermela?»
Cari dei e care dee, io lo so che non vi ho mai pregato, e lo so che vengono prima quelli che invece vi pregano ogni sera, ma voglio chiedervelo lo stesso: potete aiutare me e Aurora a diventare genitori? Abbiamo questo amore dentro che cresce e cresce e ci rende pesanti, ci fa male. Aurora teme di morirne. E io temo di sopravviverle.
Luisa ha annuito. Anziché darmi il suo parere, ha preso il suo ultimo cucchiaio di polenta e lo ha versato nel mio piatto rimasto vuoto.
25 aprile
«Altri cani?»
«Sì», ho risposto a Luisa.
Camminavano verso il porto, macchie oscillanti nel bianco polveroso delle strade.
«Solo cani?»
Alcuni li ho visti strisciare dalle case come spettri.
Per un momento, in quelle ombre, ho creduto di riconoscere i nostri amici. Ne avevamo di cari sulla terraferma: Luigi, l’architetto a cui abbiamo affidato il restauro della casa, don Patrizio, il parroco della chiesa, Felicia, l’infermiera che faceva le iniezioni a Cecilia, abitavano lì, a pochi metri dal porto.
«Solo cani».
29 aprile
Luisa ha avuto la febbre.
Non ho mai stretto la sua mano tanto a lungo, mai contato i battiti del suo cuore con la paura di sentirli interrompersi.
Ho trascorso ogni notte al suo fianco senza dormire, solo contando. I cani abbaiavano e io contavo. Partivo da uno e arrivavo a duemila, a tremila, prima di inciampare nel sonno. Ero terrorizzato al pensiero di chiudere gli occhi, di lasciare solo l’isola e l’acqua, o quel poco che ne resta, a difenderla. Per mantenerla in vita dovevo restare sveglio, l’indice sulla sua vena, la mente concentrata su ogni cifra.
Tre giorni così, forzandola a mangiare e a bere, poi, ieri mattina, Luisa ha riaperto gli occhi.
«Ho fatto un lungo sogno», mi ha detto. «Oscar diventava padre di cinque pulcini».
Ne aveva visto le uova schiudersi davanti a mamma e a papà folaga. Pare che io fossi lontano. Arrivavo appena in tempo per ammirare gli anatroccoli diventati adulti che spiccavano il volo.
1 maggio
Ci sono cose che un prigioniero non dovrebbe mai fare, tra queste discutere di cibo, battere la lingua contro ogni angolo della bocca cercandone il sapore, raccontare, su carta o a voce, la situazione e il momento in cui ne ha goduto. Dettaglio dopo dettaglio, inizierà a sentirne una voglia irrefrenabile, voglia che diventa tormento tanto più ampio è lo spazio che le si concede.
Io l’ho provata ieri, quando Luisa mi ha mostrato i suoi disegni per la scena del banchetto, una delle più tenere e romantiche del libro. È lì, sotto la tavola imbandita dalla vecchia signora Irma, che Oscar e Aurora s’incontrano per la prima volta. Avevo scritto il capitolo sorvolando sul cibo. Luisa, invece, ha fatto proprio l’opposto: Oscar e Aurora sono sullo sfondo e in primo piano spiccano la piramide dei bignè, la cesta colma di frutta, i biscotti alle mele e le focacce alle olive.
L’ho sentita allora, più forte che mai, la fame, la sofferenza. Voglia di budini al cioccolato, di fichi seccati al sole e riempiti di mandorle croccanti, di soufflé da sciogliere in bocca. Voglia di sapori intrappolati nel bambino, nell’uomo e nel padre che ero. Ci sono cose che non mangio da quando Cecilia non può più mangiarle, altre da quando i cani hanno sostituito gli uomini.
«Che cosa ti manca di più?» mi ha chiesto a un tratto Luisa, come se patisse anche lei.
«La frutta», ho risposto.
«Anche a me».
«Ricordi le albicocche comprate in quel mercato in Spagna? Non una punta di acido, solo dolcezza. E le pesche bianche, piccole, del frutteto di tua madre?»
«Mi ci lavavo la faccia da bambina. Ne avrei mangiate a chili».
Ci siamo tormentati così, io e Luisa, per buona parte del giorno. Il gioco del “ti ricordi?” ha reso appetibili, davanti ai nostri occhi allucinati, cibi che non avevo mai saputo mi piacessero e cibi che avevo sempre detestato, come i calamari, le mele verdi, la verdura amara, la liquirizia.
3 maggio
Non è chiaro come sia morto, forse a seguito di una ferita (ho sentito dei cani combattere ieri notte). All’acqua deve essersi avvicinato per disperazione o perché stordito.
È stata Luisa a vederlo per prima.
«Vado io al pozzo, tu resta in casa», le avevo detto, ma lei voleva lasciarmi scrivere.
Abbagliata dal sole, lo aveva creduto una delle tante macchie scure che le pulsavano sulle pupille. Poi la macchia era diventata carcassa.
Ho sentito il secchio nelle mani di Luisa che cadeva a terra, e sono corso fuori, senza sapere che cosa fosse successo.
Tremava, madida di sudore, irrigidita dall’ansia, mentre continuavo a ripeterle: «È morto!»
Ormai lo avevo visto anch’io. Era fermo al centro del lago; non c’era corrente che lo facesse procedere avanti o che lo spingesse indietro. La sua pelliccia, nera e lucida, sembrava mandare scintille a contatto con la luce.
«Rientriamo insieme», ha suggerito Luisa, con il terrore ancora negli occhi.
«Non ci può fare alcun male», ho ribadito con voce calma, tenendole il volto tra le mani.
Una volta a casa, lei ha smesso di guardare verso il lago; io, invece, ho aspettato di vedere muso, zampe e coda affondare insieme alla loro minaccia.
6 maggio
«Sono brutta, eh?»
Cecilia vedeva i nostri volti tesi da una spaventosa verità: che la sua vita si sarebbe spenta prima della nostra. Lei dimagriva, si faceva sempre più pallida, e noi le sorridevamo troppo, con dolcezza eccessiva.
«Non lo sei», le rispondevo. E le accarezzavo le mani.
Il gelso era carico di frutti quel giorno, il sole tiepido e il vento leggero. Cecilia passeggiava lenta sulla sponda, Luisa dormiva sulla sdraio e io tenevo d’occhio entrambe mentre scavavo una buca. Mi ero ripromesso di piantare un albicocco e un mandorlo perché, insieme al gelso, un domani chiudessero la casa dentro una muraglia tutta verde.
Non mi ero accorto che Cecilia aveva in mano uno specchietto, tanto meno che fosse quello d’argento di nonna Franca. Lo aveva aperto piano, spiandone prima l’interno, poi si era inquadrata. Dalla fronte il suo sguardo era sceso sugli occhi arrossati, sulle guance scavate, sul naso, sul neo in cima all’arco di Cupido, e infine sul collo e la sua cicatrice.
«Che cosa c’è?» le ho chiesto avvicinandomi.
Nessuna risposta.
Lo specchietto era caduto in acqua e il volto di Cecilia, quello tremante di paura, la sua e la mia, era affondato.
Lo specchietto è riemerso oggi, sporco, dal nuovo tratto di fondale scoperto. Nel prenderlo, ho deciso di non guardarvi dentro. Luisa l’ha poi ripulito con cura e riposto sul comodino in camera di Cecilia, proprio dove lo teneva lei.
8 maggio
Le uova sono deposte, con la benedizione delle divinità che abitano tra le stelle. Cinque uova bianche punteggiate di nero riposano al centro di un bellissimo nido. Luisa lo ha disegnato rametto per rametto, foglia per foglia, china sotto la luce della lampada. È sulla scrivania che l’ho vista addormentarsi ieri, la mano poggiata sui fogli e la fronte sul braccio.
«Devi aiutarmi», le ho detto svegliandola.
Le sue palpebre gonfie hanno vibrato un po’ prima di aprirsi.
«A fare cosa?»
«A scegliere i nomi per gli anatroccoli».
Dalla scrivania, Luisa si è spostata sulla poltrona accanto al letto.
«Nomi di re?» ha suggerito.
Ci avevo già pensato, ma non ne avevo trovati cinque che mi soddisfacessero.
«Nomi di poeti?»
Messi insieme anche quelli, con poco successo.
«Nomi di artisti? Di piante? Di fiori?»
Ne abbiamo snocciolato alcuni, ma nessuno sembrava funzionare.
«Menecuccio, Tittillo, Renzone, Luccio, Iacovo».
«Mai sentiti».
«I cinque figli, non la conosci?»
Le fiabe raccontate a Cecilia Luisa le ricorda ancora tutte; le cita spesso, ne sfoglia i libri, ne disegna i paesaggi.
«No, di che cosa parla?»
«Di cinque ragazzi, un orco e una principessa».
«Ti ascolto», le ho detto.
Anche se la storia non mi ha convinto, ho detto sì ai nomi.
11 maggio
Gli ultimi uccelli se ne sono andati da giorni, l’acqua si continua a ritirare e i cani – saranno cinquanta, adesso, sessanta? – si avvicinano. Annusano la terra, scavano, litigano per quel che resta di un vecchio remo, per un cerchio di gomma e una lattina.
Poco fa, col binocolo, ne ho visto uno ingoiare qualcosa, poi il suo corpo ha iniziato a contorcersi sotto la violenza degli spasmi.
«Muori!» ho urlato, sperando che la sua disperazione fosse più forte della mia e lo uccidesse.
Un attimo dopo, vedendolo camminare a capo basso e bocca aperta sulla sponda, ho chiesto perdono non so se a lui o a me stesso.
23 maggio
Menecuccio, Tittillo, Renzone, Luccio, Iacovo sono nati.
Nella luce del tramonto che si allunga tra i rami, Oscar vede una piuma che si muove, poi una zampa, un occhio che si apre, un’ala. Vede il futuro che spalanca affamato il becco.
«Grazie», dice alle divinità che abitano tra le stelle, alle stelle stesse, al sole, alla luna, a Corrado e a Libero, ad Aurora, e a quel bambino che guarda dalla riva gli anatroccoli nel nido sorridendo. È un bambino buono, pensa Oscar, che non farebbe alcun male ai suoi figli. Gli si avvicina, infatti, e ringrazia anche a lui. Poi vola via, a pelo d’acqua, in cerca di cibo. È suo il compito di sfamare gli anatroccoli, mentre Aurora li stringe al suo petto caldo.
12 giugno
Sembra che sia sceso Dio in persona a bere dalla conca del lago.
In un solo giorno, l’acqua si è prosciugata del tutto. Il fondale scoperto è una fossa comune per pesci. Come lo specchietto, siamo riusciti a salvare dal fango altre cose di Cecilia: un suo fermaglio per capelli, un suo giocattolo, il gattino di giada comprato insieme alle bancarelle del porto.
Luisa esce. Corre scalza sulle pietre infuocate, sulle zolle taglienti, per andarlo a prendere.
«È intatto», dice, sorpresa come di fronte a un miracolo, e non vede il sangue che sgorga dai suoi piedi.
13 giugno - mattina
Procedono lenti senza abbaiare né guardarsi, quasi inconsapevoli l’uno dell’altro. Forse si chiedono anche loro dove sia finita l’acqua, forse ne sentono ancora l’odore, quest’odore di marcio che stringe l’aria in un pugno, che risale su per le nostre narici da settimane.
«Non hanno la bava alla bocca», mi fa notare Luisa.
Ho già scritto e detto forse decine di volte e ho paura di ripetermi: è un’arma troppo affilata la speranza.
Forse non è rabbia.
Forse non sono gli stessi cani.
Forse neanche ci vedono.
13 giugno - sera
Li ho visti accanirsi sui corpi dei pesci, alcuni ringhiare contro un’ombra, contro il luccichio di una pietra. Quattro si sono fermati, e ce n’è uno che gira su se stesso guaiolando come impazzito. I rimanenti hanno circondato l’isola.
Al nostro passato e al nostro futuro, alla nostra Cecilia e a tutti i bambini che leggeranno questa favola.
Rileggo la dedica del libro scritta giorni fa, poi io e Luisa firmiamo l’ultima pagina.
Se avessi più tempo, la riscriverei. Anzi, riscriverei tutto da principio, favola e vita.
“Va bene così”, sembra dirmi Luisa con gli occhi.
Va bene così per le cose lasciate a metà o mai iniziate, per quelle finite, ma non come volevamo, per gli abbracci mancati, per le telefonate non fatte quando qualcuno avrebbe ancora potuto rispondere, per la gelatina ammuffita prima che vi affondassimo il cucchiaio un’ultima volta.
Ora che mi ha raggiunto alla finestra, Luisa traccia con l’indice il contorno del gelso, per poi ricopiarlo sugli angoli vuoti del giardino, di fianco al capanno degli attrezzi, oltre il pozzo e dietro al gazebo e all’altalena.
«Sarebbe stato bello, così», bisbiglia.
Un’ampia muraglia verde...
La luce che resta del giorno è rannicchiata sopra l’orizzonte. A breve scivolerà dall’altra parte del cielo, quella che non riusciamo a vedere. E noi ce ne andremo con la notte.