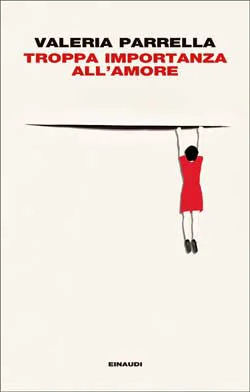di Alessandro Pinci
Paolo Zardi torna in libreria con un nuovo libro di racconti dopo aver pubblicato tre romanzi: “XXI secolo” (finalista Premio Strega 2015) e “La passione secondo Matteo” (2017) con la Neo Edizioni, e “Tutto male finché dura” (2018) con Feltrinelli.
Il nuovo libro si intitola “La gente non esiste”, è pubblicato sempre da Neo Edizioni e raccoglie ventisette racconti: storie che raccontano esseri umani pieni di speranze, paure e desideri circoscritti in un piccolo frammento della loro vita che sta per essere squarciato.
Sono racconti brevi con una sapiente cura nella lingua, efficace nel rendere l’intensità della vita emotiva dei personaggi narrati. Dopo “Antropometria” (2010) e “Il giorno che diventammo umani” (2013) Paolo Zardi si conferma, anche con questo libro, uno dei più talentuosi autori di racconti in Italia.
In occasione di questa uscita gli abbiamo fatto qualche domanda.
In questo nuovo libro, come nelle altre due raccolte, il titolo rimanda a questa tua “ricerca antropologica” sugli esseri umani e sulle loro relazioni, un tema cruciale nelle tue narrazioni. Possiamo dire che è uno degli aspetti più frequenti delle tue storie? Come mai?
Quando ero bambino, a uno dei miei compleanni (credo il nono, facendo due conti), mio padre mi regalò tre libri piuttosto voluminosi: uno parlava di archeologia, uno delle grandi spedizioni. Se, come pare, siamo in gran parte il frutto della nostra formazione, direi che quei tre libri, ciascuno a modo suo, hanno contribuito non solo a creare la mia idea di mondo ma anche a definire alcuni dei campi ai quali posso applicare il mio interesse e la mia passione. Non sono uno psicologo, e conosco poco i meccanismi con i quali si formano identità e gusti; però credo che la mia testa di bambino in rapida crescita sia stata stimolata a porsi domande su certi temi, piuttosto che su altri. Poco tempo fa ho trovato, nella ricca biblioteca di mio padre, un libro storico di Carlo Ginzburg, che fu, tra le altre cose, professore a Stanford; in questo volume di trecento pagine si raccontano le vicissitudini di un fornaio che a un certo punto della sua vita divenne un eretico; scampato alla condanna in un primo processo, finì impiccato al secondo. Vista qui, la sua è una storia folle. Ma in quegli anni – stiamo parlando del Cinquecento in Italia – la definizione di Dio, delle relazioni di parentela con Gesù, la natura dell’anima, e altri temi teologici erano al centro dei pensieri di tutti. Per certi versi, non mi sento molto diverso da quel fanatico: la ricerca antropologica sugli esseri umani e sulle loro relazioni occupa gran parte dei miei pensieri. Non è una scelta: sono io.
Nei tuoi racconti vengono affrontate molte questioni, ma, in generale, possiamo dire che si parla di vita nel suo lato più emozionante, di quegli ambiti emotivi che coinvolgono sia aspetti più virtuosi che negativi, che orientano, di volta in volta, la vita dei tuoi personaggi. Per questo credo che tutti i lettori possano immedesimarsi in ciascun aspetto dei tuoi racconti. Qual è il tuo pensiero sulla questione relazionale in un tempo come questo, caratterizzato dalla solitudine e dalla individualità?
Per mia ignoranza, non so come si vivesse negli altri tempi – leggendo Kafka posso immaginare che nella Praga di un secolo fa ci fosse una solitudine immensa, ma è difficile distinguere il caso personale da quello individuale. Per quanto riguarda gli anni in cui viviamo, sono convinto che non si sia poi così soli; mi pare, piuttosto, che sia cambiata la qualità delle relazioni individuali, con una proliferazione di conoscenze superficiali, spesso veicolate dai social, alle quali si accompagnano amicizie più profonde, come è sempre avvenuto. Il punto è che il vero sconvolgimento nelle relazioni tra le persone è nato dopo la diffusione del televisore in tutte le case, e cioè a una sessantina di anni fa. Paradossalmente, Facebook e Twitter hanno rimediato, almeno in parte, a quel tipo di solitudine; i legami che si creano sui social si basano su affinità abbastanza profonde, e non sulla semplice prossimità geografica. Di contro, i social hanno introdotto una serie interminabile di nuovi problemi, come il degrado della politica, che, potendo misurare il consenso di ogni singolo atto, ha rinunciato alla strategia di lungo respiro per concentrarsi sulla massimizzazione dei like quotidiani, o il potere, ancora incontrollabile, della propaganda basata sull’acquisizione di informazioni personali, o ancora le filter bubble, le bolle virtuali nelle quali siamo immersi, e che ci convincono che il mondo assomigli a noi: in questo senso, allora, l’individualità di ciascuno viene esasperata, a scapito di una visione globale e articolata del mondo.
I racconti che ho amato di più sono “Botole” e “Urano” nei quali l’intensità nella narrazione è, secondo me, più viva e pulsante. In entrambi si parla del tempo, uno dei nemici peggiori che possiamo avere. Nel primo i ricordi di un passato ormai lontano scompaiono, mentre nel secondo i personaggi cercano di aggrapparsi con l’amore a un futuro incerto e pieno di ombre. Ci puoi svelare in che modo raggiungi questa intensità, raccontandoci come sono nati questi due racconti? E poi qual è il tuo rapporto con il tempo?
“Botole” nasce sotto l’impulso di una casa editrice, Zona 42, che, attraverso Alessandro Vietti (un autore tra i più bravi in Italia), mi ha chiesto un racconto per una raccolta. Zona 42 è nata da pochi anni con un’idea chiara in mente: proporre una fantascienza “contaminata”, priva del timore di uscire dal canone. Il punto di partenza di questo racconto è, come spesso accade, un fatto reale: avevo un’amica che abitava in un piccolo paesino sopra Trento, in una casetta vicino alla chiesa, con una madre piuttosto anziana. Un giorno si sono presentati i Carabinieri a casa sua, l’hanno presa da parte e le hanno detto più o meno così: “Sappiamo che sua madre è una persona onesta, ma ci è veramente impossibile accettare che nel suo orto crescano piante di marijuana”. L’ipotesi più probabile è che il vento avesse portato là i semini di qualche coltivazione abusiva non distante da là. La mamma della mia amica non aveva la minima idea di quale fosse la natura di quelle piante; però ne faceva buon uso, mettendo le sue foglioline nell’insalata o preparando delle ottime frittate. I viaggi, dunque, possono essere reali, oppure interiori, e, come insegnava Godel, e come si può intuire in Matrix, il più riuscito mix di intrattenimento e scienze cognitive, un sistema non ha i mezzi per confermare la propria verità: in altre parole, l’atto di vivere dentro un sogno è indistinguibile dall’atto di vivere nella realtà, ammesso che questa parola abbia un qualche significato.
Anche “Urano” nasce da una raccolta di racconti, questa volta messa in piedi da Mauro Maraschi e Rossano Astremo per Hacca. Il tema era la fine del mondo, quella prevista per dicembre del 2012 (ricordo la presentazione del libro fatta giusto qualche giorno prima a Roma, in un’atmosfera particolarmente apotropaica). Per la realizzazione di questo racconto c’è stato un bel confronto con Mauro Maraschi, che allora non conoscevo ma che, proprio grazie a questo incontro, è diventato una delle persone che contano nella mia vita di autore. La mia idea iniziale era quella di una madre sul punto di partorire proprio nei momenti concitati della fine del mondo, combattuta tra il desiderio di vedere il volto di suo figlio, e poi vederlo morire davanti ai suoi occhi, o di proteggerlo fino alla fine, nello scrigno sicuro del suo grembo. Il problema, molto pratico, è nato quando ho saputo che un altro degli autori della raccolta, che poi avrebbe preso il nome di “ESC – quando tutto finisce”, aveva scelto il tema della gravidanza: in accordo con Maraschi, ho deciso di rinunciare a questa idea e di passare al piano B, che allora poteva essere riassunto come un vago desiderio di raccontare un evento terrificante e struggente allo stesso tempo. Scrivere questo particolare racconto è stato importante, per me, perché mi ha consentito di esplorare un mondo, quello distopico, che fino a quel momento non avevo mai preso in considerazione: il romanzo “XXI Secolo” e quello in uscita per Chiarelettere, “L’invenzione degli animali”, non sarebbero mai esistiti se non avessi scritto “Urano”.
Venendo alla seconda domanda, sono sempre più convinto che i racconti (e i romanzi, le sinfonie, i balletti, le gare di atletica) non sono altro che “tempo allo stato solido”. La trama, i personaggi, le descrizioni, i paesaggi, il ritmo del tamburo, le coreografie, la corsa sfrenata formano lo schermo necessario per poter osservare l’ombra del tempo che scorre, che è l’unico ingrediente imprescindibile di qualsiasi narrazione. Ci si domanda, già dai tempi di Sant’Agostino, cosa sia, in concreto, il tempo: una dimensione? Un’illusione del nostro cervello? Una forza fisica? E se esiste come esistono i colori, gli odori, la consistenza dei corpi, con quale senso riusciamo a percepirlo? Poiché la scienza non è ancora riuscita a fornire una risposta univoca (è ancora in corso il dibattito tra gli eternalisti e i presentisti), la letteratura (e la musica, la danza, le gare) provano a seguire, con una matita, il profilo incerto che il tempo proietta su di noi.
La differenza più grande che noto con i racconti delle altre raccolte, è che negli ultimi i toni utilizzati per le tematiche narrate sono molto meno duri e cupi rispetto al passato; noto anche alcune immersioni nel grottesco, nonostante (o, a maggior ragione!) si parli di tradimenti, malattia e morte; e, poi, per la prima volta, a differenza del passato, nomini i tuoi personaggi. Sei d’accordo con questa analisi? E come mai questa scelta?
La sorgente di tutti i racconti è il corpo di un essere umano che vive in questo mondo; una persona – io –che cresce, invecchia, che viene sottoposto, suo malgrado, a esperienze talvolta terribili, che evolve o involve: che cambia. Ho iniziato a scrivere racconti nel 2007. Sono passati dodici anni, da allora, e credo che le cellule del mio corpo siano state tutte sostituite dalle figlie delle loro figlie, copie un po’ sbiadite delle originali. Ora, a un passo dai cinquant’anni, so di aver superato già da un pezzo la prima metà della mia vita; la morte, che per tanto tempo è stata uno stimolante argomento di conversazione, è diventata una presenza più prossima: non incombente, ma comunque tangibile. In “Cuore di tenebra”, Marlowe, alter ego di Conrad, racconta che da bambino, osservando le carte geografiche dell’Africa, subiva il fascino irresistibile del suo nucleo inesplorato: di quel mistero oscuro. Con gli anni, però, gli esploratori hanno tracciato, su quelle mappe, fiumi, catene montuose, strade, città: ma, come aveva capito Leopardi, la base della poesia, e in senso più generale della scrittura, è la vaghezza. Si scrive di ciò che non è ancora noto, chiaramente definito (sempre Leopardi diceva che la precisione del francese aveva ucciso qualsiasi possibilità di creare poesia in quella lingua).
Per quanto mi riguarda, il tempo ha contribuito a delineare meglio il profilo della morte. Quel mistero così esotico è diventato un oggetto quasi quotidiano. In The pornography of death, Geoffrey Goer spiega (siamo nel 1955) come la morte sia diventata il tabù del XX secolo, sostituendo quello del sesso: un tempo ai bambini si diceva che erano nati sotto un cavolo, ma li si lasciava assistere alla morte dei parenti nella loro camera da letto, che se ne andavano attorniati da parenti, vicini e semplici curiosi. Ora, quando un nonno sparisce nel silenzio più assoluto, si dice che è volato in cielo; e si continua a pensarlo, più o meno inconsciamente, fino a quando non senti che la morte è qualcosa che ti riguarda da vicino; allora si alza il velo, e la vaghezza finisce. È più o meno questo il motivo per cui i miei toni sono diventati meno cupi: poiché la morte ha perso parte del suo mistero, forse mi interessa un po’ meno parlarne.
E poi ci sono stati altri cambiamenti, dettati dalla semplice voglia di esplorare. Le storie, ora, hanno spesso più personaggi, e per distinguerli tra loro diventa necessario usare i nomi propri. Sto provando a usare la prima persona, che consente di ottenere risultati completamente diversi. C’è della fantascienza; e il grottesco, che è l’elemento centrale del mio romanzo “Tutto male finché dura”, trova spazio in diversi racconti. L’aspetto bello di scrivere racconti sta soprattutto nella possibilità di sperimentare, di provare nuove strade.
Viri con molta naturalezza e maestria dai racconti ai romanzi e viceversa. Ci puoi spiegare quali differenze ci sono per te tra queste due forme di narrazione e quale preferisci?
Mi piace scrivere, e questo è il punto di partenza. La lunghezza di una storia dipende dalle sue caratteristiche intrinseche, e non da una scelta personale: ci sono eventi che vanno risolti in poche pagine e altri che invece si espandono, che richiedono la costruzione di antefatti, di piccoli mondi inventati. Il racconto dà una soddisfazione più immediata: anche se la fase del concepimento può durare anni, la realizzazione non richiede quasi mai più di due o tre giorni; lo sforzo viene ripagato subito. Il racconto ha meno vincoli sentimentali: vivi con lui per poco tempo e poi lo abbandoni presto al suo destino. In un racconto è più semplice usare una voce scomoda, eccessiva, sopra le righe, perché il tempo per il quale deve essere sostenuta è breve. Il romanzo, invece, è una casa che devi costruire a mano: per mesi, vedi solo lo squallore delle sue fondamenta, mentre tutto il resto è solo nella tua testa. Il romanzo richiede perseveranza, lucidità, abnegazione, presunzione, forza di volontà. Assomiglia a una partita a scacchi: le prime mosse sono semplici, ma poi iniziano le coercizioni – la lingua adottata, i passaggi obbligati, le caratteristiche dei personaggi, i raccordi tra i nuclei narrativi: da un certo momento in poi, ogni mossa è vincolata allo stato in cui si trova la scacchiera. Il romanzo è un’avventura profonda, una sfida continua; richiede progettualità, organizzazione, un piano ben congegnato capace di prevedere in anticipo l’inevitabile scoramento che ti assale quando si incontra una secca, e la disperazione di non riuscire più a trovare la soluzione giusta per il problema che noi stessi ci siamo posti.
Ma la sostanza è la stessa. Si scrive una parola dopo l’altra, fino a che si arriva alla fine. Non c’è niente di più di questo.
Sei considerato da molti come uno dei più bravi scrittori di racconti in Italia. Da profondo conoscitore della narrativa breve, secondo te, come se la passa oggi il racconto in Italia?
Il racconto, anche in Italia, ha una lunga tradizione, che a mio parere non si è fermata. Il web è pieno di riviste on line che pubblicano racconti, spesso molto buoni. Le case editrici tendono a essere prudenti, per considerazioni forse non troppo irrealistiche: è più semplice vendere romanzi che raccolte di racconti. Facendo un passo indietro, però, credo che sia più semplice valutare un romanzo che una raccolta di racconti; che sia più semplice da editare, da sistemare, e poi da raccontare ai librai, quando gli agenti propongono le nuove uscite, e ai lettori che entrano in libreria per comprare qualcosa, o cercano su Amazon un libro da portarsi in vacanza; più facile da recensire, da riassumere in una fascetta, in un titolo di giornale, in un suggerimento a un amico. Non c’è un complotto nazionale contro il racconto: è semplicemente più difficile “veicolare questo prodotto”, come direbbe un rappresentante di colle epossidiche. Lo vedo nelle presentazioni: in un romanzo ci sono personaggi, una trama che si può accennare, facendo sempre la doverosa premessa che non si intende spoilerare il finale (facendo intendere che lascerà di stucco il lettore) e c’è quasi sempre un tema centrale, portante di cui si può discutere per una buona mezz’ora; ma quando qualcuno si trova a moderare la presentazione di una raccolta di racconti, be’, dovrà parlare di cose impalpabili come lo sguardo dello scrittore o la distanza, di scelte stilistiche, e anche dello stato del racconto in Italia e della differenza tra il racconto e il romanzo. 😊
Ma il racconto esiste, è forte e ha un seguito importante; è una forma imprescindibile di letteratura.
Puoi consigliare ai nostri lettori i tre libri di racconti che secondo te tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita?
Opzione tradizionalista: tutti i racconti di Čechov, tutti i racconti di Flannery O’Connor, e una robusta antologia di racconti di fantascienza.
Opzione alternativa: i 49 racconti di Hemingway (anche solo per imparare come non conviene scrivere), una raccolta a caso di Carver (tenendo sempre in mente che il suo minimalismo nasce per sottrazione, e non per stitichezza), e un’antologia di racconti di Buzzati.
Oppure, ancora: la raccolta di tutti i racconti della Berlin (con spirito critico: dentro ci sono anche cose di scarso valore), tutti i racconti di Kafka (respingendo con forza la voglia di imitare il suo genio inarrivabile) e l’introvabile “Fiale” di Elena Rui, autrice italofrancese di indubbio talento.
Scegliendo tra gli autori non ancora pubblicati: la raccolta in lavorazione di Rina Camporese, quella già completa di Sara Gambolati, quella che prima o poi vedrà la luce di Carmelo Vetrano.
O infine, per andare sul sicuro: tre libri a caso pubblicati dall’ottima Racconti Edizioni.