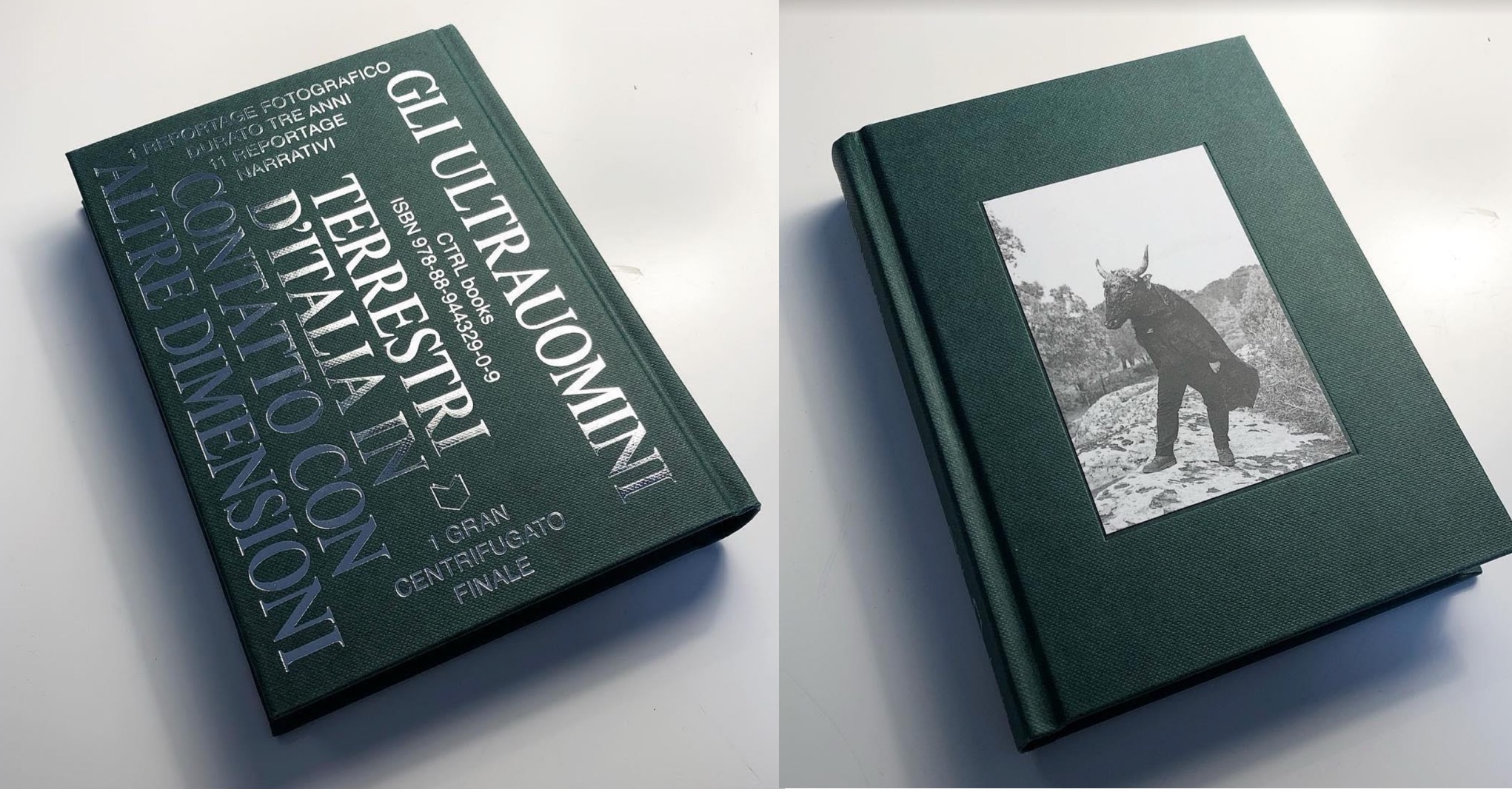di Giordana Restifo
Ogni volta che leggo un libro di cui poi scriverò, è come se ciò che ho intorno mi parlasse, attraverso sfaccettature multiformi, dei temi o delle ramificazioni che pervadono quella determinata opera. I miei amici la definiscono sincronia, altri coincidenza; qualunque sia il termine più adatto, credo sia fondamentale saper ascoltare, captare e fare propri gli stimoli esterni. Per dirla con un verbo: immedesimarsi.
Così è successo anche con Panorama. Narrazione sullo svolgersi degli eventi di Dušan Šarotar, pubblicato in Italia nel marzo 2021 da Keller Editore, tradotto dallo sloveno all’italiano da Patrizia Raveggi. In questo caso, però, ho dovuto prestare molta attenzione, intesa nel suo significato etimologico di “rivolgere l’animo” (dal lat. attentio -onis, der. di attendĕre – vocabolario Treccani) e, quindi, tutti i sensi, per percepire i pungoli circostanti. Il primo approccio con l’opera, infatti, non è stato sereno.
Anzitutto, come ci dice Raveggi, che ha curato anche la postfazione di Panorama, «tempi ed epoche diversi, luoghi e avvenimenti confluiscono in un torrente che trasporta chi legge con la musicalità di un ininterrotto e labirintico scorrere, e offusca le tracce di trama cui il lettore cerca di appigliarsi, come di proposito sviandolo». Già dalle prime pagine è chiaro che tra le mani non si ha un romanzo e che, anzi, la tecnica narrativa scelta dall’autore, originario di Murska Sobota, è quella del flusso di coscienza; si decide di farsi trasportare attraverso ricordi, dialoghi senza alcuna punteggiatura, sogni lucidi.
Sin da subito si viene scaraventati in un’atmosfera nebbiosa, carica di una tristezza lontana, luoghi e personaggi esalano struggimento, tutto sembra avvolto in una grande nuvola di fumo che non si dissolve. Proprio mentre il lettore prova a districarsi o a cambiare atteggiamento per muoversi in questo spazio estraneo, ecco che le interferenze con la realtà sovvertono nuovamente la comprensione. Šarotar ci riporta alla tangibilità disseminando per tutta l’opera degli scatti fotografici in bianco e nero, più o meno sfocati – effetto voluto, come riferisce anche la traduttrice. Voglio immaginare che questo sia un ammonimento dell’autore per dirci: “Risvegliati, questi luoghi e queste persone esistono davvero, hanno patito tutta la tragicità che emanano, e anche più”.
Ritrovarsi con Google Maps?
Ciò che tormenta il narratore, verosimilmente Šarotar, e la gente che incontra durante il suo peregrinare attraverso la selvaggia regione del Connemara o la domata capitale del Belgio, è l’identificazione. Se da molto tempo ho lasciato la terra dove sono nato, se non parlo più la lingua con la quale sono cresciuto, se torno nella mia città e non la riconosco più, chi sono? La mia casa dov’è?
Insieme al narratore/viaggiatore si muove Gjini, autista e saggio albanese emigrato in Irlanda da tanti anni, che non perde occasione per aumentare il senso di inquietudine:
“quando sei lontano dalla lingua, sei anche lontano da casa, ogni giorno di più, a ogni nuova parola la distanza si fa più grande e profonda, la parola perduta viene rimpiazzata o apparentemente sostituita da un’altra, più convincente, migliore, comprensibile a tutti, ma straniera; l’emigrante, questo eterno custode della propria lingua e allo stesso tempo colui che la nega, sa che la perdita è un vuoto, avvolto nel disciolto malto dell’oblio, un vuoto che lui colma con un apprendimento costante, unico vaccino contro la solitudine, la disperazione e la follia, ma è una perdita comunque insostituibile, dolente e incurabile come l’amore”.
Persino Martin il cameriere, personaggio apparentemente marginale, è intriso di mestizia, si incanta fissando fuori dalla finestra, vaga lontano con lo sguardo e con la mente finché non si tranquillizza vedendo le case lungo la baia illuminate dagli ultimi raggi di sole e, come se dovesse convincere se stesso, dice agli avventori del pub: “è casa mia, là, c’è la mia casa, vicino alla chiesa, subito dietro il muro del cimitero …”.
Dunque, bastano dei punti di riferimento fisici per confermare dov’è la nostra casa?
E se questi punti fermi non esistono più, andati, cancellati, sbiaditi?
La malinconica Caroline prova a fornirci una risposta dal suo punto di vista, raccontando al viandante la sua (incredibile) vita da girovaga: “Non ho un paesaggio mio proprio, cerco e invento gli spazi della mia lingua”. E di nuovo Gjini sovverte tutto: “non possiamo nascondere o negare la nostra origine, da qualsiasi posto veniamo o dovunque siamo nati, cioè, siamo fatti di una sostanza, come terra o isola, e soprattutto nostalgia”. Una particolare, soggettiva, nostalgia che, in alcune situazioni, può essere condivisa anche se la memoria storica, all’apparenza, sembra differente.
Riflessioni, interrogativi che ci colpiscono nel profondo, finché il narratore non ci spiazza ancora una volta e, con un brusco risveglio, ci induce a credere che potremmo ritrovarci con Google Maps:
“con il tablet sulle ginocchia ho aspettato che i satelliti mi trovassero, perché solo così tornerò all’esistenza, il mio paesaggio interiore mi sarà restituito, sarò di nuovo iscritto in una rinnovata mappa dei nomi, anche se invisibile, unicamente virtuale, come un ricordo, dal quale il futuro testo comincia appena a prendere forma, con il rilievo e l’atmosfera di ciò che è passato, ma mai perso, come circonfuso da fasci di raggi in mezzo a nuvole fluttuanti, quindi ho soppesato e riflettuto, sebbene tutto fosse stato deciso molto prima, anche prima del mio arrivo, forse anche prima che io nascessi”.
Dopo aver letto queste parole, ho deciso di approfondire questo viaggio attraverso i territori, sono entrata su Google Maps e ho “camminato” per Galway, Clifden, insieme alla signora badessa Maura Ostyn attorno all’Abbazia di Kylemore, ho “percorso” piccoli tratti delle isole Aran; ho seguito il flusso fino in Belgio, scoprendo Gent, Mechelen, perdendomi nelle architetture della stazione di Anversa, sono giunta in Slovenia a Lubiana e a Maribor (allungando di poco il mio percorso per arrivare a Murska Sobota), sono passata da Travnik e, aspettando Šarotar che finisse di visitare la casa natale di Ivo Andrić, ho pensato che, a dire il vero, questi luoghi non erano così struggenti, anzi, alcuni infondevano addirittura serenità con le loro piccole case colorate sulle rive dei fiumi. Quando il viaggio è ripreso verso Mostar e Sarajevo, ho spento Google Maps e ho iniziato a ricordare.
Spomenka, la professoressa originaria della capitale della Bosnia-Erzegovina emigrata in Belgio, insegna ai suoi studenti che “la letteratura non è una medicina per la nostalgia”. Sicuramente, però, è un buon palliativo, aggiungerei io. La vicenda personale della professoressa e della figlia Zora, mi ha suggerito che non erano i paesi a suscitarmi quella angoscia provata sin dalla prima pagina, ma la storia legata ad essi.
Una storia collettiva
Come fa notare Patrizia Raveggi nella postfazione, il mezzo narrativo del flusso di coscienza è un omaggio a James Joyce nella sua terra d’origine. Potrebbe esserci anche una connessione tra i due scrittori rispetto ai cambiamenti che hanno scosso la storia politica e sociale tanto dell’Irlanda quanto della Slovenia. I due paesi hanno affrontato sconvolgimenti differenti e l’epoca in cui ha vissuto Joyce non è la stessa di quella di Šarotar, però entrambi sono rimasti profondamenti turbati da ciò che hanno visto e subito. Gli anni di formazione di Joyce coincidono con un periodo estremamente travagliato per l’Irlanda. Infatti, alla fine dell’800, il paese, stremato da anni di carestia e miseria, si è ritrovato diviso: “chi è rimasto, o accetta di conformarsi al regime politico esistente inserendosi integralmente nell’ambito della cultura inglese, oppure si propone una lotta disperata per sottrarsi al giogo dell’Inghilterra promuovendo in primo luogo un nazionalismo culturale che recuperi i valori di una tradizione ignorata e soppressa” (Giorgio Melchiori nell’introduzione dell’Ulisse, James Joyce, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1973). Tali fazioni ricordano ciò che è accaduto in Slovenia, in Croazia e, successivamente, in Bosnia-Erzegovina durante gli anni ‘90. Andando a rileggere la storia di come si dissolse il sogno del Maresciallo Josip Broz Tito di una grande Jugoslavia unita, è sopraggiunta la prima di quelle sincronie di cui si parlava all’inizio. Proprio nei giorni in cui sto scrivendo di Panorama, trent’anni fa la Slovenia, il primo paese di quell’area chiamata oggi ex Jugoslavia, si distaccava dal potere accentratore di Belgrado dichiarando la propria indipendenza. Il 25 giugno 1991 il parlamento sloveno proclamava la sovranità della Repubblica e, la sera dopo, il 26 giugno, nella piazza principale di Lubiana, si svolgeva una solenne cerimonia nel corso della quale veniva dichiarata l’indipendenza del paese, funesto preludio a giorni di scontri con l’Armata popolare jugoslava. La maggior parte degli sloveni voleva preservare le proprie tradizioni, la propria lingua, la propria storia, e non uniformarsi all’ideologia ufficiale della causa jugoslava, per tale ragione chi ha combattuto per l’indipendenza della Slovenia è stato considerato dalla Serbia un traditore. È una storia lunga, piena di lotte e spargimenti di sangue, quella del popolo sloveno: le rivolte contadine per la terra, contro gli invasori o per la preservazione della propria identità, iniziate nel 1469; le sommosse scoppiate tra i militari sloveni durante la prima guerra mondiale, dalle quali nacquero bande di disertori (i cosiddetti “gruppi verdi”); la resistenza slovena che guidò la lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale; questi sono solo alcuni degli episodi che hanno caratterizzato la storia di questa nazione.
Proprio in quegli anni tragici in cui il mondo veniva sconvolto dal nazi-fascismo anche la vita di Šarotar (non ancora nato), in qualche modo, dev’essere stata segnata inesorabilmente. Non è un caso se in molti dei suoi libri ci sono riferimenti al popolo ebraico. Un tempo, a Murska Sobota, la sua città natale, viveva una vasta comunità di ebrei, sterminata o deportata nei campi di concentramento durante il secondo conflitto mondiale.
Di monaci e fate
L’opera dello scrittore sloveno è intrisa di omaggi alle arti. Oltre alla fotografia e alla letteratura, l’autore si ispira alla pittura. Ci sono, infatti, cenni a Jack B. Yeats e ai fratelli Van Eyck, ma non solo. Una retrospettiva del pittore tedesco Richter a Londra gli ha, probabilmente, suggerito il titolo Panorama. Così, per puro caso, si è palesata la seconda connessione che mi ha fatto pensare al libro. Nei giorni scorsi in un programma in tv si parlava di un quadro che mi ha colpita per la sua potenza, tanto a livello cromatico quanto per il significato introspettivo. Il Monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich, infatti, mi ha subito portato alla mente l’immagine di angoscia e smarrimento di Dušan Šarotar che, scrutando il mare scuro dell’Irlanda, si chiede, per tutti noi, qual è la nostra casa.
Infine, una folgorazione, arrivata quasi sul finale, le “colline dolci e sassose” alle spalle, davanti agli occhi si apre la valle che precede Mostar, la strada scompare nel mare con l’aria tremolante per la calura estiva: “una fatamorgana”. La fata che per tutto il viaggio ha guidato il narratore è Jane. Di lei si sa ciò che deve bastare al lettore. Come tutti, era alla ricerca delle sue origini, che ricercava anche nelle annotazioni sui suoi taccuini. Figura eterea, impalpabile, è la Morgana che prende i personaggi per mano, li sospinge, li conduce e poi li inganna. La si vede in giorni, come si dice nella mia città, di calmarìa, quando cioè il mare sembra immobile. Le correnti d’aria si incontrano a temperature diverse e ti sembra di poter attraversare lo Stretto di Messina a piedi. Anche in Irlanda accade di incontrarla, così Gjini e il narratore si lasciano trasportare su un aliscafo, ma Morgana li tradisce: il mare si trasforma, montano le onde e il segnale non prende più, non ci si riesce a connettere per mandare l’ultimo messaggio, l’ultima email, o per aprire Google Maps e segnalare la posizione dell’imminente naufragio.
Non può finire così. E così non finisce perché, nonostante le parole dello scrittore in un’intervista del 2020, di cui ci informa Patrizia Raveggi, “la storia cambia, viene revisionata e cancellata e spesso scorrettamente manipolata. La poesia no, resta la stessa. In essa l’autore si riconosce, senza differenza tra la vecchia e la nuova”, la storia è quella che viene tramandata con spirito critico. È grazie alla storia studiata, capita, analizzata, discussa, che siamo qui oggi a parlare di ciò che è accaduto e che accade nel nostro mondo ricolmo di odio. E finché ci saremo non dovremo mai sottovalutare questa parola, come suggerisce a Ivo Andrić l’amico Max Levenfeld in Una lettera del 1920 (Romanzi e racconti, I Meridiani Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2001): “Sì, sull’odio. Anche tu reagisci istintivamente ribellandoti quando senti questa parola (l’ho visto bene l’altra notte alla stazione), come ognuno di voi si ribella a sentirla, capirla, accettarla. E invece si tratta proprio di capirla, rendersene conto, acquisirne consapevolezza, analizzarla. Il dramma è che nessuno vuole o può farlo”.