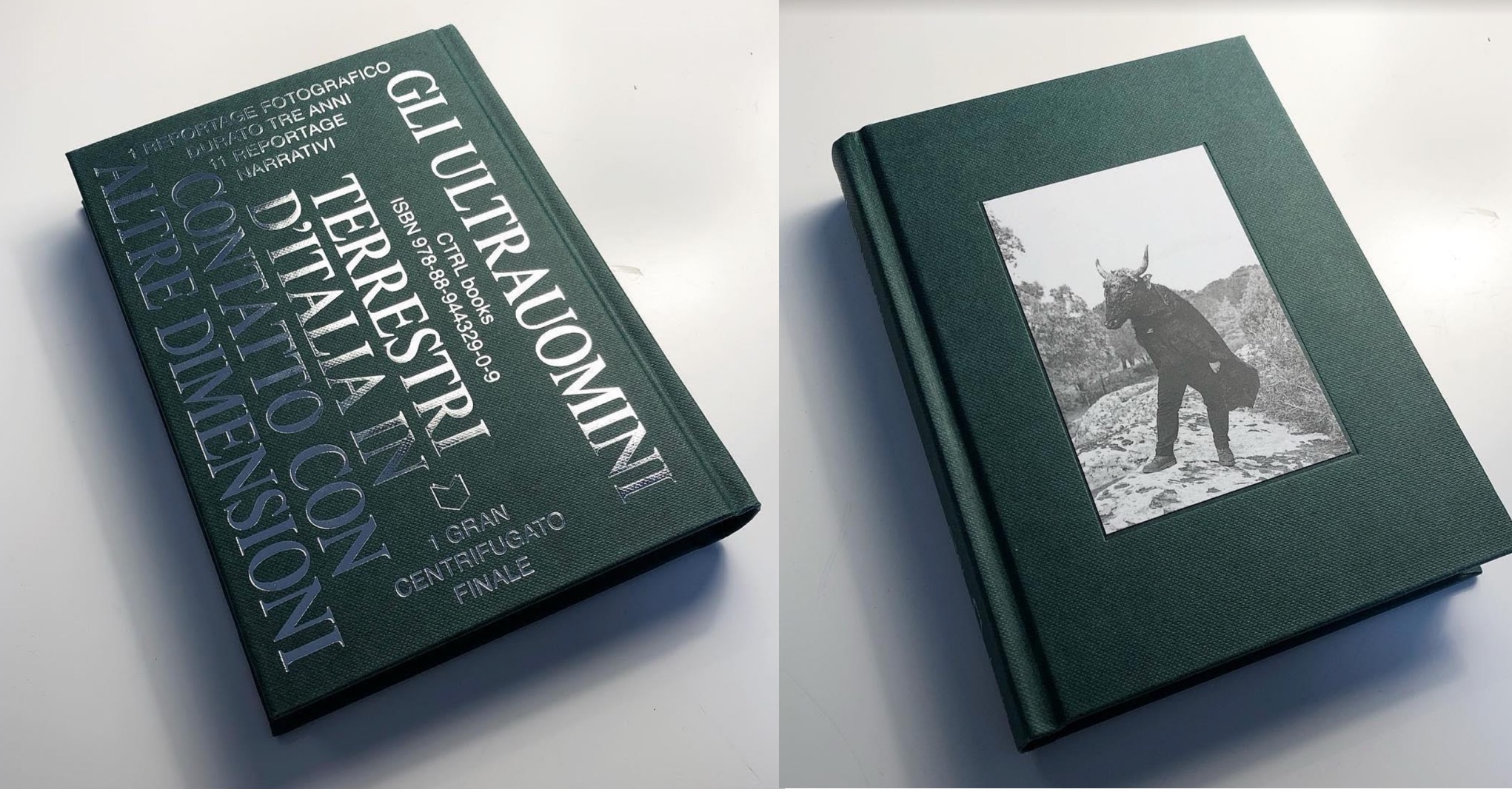Un libro-reportage di incontri ravvicinati con terrestri d’Italia che vanno ultra: a partire dal gestore di un’agenzia di pompe funebri di Mirandola, in provincia di Modena, che fornisce servizi di ibernazione. Tradotto: congela i cadaveri dei richiedenti e li spedisce in Russia in un centro specializzato di criogenesi (pratica legalizzata in quel paese), dove i corpi riposeranno in silos, a meno 196 gradi, in attesa di una “resurrezione” per intercessione della tecnologia.
E poi reportage da un convento di suore di clausura, dalle viscere della terra, da una sala operatoria, dalla casa di un “alieno di paese”, da una panchina su cui siede un cyborg ventiduenne, da un salottino in cui un maestro della Quarta Via beve il caffè, da un ufficio comunale in cui lavora una donna wrestler, da una conferenza di Persone Altamente Sensibili, dalla cameretta di una tanatoesteta, dalle spiagge dove un pensionato va a caccia di messaggi in bottiglia.
Cattedrale vi propone il testo di Donato Novellini
*
L’alieno della porta accanto
di Donato Novellini
Quell’uomo stralunato, trasandato e palesemente inattuale, ricorda un po’ Louis-Ferdinand Céline, periodo fuggiasco in esilio danese; imbottito a strati di giacconi e maglioni d’orso usurati, con un gatto raggomitolato sulle spalle, sta fermo dinnanzi alla porta verde scrostata di casa guardando distrattamente i rari passanti. Vecchie ricurve coperte di scialli e becchini del giorno, del sole velato costretto in fretta al crepuscolo; tutti spettri infagottati dal passo lesto diretti al calduccio. D’inverno marciapiedi dissestati, squarci di pozzanghere ghiacce, luci sterili in vasi da notte capovolti dall’alto, collezione privata ENEL. Saluti appena accennati, la mano intirizzita che frettolosamente esce dalla tasca per un gesto che assomiglia a una benedizione reciproca tra conoscenti, ovvero tra abituali estranei; poi il traffico biancastro dei furgoncini degli artigiani, nervoso scemare oltre la visuale di catrame sbriciolato tra due filari di portici, deserte strisce pedonali, direzione aperitivo delle 19.00. Solito viavai serale, diverso lo sguardo – del solitario senza telefono e televisore in casa – che osserva con disincanto dal civico 71 il meccanico deambulare di provincia: in alto comignoli fumanti, gelo e foschia, è da poco passato Natale e l’obsolescenza maldestra delle luminarie conferisce alla strada quel nonsoché di sordido. Decadenza padana, come quando la neve muta in pioggia imbrattando di fanghiglia i bei portoncini blindati delle dimore con balcone. Come quando le stelle filanti di carnevale affogano nella guazza, dimenticate dalla festa. Quella catapecchia con le tapparelle sempre serrate in obliquo guasto, buttata lì su una curva a gomito della via principale di un piccolo paese in riva all’Oglio, tra Mantova e Cremona, è tutto ciò che possiede, ultimo baluardo dell’eredità (sperperata) ricevuta dai genitori: suo padre, bell'uomo intraprendente, era un rivenditore di dolciumi, per l'esattezza Ingrosso Coloniali. Appassionato d'auto veloci, morì ancora giovane schiantandosi con l’Alfa Giulia contro un paracarro. Robe da film. La madre invece, casalinga protettiva d'aspetto gitano, usava pettinarlo come una signorina, cercando di dare una forma di banana a quei boccoli ribelli da putto barocco. Ella desiderava somigliasse ad una bambola, oppure a quei marinaretti d'inizio ’900, statuine di porcellana che custodiva gelosamente nella vetrinetta in salotto. Ma lui era maschio, figlio unico precocemente aduso a incipriarsi il volto, in qualche modo predestinato all’omosessualità. Ma poi chissà. Da sempre vive solitario in quel presidio d’alterità sovraccarico di memoria minuta, come in un presepe pagano tra animali vivi e altri immaginari, ovvero gli spiriti di piccole bestiole domestiche ormai morte; come in un’enclave di bizzarrie, tra vetusto mobilio per quotidiano horror vacui, le gerarchie risultano invertite: «I gatti sono i veri proprietari, io solo un ospite», suole dire al casuale visitatore schermendosi. Roberto, per tutti Bert, è un uomo senza età, pelle rettile – di primo acchito vecchio cogli occhi capaci di imprevedibili guizzi di vivacità – ma sulla cui figura allampanata pesano trascuratezze boeme, fardelli di vite precedenti, tutti i dazi doganali della libertà praticata senza compromessi. Se ne sta lì appollaiato davanti all’uscio per ore, come un bonzo, reduce orientale, come la piumata ancella di Minerva; testa sotto cuffia di lana a rombi e borse di plastica della Coop piene di chissà cosa, all’erta per motivi genericamente contemplativi o, più prosaicamente, per scroccare una sigaretta, 2 euro per la prioritaria pappa dei gatti, l’ultimo pettegolezzo carpito dalle badanti estoni in libera uscita, un ciocco di legno in extremis per rientrare. Finissima questuanza frammista a incancrenita pigrizia. Dentro casa fa più freddo di fuori.
In paese si dice che Il Bert non abbia mai lavorato in vita sua. Ultimamente, addirittura, si sostiene che sia un inetto approfittatore, un parassita della comunità, il satrapo direttore di misteriosi traffici illeciti: “Gatti e indiani”, borbotta la gente scuotendo il capo. Dalla prolungata inoperosità l’inevitabile taglio dell’utenza gas, massima onta per i perbenisti della domenica. Per acqua ed energia elettrica invece si fa bastare un piccolo sussidio, messo insieme da amministrazione comunale, parrocchia e lontani parenti pietosamente benefattori. Talvolta viene convocato nell’ufficio del sindaco, il quale dapprima lo rampogna riguardo alla cronica condotta improduttiva, per poi proporgli “lavori socialmente utili” e altre forme di reinserimento nella vita della comunità locale. Profferte che puntualmente cadono nel vuoto. Carta d’identità scaduta, saranno 10 anni come minimo che non va a votare. Come tutte le affermazioni categoriche pure quella dell’allergia al lavoro tende all’iperbole macchiettistica. Un mese da operaio presso l’officina, manutenzioni di vagoni treno in deposito, se lo fece eccome il Bert. Fu una delle sofferenze più grandi della sua vita. Erano i primi anni ’70, le baffute tute blu – con le loro rivendicazioni sindacali, picchetti, striscioni rossi e poster di donne nude negli armadietti, con quel piglio rude e in fondo cameratesco – tolleravano a malapena le stravaganze di quell’invertito pacifista devoto a Krishnamurti, le finezze metafisiche di uno in procinto di farsi “arancione” Hare Krishna, di un vegetariano senza patente ma soprattutto anticomunista. Difatti fu un capriccio camuffato da obbligo, tanto per poter consegnare agli annali locali l’ovvia sentenza: “Ci ho provato, ma davvero non faceva per me durar fatica”. Per un lungo periodo s’arrangiò dipingendo murales onirici, presso il bar del Mecca, storico ritrovo di fricchettoni. Il titolare, pure lui omosessuale e forse suo vecchio amante, gli lasciava carta bianca pagandolo più del giusto; così quel locale di anno in anno prendeva le sembianze di un cielo costellato a zodiaco, di una Śambhala nevosa e fiorita di loto, di un Olimpo per divinità disinibite, di una New York di finestre gialle, cassonetti e piume di struzzo. Contemporaneamente esercitava l’attività di tatuatore, in spregio ad ogni norma igienica, per cavie incoscienti e adoratori di serpenti. D’altronde erano gli anni ’80, anche se da queste parti non se n’accorse nessuno. Cascami dello spirito hippy imputridivano stancamente nella bruma, perpetuando anticonformismi giovanili sempre più vacui, relegando questo paese di cacciatori e pescatori d’acqua dolce ad un manicheismo permanente, ad una contrapposizione generazionale altamente stucchevole. I giovani erano tutti vecchi già da giovani, inghiottiti dal tedio della provincia, come se la segnatura basso-padana non sapesse generare altro che argini alle acque intorbidite del tempo nuovo: simili coi simili e diversi coi diversi. Tutti uguali nei loro ruoli prestabiliti. Erano quelli i tempi delle Citroen DS Pallas, degli adesivi col vagabondo o con il simbolo dell’Om sulla Vespa, delle discoteche Cosmic, Melamara, Typhoon e dei pomeriggi noiosi passati ad ascoltare Radio Azzurra al parchetto, tra uno spinello e l’altro. Chiamavano “Afro” quella musica funky imbastardita con l’elettronica, pretesto per baccanali e inconcludenti raduni di storditi, variante nichilista del peace & love fuori tempo massimo; s’abbigliavano con larghe camicie a sbuffo, colletto alla coreana, jeans chiari strettissimi, pendagli, argenterie assortite a collo e polsi, ai piedi Clarks scamosciate. Ogni tanto qualcuno finiva nella spirale dell’eroina e ci restava secco. Li trovavano il giorno dopo distesi in macchina con le facce bianche, ibernati nei pressi di certe cascine diroccate, mentre le zolle scure all’alba emanavano vapori nel grigiore fatiscente della campagna. Morti tra le acque morte. Il Bert invece, riluttante alle medaglie di spade, furbo come i gatti, s’era già chiuso nei suoi appartamenti, congetturando d’apocalissi prossime venture. Sprezzatura d’un veterano d’ebbrezze, ma d’altronde se lo poteva permettere: alla fine degli anni ’60, assieme ad una compagnia di utopisti locali, partì per Londra, poi Amsterdam, quindi finalmente il generazionale viaggio in India: fiume Gange! Di quella comitiva tornata al villaggio dalla Lourdes degli hippies, con le boccette d’acqua sacra e taluni souvenir illegali dall’Afghanistan, solo il Bert rimase in fissa con l’induismo; gli altri, inventatisi elettricisti, idraulici, fabbri ferrai, carpentieri e messa su famiglia, dimenticarono per necessità e pragmatismo gli ori lontani dell’illuminazione. Così delle droghe: dopo l’LSD e le baluginanti fumate d’oppio venne la stanca routine dell’hashish in Padania. Dopo le infatuazioni per i mistici orientali mescolate a sincretismi rosacrociani, venne un blando attivismo antiproibizionista presso il Partito Radicale di Marco Pannella. Egli gradualmente abbandonò le scene coi bonghi e l’agitarsi dei capelloni, per divenire l’eremita del paese. Un celebre sconosciuto ormai calvo. Un emarginato ormai salvo, a suo modo un personaggio: l’Uomo-Gatto.
Ci scambiamo visite, con Roberto, come due monadi con una generazione di troppo in mezzo, anche perché è il mio dirimpettaio in via Garibaldi e traversare la strada non gli costa gran fatica. Più sue da me che il contrario, ma dipende dai periodi. Bussa al vetro, segnale in codice per chi sa che ho disattivato il campanello, quindi dopo alcuni minuti d’attesa attacca a chiamare a gran voce: «Don, Don, è urgente, ho bisogno di te!». In caso d’assenza lascia biglietti melodrammatici nella cassetta della posta. Scostando l’imposta lo vedo muoversi a scatti, nervosamente davanti alla porta, un passo e mezzo a destra un passo e mezzo a sinistra, uno avanti uno indietro, balletto di preoccupazioni con una pila d’oggetti in mano. Si tratta di vecchi volumi a tema esoterico, che vorrebbe vendermi per l’urgenza del momento: ha finito le scatolette per i gatti, afferma affranto mentre gli apro. Tantrismo, sufismo, alchimia, qabbaláh, astrologia, in belle edizioni primonovecentesche, rarità da bibliomane mescolate a dozzinali pubblicazioni ufologiche o sul cinema, Touring Club color carta da zucchero, dischi di Roxy Music, Devo, Talking Heads imbarcati dall’umidità, arrugginite scatole di biscotti, spaiati mazzi di tarocchi, campanelle tibetane, amuleti nepalesi, mappe astrali, ammennicoli elfici, civette in terracotta. Prendo tutto per i 20 euro richiesti e un paio di sigarette. Ma poi rinfrancato alza la posta, recitando un superfluo siparietto di smorfie piagnucolose: «Non avresti anche un pezzo di legno per la notte? Del sale grosso? Una bottiglia di vino? Del formaggio grattugiato? Stasera vengono a trovarmi gli amici indiani…» – alludendo a taluni bergamini inturbantati, orientali in bicicletta provenienti dal lavoro presso cascine sparse nella campagna, sovente suoi ospiti, quasi si trattasse di un consolato o di un Mandir dove meditare sui 18 canti della Bhagavad-gita – «Pronti!» ribatto cercando l’occorrente, immaginandomi con una certa attendibilità nei suoi panni, tra qualche anno. Così, grazie a quello stravagante mercimonio mensile, l’oggettistica fané in cerca di nuova polvere e la libreria arcana del Bert traslocarono da me, accadimento che assunse i connotati d’un temibile passaggio di consegne: ispirato da esotiche pratiche mistiche avrei finito anch’io per giudicare illusoria ogni realtà? Perderò il lavoro, affidandomi ciecamente all’interpretazione solipsistica delle coincidenze? Percepivo pericolosamente d’esserne propenso e l’occultismo mal si conciliava con i ripetitivi doveri della cronaca minuta, del giornalismo locale, ovvero con la mia precaria fonte di reddito. Ad oggi l’Uomo-Gatto tiene gelosamente per sé i vinili di Patty Pravo, anche se non ha più il giradischi, e un antico manuale per consultare gli astri, indispensabile strumento per compilare temi natali. D’altronde, non essendogli rimasto più nulla da vendere, con le mani atrofizzate dall’insalubrità domestica e perciò incapaci di praticare tatuaggi a rischio epatite – che per altro al giorno d’oggi nessuno si sognerebbe di fare da lui – quella degli oroscopi personalizzati resta l’ultima attività di piccolo guadagno. Fa così: traccia un cerchio col compasso su un foglio a quadretti, all’interno del quale tira delle linee, formando spicchi dove collocare i pianeti. Tutto il cielo su un pezzo di carta. In base a quel posizionamento e alla sua sapienza, nelle tre pagine seguenti narra con bella calligrafia e piglio confidenziale questioni riguardanti sconosciuti. O sconosciute. Proprio da ciò dipendono le mie sortite presso il suo domicilio, bramoso di conoscere preventivamente i segreti futuri, le più recondite intimità di certe donzelle del Leone, del Sagittario, dell’Acquario, del Toro, della Bilancia…
“Spero sempre che gli effetti terapeutici della cannabis riescano a mitigare la maledizione d’avere l’ascendente in Scorpione”, penso tra me mentre pigio il dito sul campanello. Ma poi che importa? Mica sono io il soggetto delle sue indagini stellari. «Vieni vieni, entra pure, non aver timore», fa con quei modi melliflui, tali da riportarmi alla memoria le due sorelle macellaie de La casa dalle finestre che ridono, pellicola di Pupi Avati narrante le vicende di un pittore d’agonie, di uno sprovveduto restauratore vittima dell’omertà di paese e di altre misteriose vicende ambientate alla foce del Po. Anche se da fuori la bettola del Bert somiglia più ad una casa dalle finestre che piangono, gli interni conservano ancora intatta la caleidoscopica stramberia del flower power; Berlino di campagna, austerità architettonica del dopoguerra orpellata da iconografia un poco lugubre, come di un santuario dannunziano; teatrino domestico di lacerti orfici, colonizzato da vezzi hollywoodiani versione gay d’antan. Nell’atrio i ritratti in bianco e nero di Dirk Bogarde e Charlotte Rampling, James Dean, Rock Hudson, Judy Garland e Liza Minnelli, Yukio Mishima, Jean Genet, Joe Dallesandro, Candy Darling, Lou Reed, David Bowie e molti altri, formano un mosaico emblematico, un puzzle di cartoline ingiallite appiccicate al muro con puntine da disegno. Varcata una porta di legno con finestrelle, vetro increspato d’allegorie liberty tenuto insieme col nastro adesivo, si accede ad un salottino piumato, camera tutta smaltata di rosso e blu. Dentro due enormi poltrone in velluto verde tempestate di bruciature di sigarette, in fronte a un sofà ricoperto di trapunte sgualcite dove poltrisce un numero imprecisato di gatti. Miao, fan tutti stiracchiandosi, come surreale benvenuto. A terra bottiglie vuote di alcolici, grappa e vino, nocino di contrabbando. Tutt’attorno piante grasse in vaso e altre finte, statue del Buddha e di demoni con la lingua fuori, campane di vetro contenenti ossa d’animali domestici messe in candeggina, riproduzioni accumulate in cornice del San Sebastiano di Guido Reni, candele da fabbriceria probabilmente prelevate da qualche pieve in stato d’abbandono. Zolfo e incenso, misticismi obliqui irrorati dal nauseabondo odore di piscio di gatto che rende la permanenza oltremodo difficoltosa. Ma poi dopo una sigaretta ci s’abitua a tutto, anche al doppio senso del termine ospite. Alla richiesta d’accomodarmi mi siedo sul bracciolo consunto del divano, assumendo la pavida posa del richiedente udienza. Mi tolgo dagli imbarazzi passandogli un foglietto rosa con su scritto: “Napoli, 25 gennaio 1981, ore 18.00”. L’astrologo lo prende tra due dita, come se fosse una brace incandescente, limitandosi a insistiti cenni d’assenso. «Ti consegnerò l’esito in busta chiusa tra quattro o cinque giorni» – per alimentare attesa, ma sarà domani come sempre, perché ha bisogno di soldi subito – «Ora gradisci un calice di Porto Sandeman? M’è rimasta mezza bottiglia dal cesto natalizio della Pro Loco». La finiamo in tazzine da caffè decorate alla moda del Kandinskij, ciaccolando di Schopenhauer, Pascal, Guénon, Crowley, Gurdjieff, davanti ad una stufa in ghisa agli ultimi tepori. Inebriato dal vino liquoroso azzardo una sortita maldestra, una stoccata fuori protocollo per ridestare il colloquio dal mero ricamo dialettico, dall’eruditismo sofistico inerente culti catacombali mitraici o dell’androginia ermetica del Rebis: «Senti Bert, ma tu ci credi veramente? Intendo ai tarocchi, agli oroscopi, alle reincarnazioni, agli spiriti, al paranormale?». E lui serafico, accavallando la gamba, con quei pantaloni maron di velluto a coste larghe: «Credere? Semmai il contrario, perché solo smettendo di aver fede nelle cose, nei fatti, nella realtà, perfino negli strumenti divinatori e negli oracoli, la vita degli altri si fa un po’ leggibile». Silenzio, appagata boccata di fumo da quella bocca senza più denti, poi riprende con tono lievemente artificioso: «Indubbiamente serve una certa conoscenza, anche matematica, per indagare il futuro, ma ancor più è necessario liberarsene, svuotarsi, farsi porosi al cospetto dei segni; si conosce l’ignoto altrui attraverso l’ignoto che ci permea», quindi chiude in leggerezza; «Oppure parlando ai gatti, affidando l’esito dell’oroscopo alle loro reazioni enigmatiche… Spesso sono i micetti a decidere… Per me è solo un gioco di miagolii siderali, per il consultante invece sembra sempre una questione di vita o di morte». Siamo entrambi ubriachi, consci dell’ora tarda e che là fuori la notte è greve. La notte è gelida e oscura. La notte muta che fa cantare i morti fin dentro la sala, volteggianti spettri entrati come spifferi, ebbri passaggi catturati per un attimo sulle specchiere ossidate, sorpresi loro malgrado dalla coda dell’occhio. Suggestioni. Seduta spiritica tra mici dormienti appallottolati in ciambelle di pelo, fumoir narciso su un tavolino traballante che culmina in lievi elzeviri su cenere: «Post fata resurgo», sussurra il Bert poco prima del commiato, contemplando il braciere quasi spento. Passando davanti allo specchio invecchiato dell’atrio non mi riconosco, forse era il mago che mi accompagnava alla porta a velare il transito, forse a riflettersi null’altro che un presentimento messosi di traverso.
Neve il mattino seguente, la rosa nel vaso è già imbiancata e nella cassetta della posta c’è una lettera, con l’effige dell’Acquario disegnata a pennarello sulla busta. Brocca d’acqua e pesci gialli assiderati, mentre la temperatura va sottozero il flutto dolce si ghiaccia in tariffa. “Sono 20 euro grazie, Bert”, recita il post-it in allegato. Quando mai l’avrà stilato l’oroscopo, se ci siamo salutati da poche ore? Mistero, o forse solo tempi diversi dettati dall’insonnia. Così quella busta diventa prassi di doppio Mercurio, come un Ermete carpiato – messaggio degli Dei che passa dalla mano del mago a quella del tramite interessato, e quindi forse alla signorina indagata negli astri – che potrebbe farsi rituale bendato affidato alle Poste Italiane, oppure perdersi nel gorgo della curiosità personale, infrangendo così il patto di segretezza che vincola certe ambasciate. Prevale come sempre la seconda, sicché la dissigillo ficcando il naso tra stelle e pianeti, ascendenti, costellazioni forestiere, metalli e premonizioni che non mi riguardano direttamente, tutto uno zodiaco altrui messo in inchiostro su foglietto a righe dalla bella mano del Bert. Compito in classe d’un veggente, premure da vecchia zia, perfide coccole di un abile affabulatore. Leggendo con avidità, improvvisamente l’umore si guasta. Ma perché sapere anzitempo di gioie e delusioni di là da venire? Forse per evitarle entrambe? Per profanare la sorpresa della vita? Nauseato dalle previsioni astrologiche, dalle possibili gravidanze impreviste di un’amabile sconosciuta richiudo la busta, affidandola senza indugi al guscio ingiallito di un vecchio libro, dove sparirà come un fiore secco. Di malumore traverso la strada per saldare il debito, il Bert è già sulla porta inscalfibile al tempo, in paziente attesa della banconota. Col gatto prediletto acciambellato al collo a mo’ di sciarpa, nota immediatamente la delusione che accompagna i miei passi verso di lui. Piegando il sorriso in una smorfia luciferina mi fa: «Non sarà attraverso il futuro degli altri che eviterai di pensare al tuo». «Grazie, il futuro non esiste», sono già di spalle mentre medito sul fatto d’avergli commissionato decine di oroscopi, ma mai il mio.