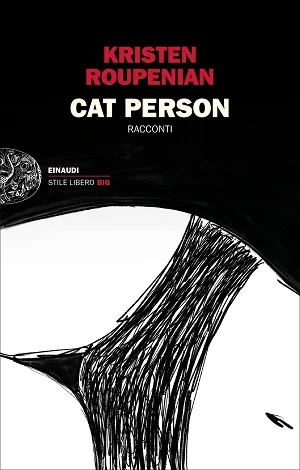di Roberto Galofaro
Una buona storia è il paesaggio interiore di un personaggio
In una breve lezione di scrittura creativa, Yiyun Li dice che bisogna evitare di scrivere drammi incentrati su un singolo evento significativo: una situazione, per quando drammatica, misteriosa e carica di conflitto, di per sé non costituisce una storia. Al contrario, una storia si rivela interessante quando ci offre una prospettiva nuova per mettere a fuoco un personaggio; quando, invece che concentrarsi su un unico, denso segmento temporale, la narrazione si dispiega facendoci intuire l’intera storia del personaggio chiamato in causa, mettendone in connessione presente e passato. Le interazioni tra i personaggi ne rivelano le intenzioni, ovviamente, ma anche le motivazioni: è quel che in genere si sintetizza brutalmente in «non esistono i personaggi ma le relazioni tra personaggi».
Li pronuncia una frase che può valere come epigrafe della sua stessa opera: «A good story is a character’s internal landscape». A questo precetto si conformano i racconti di Ragazzo d’oro, ragazza di smeraldo, raccolta uscita negli Stati Uniti nel 2010 e da poco pubblicata in Italia da NN editore, nella traduzione di Eva Kampmann.
I nove racconti sono tutti ambientati in Cina, una collocazione geografica che al lettore italiano contemporaneo, al pari di un qualsiasi lettore occidentale del 2019, risulterà inevitabilmente esotica così come esotici risulteranno i riferimenti storici e culturali qua e là evocati. Sotto questo profilo, poco o nulla delle situazioni narrate è familiare, e tuttavia, questo è assolutamente irrilevante. Sì, leggiamo di scambi di email, di siti internet, persino di una maternità surrogata. Ma leggiamo anche di un anno di servizio militare obbligatorio, imposto dal regime comunista per rinsaldare la disciplina dei giovani dopo il massacro di piazza Tienanmen. Leggiamo anche di donne che combinano matrimoni e di uomini che vengono pestati a sangue dalle Guardie Rosse. Leggiamo di cibo razionato e persino di preservativi razionati. Siamo coinvolti, emozionati, turbati dalla lettura, dalla peculiare capacità di Li di raccontare nove paesaggi umani, mettendone in scena l’esistenza come conflitto con il proprio melodramma: non l’esito comico o tragico, non l’intreccio, non la trama, non la soluzione cerebrale, razionale, fattuale di un conflitto. La pura manifestazione dell’emotività, del sentimento. Irrisolvibile, e irriducibile.
Drogata di fatalismo
Yiyun Li è nata a Pechino nel novembre del 1972, ha studiato in Cina e, dopo un anno di servizio militare obbligatorio, si è trasferita negli Stati Uniti per specializzarsi in Immunologia. A quel punto, però, ha scelto di abbandonare la carriera medico-scientifica e di dedicarsi alla scrittura, abbandonando definitivamente anche la lingua madre cinese per l’inglese, e ha conseguito un Master of Fine Arts in Creative Nonfiction presso l’Università dell’Iowa.
Ha esordito nel 2003 sul «New Yorker», che in seguito l’ha segnalata tra i venti scrittori sotto i quarant’anni da tenere d’occhio, mentre la sua prima raccolta di racconti, Mille anni di preghiere, è uscita nel 2005 (in Italia per Einaudi nel 2007, nella traduzione di Eva Kampmann). Ha ricevuto premi prestigiosi come il PEN/Hemingway e una MacArthur Foundation fellowship. Oggi insegna a Princeton, dove vive con il marito e i figli.
Ma c’è ancora una notizia biografica, assai intima, che colpisce e che potrebbe sembrare apparentemente pettegola, forse eccessiva nel dettaglio, tanto che sulle bandelle e sul sito di Penguin non è riportata: Yiyun Li ha avuto un esaurimento nervoso nel 2012, dice la scarna nota biografica su Wikipedia, e ha tentato due volte il suicidio.
Nel 2017, dopo anni di riflessioni e di riscritture, ha raccontato se stessa e la propria vocazione e formazione letteraria a partire da quell’esperienza nel memoir Caro amico dalla mia vita scrivo a te nella tua (uscito nel 2018 per NN editore, nella traduzione di Laura Noulian). Da questo libro è possibile partire per cercare le parole chiave, una luce, un’illuminazione sulla scrittura di Yiyun Li.
Non è un libro sul suicidio e sul tentato suicidio, non è né una difesa né una condanna del gesto estremo, né una ricostruzione puntuale della crisi e dei momenti difficili vissuti, anche se affronta tutti questi temi in una confessione intellettuale molto lucida. Yiyun Li accenna sì al difficile rapporto con la madre, che con i suoi ricatti emotivi era per lei quasi come una figlia, racconta della sua tendenza al fatalismo, un fatalismo testardo e rassegnato. Ma il libro è, sorprendentemente, il racconto del suo apprendistato letterario, che ha origine con la lettura delle poesie in prosa di Turgenev e che prosegue con una passione per il massimo della scrittura autobiografica: i diari e le lettere di autori fondamentali per Li: Turgenev, Sweig, Mansfield, Woolf, Kierkegaard, Moore, Bowen e altri. È la storia di una persona che, scegliendo di cambiare lingua, ha azzerato o quasi i propri ricordi, il proprio passato – senza per questo ottenere una pacificazione («Quando ricordiamo in una lingua d’adozione, nella memoria c’è una linea di confine. Ciò che successe prima che adottassimo la nuova lingua potrebbe essere accaduto nella vita di un altro; potrebbe addirittura essere frutto della nostra fantasia»). È il racconto di una donna che da sempre si è negata l’affetto e l’amore altrui per timore di perderlo o di non meritarlo o, peggio ancora, per timore di esserne determinata, preferendo restare un “niente”, una reclusa. Coltiva un desiderio di invisibilità, autodistruttivo, e si sente malata di fatalismo, laddove fatalismo è «prendere a ogni svolta una decisione sprezzante e contraria al proprio intuito». Ma è anche accettare la sofferenza con apparente rassegnazione: «Essere drogata di fatalismo può farti apparire calma, capace, persino felice».
Al di là dei dati biografici, Caro amico è una miniera di riflessioni sulla creatività di Li. Mentre dagli affetti della vita reale vorrebbe tagliarsi via, deresponsabilizzarsi, per i personaggi dei suoi libri nutre un affetto e un’ossessione assoluti, perché rispetto ad essi può, senza timore di ritorsioni, sentirsi partecipe e ignorata: non le chiederanno mai conto, non si ripresenteranno se non sarà lei ad andarli a rievocare, non la dimenticheranno perché non l’hanno mai neanche conosciuta, e il filtro della memoria, che distorce per rassicurare, non la sfiorerà mai.
Yiyun Li dice di non essere e non voler essere una scrittrice autobiografica: detesta usare la parola “io” in inglese; in un altro passaggio dice di ritenere da sempre indegna di racconto la propria vita. E tuttavia, più avanti afferma: «Scriviamo parlando di ciò che ci ossessiona. Sotto questo profilo, nessuno può evitare di essere autobiografico».
Nel raccontare il suo proprio paesaggio emotivo, Yiyun Li sembra riconoscere, controvoglia, che da esso scaturisce l’attenzione per i suoi personaggi. Come può una persona allegra e vitale come lei aver pensato al suicidio, le chiedono i lettori, indiscreti. «Non mi sono mai messa a scrivere di proposito di malinconia, solitudine, sconforto. Io mi tengo per me, e non sono io a stabilire il destino dei miei personaggi; con loro sono riservata come lo sono nella vita».
Quali sono dunque le ossessioni di Yiyun Li, forse le sue principali ossessioni? Il fatalismo, il melodramma, la memoria.
Memoria e melodramma
È possibile scrivere una raccolta di racconti improntati a situazioni minime e vite sul crinale della disperazione, destini di sconfitti, rassegnati (ma non disperati), senza per questo indulgere nella negatività? Raccontare queste vite e commuovere? Raccontare esperienze del genere e far sorridere di compassione?
Yiyun Li è capace di farlo, grazie a una scrittura sempre moderata, nonostante l’altissima temperatura emotiva.
In Caro amico leggiamo:
«Tutto considerato, direi che la memoria ha due forme, nessuna delle quali è esente da distorsioni: una è il melodramma, l’altra il ricordo riveduto e corretto. Ci aggrappiamo a quest’ultimo perché il melodramma non ci riduca la vita in macerie.
Ma, decurtata dal melodramma, cosa ci resta se non una vita vuota, fatta di impegni?».
Possiamo tenere queste parole come faro per l’interpretazione della raccolta Ragazzo d’oro, ragazza di smeraldo.
Sono parole che escludono l’assalto frontale all’esistenza, che configurano invece un ripiegamento. La memoria è il fondamento dell’identità dei personaggi di Yiyun Li ma, contariamente a quanto ci aspetteremmo, non in una funzione di rivendicazione ma di rassegnazione, un compromesso con la propria storia personale, anche se non pacificato.
L’adattamento, la rinegoziazione comportano l’infelicità sottotraccia, che sia riconosciuta come tale o no, che sia lamentata o no. Il crollo, se è avvenuto, è stato senza schianto. Quasi che la frana si sia svolta a un ritmo costante e lento, quasi coincidesse con il procedere del tempo: il fatalismo.
Così è per i due personaggi contrapposti del racconto che dà il titolo alla raccolta. Siyu, la trentottenne “ragazza di smeraldo”, è invitata a unirsi in matrimonio con il figlio dell’anziana professoressa Dai, il “ragazzo d’oro” Hanfeng. È un matrimonio impossibile, e il legante della pressione sociale, che imporrebbe le nozze per mettere compimento a una vita, è insieme trascinante e indifferente. Leggendo, diventa chiaro che nessuno dei tre ha una ragione sufficiente per compiere uno strappo, tuttavia, e alla fine Li scrive:
«Erano persone sole e tristi, tutte e tre, e non sarebbero diventate meno tristi grazie alle altre due, ma potevano, con molta cura, creare un mondo che avrebbe accolto la loro solitudine».
In Un uomo come lui, la madre del maestro Fei, novantenne, porta le tracce di un tempo in cui il regime comunista razionava il latte; Fei, sessantenne, insegnante d’arte in pensione, assiste la madre ogni mattina e ogni sera, ma passa i pomeriggi in un internet cafè a chattare e si chiede se, di lì a cinquant’anni, i ragazzini fonderanno la loro nostalgia su un mondo fallace che è esistito soltanto all’interno di un apparecchio. Passato, presente. Rimembranza, nostalgia. Il maestro è scapolo, annota le frasi pronunciate dalla madre quando sembrano massime di saggezza: «Non ho nulla da dire su questo mondo». Una frase di un fatalismo estremo, nonché l’ultima frase pronunciata dal padre del maestro, si scoprirà, prima di suicidarsi. Fei riconosce un’anima affine in un uomo coinvolto in uno scandalo familiare: lo cerca, lo segue, lo invita a bere. E lì, raccontando a questo sconosciuto lo scandalo di un’accusa ingiusta che ha segnato anche il suo passato, si prende il suo sfogo, liberando il rancore puramente nell’atto dell’esprimerlo.
In Prigione leggiamo di una coppia che dall’America torna in Cina per scegliere una madre surrogata nel paesino d’origine. Qual è la prigione del titolo? Non è solo la gravidanza ospitata per contratto, è il matrimonio stesso, è il desiderio condiviso e imposto, è la maternità, è il richiamo del sangue, è la rabbia? «Buona parte della complessità della vita sta nel fatto che in molti dei rapporti più importanti l’io si moltiplica», scrive Li in Caro amico. Una moglie non è mai solo una moglie, è anche una madre potenziale, una figlia, una donna più ricca di altre, un’emigrata che fa ritorno al piccolo paesino cinese in cui è nata. Ogni aspetto dell’io è un muro di quella prigione che è la vita.
La signora Jin, la protagonista del racconto La proprietaria, ha una bottega davanti al carcere, nella quale prende come lavoranti le mogli degli uomini incarcerati. A dare il via al racconto è l’arrivo di un’intervistatrice, interessata a conoscere e divulgare la storia di questa benefattrice. È curioso come questo espediente sia la vera e propria incarnazione narrativa della scrittura di Yiyun Li: concedere spazio e tempo ai personaggi perché raccontino sé stessi. Scopriamo che la signora Jin è stata scaltra ed è stata vittima della scaltrezza altrui, scopriamo che, dal suo passato, è rimasta come una scoria melodrammatica l’idea di ricambiare un antico gesto di gentilezza.
In Incendio domestico facciamo la conoscenza delle “Soccorritrici di case in fiamme”: un gruppo di amiche donne tra i cinquanta e i settanta che, fallito il tentativo di fare da sensali, fallita cioè la prospettiva di imparentarsi tra loro convincendo o forzando i propri figli e figlie ad accasarsi tra loro, si dedicano al salvataggio di matrimoni a rischio di infedeltà, e più precisamente si danno a soccorrere, come un’agenzia di servizi, altre donne che temono di essere tradite dai coniugi. Il matrimonio è un’esigenza sociale, interiorizzata nella forma del ticchettio di un orologio biologico che è un conto alla rovescia verso la solitudine, l’abbandono, il fallimento. «Un vecchio innamorato è come una vecchia casa in fiamme, prende fuoco facilmente e si riduce presto in cenere», è un battuta che circolava tra loro via sms: dunque non siamo in una premodernità arcaica e in un tempo remoto, siamo in un’epoca vicina al presente, se non coincidente con esso. Questo stridente contrasto di epoche e di culture non è portato in primo piano da Yiyun Li, non è mai il tema dei suoi racconti. È un dato acquisito. La vicenda del racconto porterà in luce un’amara consapevolezza. La verità non rende liberi ma prigionieri: prigionieri si è della menzogna, prigionieri si è della verità.
In Ricordo si fronteggiano, amaramente inconciliabili, la speranza folle di una giovane donna (l’amore per un ragazzo-eroe impazzito dopo le torture subite in seguito alle manifestazioni politiche a cui ha partecipato) e la speranza folle di un anziano vedovo (sedurre una giovane donna paragonandola alla moglie morta). Il correlativo oggettivo di questo sentimento è una scatola rosa di preservativi, richiesta dalla ragazza in farmacia e interpretata come una denuncia del suo status sociale di donna single. L’irrisione delle donne anziane al bancone della farmacia nasce dal fatto che agli uomini e alle donne sposate è il datore di lavoro a passare scatole di preservativi per il controllo delle nascite.
Non è un mondo di anime candide, quello evocato da Yiyun Li, tutt’altro. Questi personaggi, infelici, malinconici, rancorosi, sono vittime del destino. Ma la vita non è l’anticorpo di se stessa. Non avvengono perciò rivolte, né atti volontaristici. Avvengono adattamenti, posture che si modificano lentamente, assistiamo al lavorio del tempo, dei rovelli interiori, alla limatura costante delle loro esistenze. Anche chi alza la voce, sembra pronunciare sulla propria esistenza la frase-pietra tombale: «Non ho niente da dire».
Rinfilare il pulcino nel guscio
L’umanità raccontata da Yiyun Li è aggrappata a una speranza minima che spesso è ripiegata indietro, che non produce futuro ma sembra ricreare all’infinito il passato.
Per pochi istanti, minuti, ore, giorni, anni, per tutta la durata che rimane – queste vite non sono spezzate, non si spezzeranno, resteranno curve verso il punto in cui l’onda si è increspata. Cerchi concentrici immortalati in un fermo immagine.
«I nostri ricordi rivelano più l’adesso che il passato. Senza dubbio il passato è qualcosa di reale. Le prove non mancano: foto, diari, lettere, vecchie valigie. Ma noi selezioniamo e scegliamo da una sovrabbondanza di prove solo quello che si confà al momento presente», leggiamo in Caro amico.
A partire da un assunto simile è costruito il racconto Gentilezza. È l’unico della raccolta scritto in prima persona, ed è quello che più di tutti sembra autobiografico, perché la protagonista rievoca il suo passato in Cina e in particolare l’anno di servizio militare obbligatorio. Ad innescare la catena di ricordi è, in un primo momento, la notizia della morte della tenente Wei.
Da lì, a ritroso, l’io narrante descrive il rapporto conflittuale con la tenente durante la leva, l’amicizia superficiale con le altre donne del campo e, scavando nella memoria, l’infanzia e il rapporto con i genitori, un padre molto in là con gli anni e una giovane e indolente madre che passa le giornate a letto, e l’intervento salvifico dell’anziana professoressa Shaun, una guida spirituale e letteraria, poi rinnegata.
La protagonista si distingue nella vita in caserma per un atteggiamento cinico e distaccato. La tenente Wei vuole piegarla alla disciplina ma soprattutto, avendo intuito qualcosa di speciale in lei, di comprenderla, impegnandola in continue conversazioni, cercando di sondare le ragioni della sua solitudine, della sua evidente malinconia. Tra loro due è un gioco di forze, di tensioni, un tiro alla fune tra opposti desideri, fino alla massima amara: «Se non desideri nulla, nulla ti vincerà». Vincere è tutto. Appostarsi in trincea contro la sorte, buona, cattiva o pessima che sia, andare avanti senza cedere. È forse per questo, per una rivendicata fissità e coerenza con il proprio destino, che il racconto inizia nel presente con le parole: «Sono una donna di quarantun anni e vivo da sola nello stesso bilocale in cui ho sempre vissuto».
Dei genitori sappiamo che tra loro è perdurato il silenzio; il loro è stato un matrimonio riparatore molto particolare, che ha scampato alla moglie il manicomio: una consolazione, più che un motivo di rancore. Ancora una volta: il risentimento non è urlato, anzi sfocia nel silenzio. Yiyun Li sceglie di mostrarci la brace, non le fiamme delle passioni. Le passioni covate a lungo, a lungo rimugnate, indigeribili. Per sempre saranno insieme rabbia e rassegnazione, tumulto e quiete. Vivere allora è come sobbollire.
La madre della protagonista è una bella donna che si lascia sfiorire in balia di uno struggimento simile alla depressione. È una psicosi, la sua? È una nevrosi? Il dato clinico è irrilevante, non hanno peso le definizioni. Sono le azioni che definiscono e informano il mondo rappresentato da Yiyun Li. Le azioni e, appunto, il paesaggio interiore.
In uno dei ricordi – citato anche in Caro amico, proprio perché scambiato per autobiografico da molti lettori –, la protagonista racconta di aver ricevuto in dono da alcune signore una coppia di pulcini. Alla loro morte, avvenuta dopo pochi giorni, aveva preso due uova, le aveva aperte con delicatezza e svuotate e aveva tentato di rinfilarci dentro i corpicini esanimi dei due pulcini. Senza riuscirci.
«Allora imparai che la vita è così,
ogni giorno finisce come un pulcino che si rifiuta di farsi rinfilare nel guscio.»