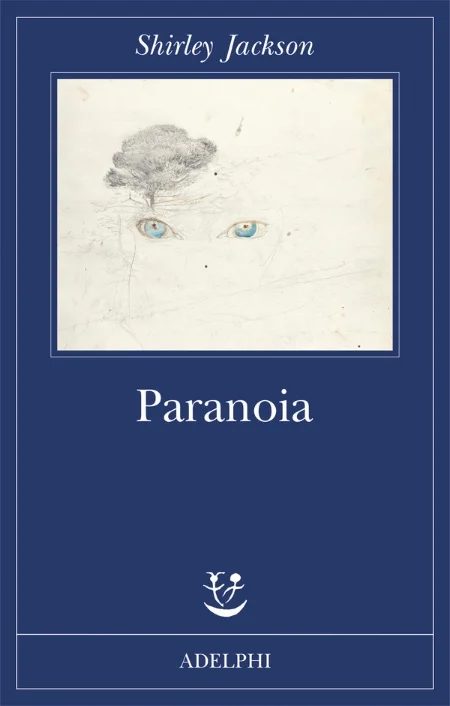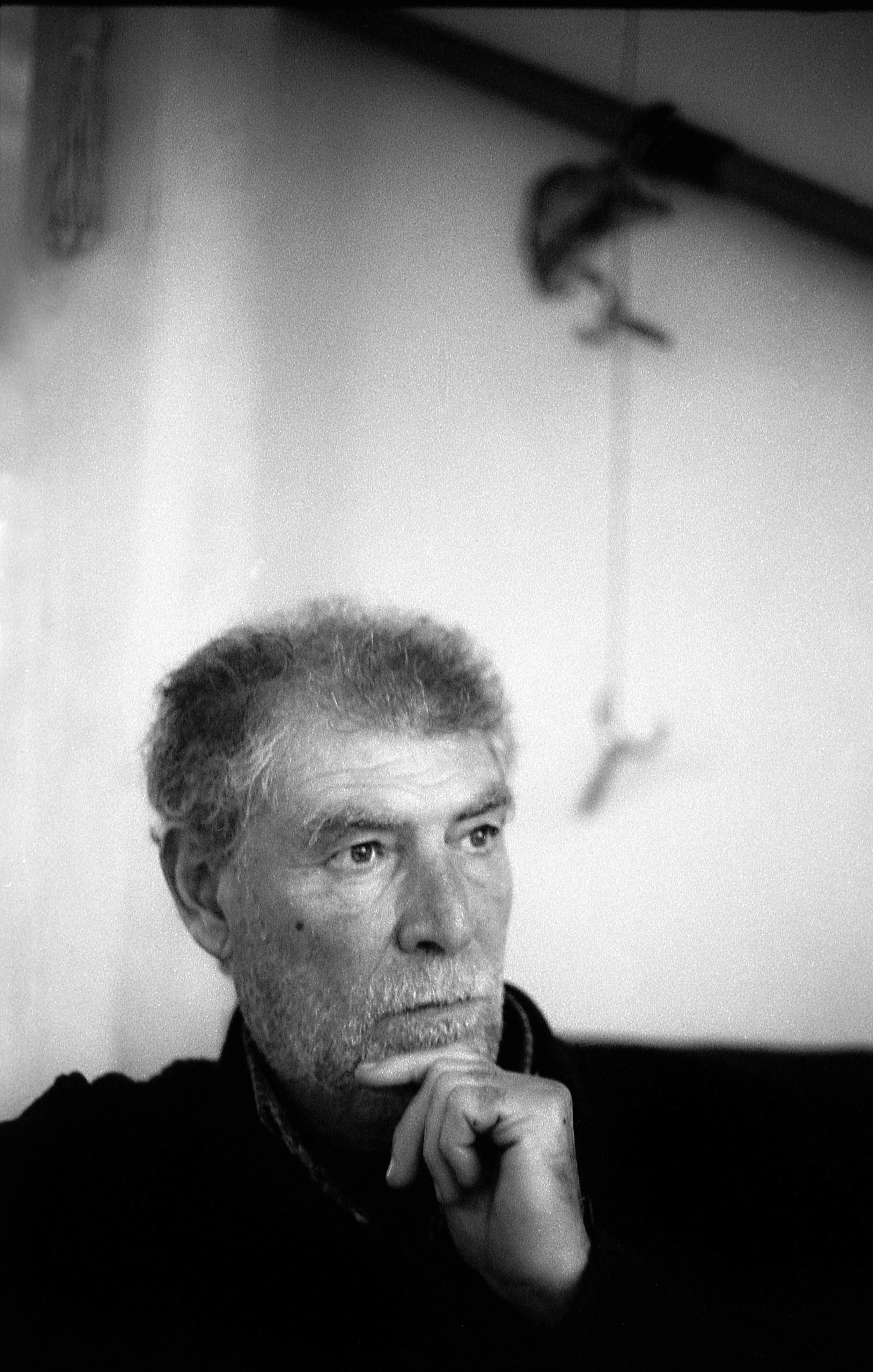Chi diavolo è László Darvasi?
Tutti i cadaveri squisiti di una Mattina d’inverno
di Andrea Cafarella
Ponetevi nello stato più passivo, o ricettivo, che potrete. Fate astrazione dal vostro genio, dalle vostre doti e da quelle di tutti gli altri. Ripetetevi che la letteratura è una delle strade più tristi che conducano a tutto.
André Breton, «Manifesto del surrealismo (1924)», Manifesti del surrealismo (Einaudi, 1966)
Io non conosco László Darvasi. Onestamente, l’unico László di cui so qualcosa ha un cognome impronunciabile (Krasznahorkai) e ha scritto un libro straordinario – Santantango (Bompiani, 2017) – da cui un altro compaesano (stavolta dal nome semplice e sicuramente anche molto più conosciuto: Béla Tarr) ha tratto un film monumentale, difficile, lento, che supera i quattrocento minuti in poco più che centocinquanta inquadrature (così ha dichiarato il regista) e del quale qualcuno ricorderà l’incipit: la celeberrima «scena delle mucche»: il primo ostacolo, la prima fatica che apre il lungo e sfiancante cammino tra le meravigliose immagini in movimento di questo film: un’opera dalla complessità rivelatrice, dalla lentezza chiarificante.
Insomma, conosco già due autori ungheresi: uno, molto conosciuto, legato all’altro da questo film leggendario. L’altro, invece, è semplicemente un omonimo del mio Darvasi, ma sembra non averci assolutamente nulla a che fare.
Continuo a cercare, scorro i nomi di altri autori ungheresi, rumeni, polacchi. Li conosco, li conoscono tutti, ma sembra che nessuno conosca László Darvasi. Chi diavolo è?
Ho trovato il suo libro sul bancone della libreria dove lavoro. Più correttamente: ho trovato le bozze, non corrette, che a volte gli editori mandano in anteprima perché i librai possano leggere in anticipo le novità che saranno tra gli scaffali nel giro di qualche mese. Più spesso le bozze rilegate in omaggio arrivano contemporaneamente alla pubblicazione del libro. Nella maggior parte dei casi non arrivano, anzi, non vengono spedite, oppure bisogna chiederle per vie traverse, e solo se il libraio (più o meno lo stesso sistema potremmo applicare a giornalisti e recensori) ha un interesse particolare per un libro in attesa di pubblicazione. In due anni non credo sia mai successo che un’anteprima arrivasse con due mesi d’anticipo. Invece siamo a febbraio e sul libro – le bozze – che ho davanti, c’è scritto «in libreria dal 19 Aprile». Il volume non ha bandelle e le due righe di testo sul retro della copertina, che raccontano l’autore, sono inutili, insufficienti; una brevissima biografia striminzita che dice: «László Darvasi è giornalista, scrittore, drammaturgo e poeta. È la voce più significativa [il corsivo è mio. Ci torneremo più avanti] della letteratura ungherese contemporanea.» Allora, penso, qualcuno lo conosce. Anzi, in Ungheria sarà famosissimo, anche più del suo omonimo dal cognome arzigogolato come le vicine scogliere croate. Mi viene in mente la Croazia, poi Budapest, Bucarest, Bratislava, mi spingo fino a Praga, Vienna, Sarajevo. Di quei posti, più di tutto ricordo i muri dei palazzoni di mattoni rossi, che ancora mostrano i fori abnormi delle pallottole di fucili e mitraglie, la cui presenza è un’emanazione lugubre, come la mano che passa distratta su una cicatrice impossibile da dimenticare. L’odore rimasto della polvere da sparo si percepisce ancora per le strade. Anche a Vienna o a Praga – che, rispetto alle sorelle dell’Est, sembrano intatte, eleganti, principesche – si nasconde quel sapore nostrano di sangue. Quell’oscuro mistero rannicchiato negli angoli bui, che si è annidato a nord della Transilvania. L’odore di morte dell’Europa dell’Est. Come se la Germania e l’Austria facessero da portone infero al deserto senza Dio che precede la fredda steppa russa, infinita, silenziosa e distesa fino ai confini del mondo, dove la vita è un concetto flebile e perso, solo, nel freddissimo nulla.
«Il nostro mercato è come il paradiso. Ovunque guardi, c’è di tutto. E quello che non c’è, si può immaginare. E io so bene che per poter immaginare le cose si deve essere liberi, dev’essere la libertà ad avere in mano il cuore della persone. Perché dove c’è schiavitù c’è solo desiderio. Non è mica un caso se racconto tutta questa storia». («La caduta»)
Ricominciamo da capo: chi diavolo è questo László Darvasi? Questo bastardo dalla penna lorda che mi tiene da giorni appeso alle sue parole. Ho preso questo libro dal bancone della libreria e non ho potuto più leggere altro. Avevo voglia di parlarne in continuazione. Lo leggevo alla mia compagna, inserivo pezzi di trama dei racconti, come storie vere, nelle discussioni. Parlavo al telefono con mia madre e le descrivevo una scena del libro per rispondere alle sue domande; recitavo un pezzo a un amico, ai miei coinquilini distratti, per riempire il silenzio di casa. Forse László Darvasi è semplicemente un uomo libero. Uno scrittore libero. E per questo è riuscito a stregarmi – ammirazione. Oppure è un essere totalmente schiavo, che nella letteratura si libera. E allora è questo che mi attrae misteriosamente – compassione. Non lo so. Il fiuto, però, mi dice che sto cercando nel posto giusto...
Per capirci, questa è l’ambiguità sconvolgente insita nel concetto di «libertà» della letteratura di László Darvasi: nel racconto da cui proviene l’estratto riportato qualche riga sopra, chi racconta è un padre, caduto da una scala nel tentativo di rimettere a posto una tegola e rimasto immobile, per sempre. Il mercato di cui ci parla è il luogo in cui suo figlio lo venderà perché impossibilitato economicamente a mantenerlo in vita accanto a sé.
E poi la storia si dipana e si riversa nei mondi surreali, si dispiega nel fantastico: nella libertà concessa dall’atto di immaginare. Esplode nella potenza creatrice della Letteratura.
«Spesso non si vedeva oltre la staccionata, perfino il noce secco era ormai inghiottito dal grigiore. L’uomo stava seduto accanto alla finestra della cucina, fissava il paesaggio che si inzuppava sotto la pioggia. Era una di quelle piogge che non si smuovevano l’aria. Tendeva fili grigi tra la terra grigia e il cielo grigio.
– Vedi, la pioggia – disse». («Fiore»)
Il primo racconto della raccolta, «Fiore», è un dialogo assurdo e surreale tra un “uomo” e un “ragazzo” – evidentemente padre e figlio. Inizialmente il padre nomina le cose («Vedi, la pioggia»), come per spiegarle al figlio – e nominandole è come se le creasse, come se lui stesso evocasse le cose del mondo. Finché il ragazzo improvvisamente indica un fiore e dice «Chestolcesomotea». Una parola senza senso, detta con assoluta non curanza – almeno così farebbe supporre il fatto che il racconto finisce con il ragazzo che confessa distrattamente di non ricordare nemmeno di averla detta. «Chestolcesomotea» è davvero una parola senza senso?
«Fiore», è anche il primo racconto della sezione che Darvasi intitola «Dio». Mi viene quindi da chiedermi e chiederci: quella che ho appena descritto è solo una scena onirica, dalla bellezza delicata e abbagliante, oppure dietro questo lampo di genio si nasconde un ragionamento, una filosofia, un’intuizione? Non penso che abbia alcuna importanza – rispondere, decifrare – e che contemporaneamente abbia tutta l’importanza del mondo – cogliere, ascoltare, riflettere.
C’è qualcosa nella prosa di László Darvasi che sembra racchiudere tutto in un istante di ebrezza ascetica, in un minuscolo baluginare della Verità. Non sapere chi sia è un vero peccato, eppure, sembra impossibile scoprirlo, da qui. E forse non ha neppure importanza, dal momento che nei suoi testi non c’è niente di reale, eppure è tutto vero; posso supporre che anche lui non sia reale perché vero, come pochissimi uomini al mondo e come quei rarissimi casi di autori visionari che riescono a sfiorare con la parola il senso di ogni cosa, «il significato» – da questo punto di vista descriverlo come il più significativo degli scrittori del suo paese inizia ad avere senso e a dirmi e dirci qualcosa di più.
Invasione di spettri. Dall’Europa dell’est
Inizio a innervosirmi. Non trovo informazioni utili, non ne parla nessuno: chi cazzo è questo László Darvasi? Avevo scritto sul mio taccuino, poi mi sono arreso. Anche se ho continuato a chiedere, nei giorni, quando per esempio ho incontrato Vera Gheno o Bruno Mazzoni (traduttori eccezionali, rispettivamente dall’ungherese e dal rumeno). Ricevendo sempre risposte vaghe. Non esiste una risposta alla domanda su chi sia questo spettro famelico, questo demiurgo macabro, che mi sa un po’ di Edgar Allan Poe, un po’ di Ligotti, un po’ di Kafka, un po’ di Joseph Roth. Uno scrittore che mi riesce difficile incasellare: un Carver col cuore di Lovecraft? Non saprei proprio come descriverlo pienamente in maniera esaustiva. Perché nei racconti di Darvasi c’è tutto il dolore causato dallo sfortunato destino novecentesco di un’area geografica cui finalmente sembra essere approdata anche la nostra editoria. Quella più lungimirante, di editori piccoli e medi, editori così detti «di ricerca». Perché in Darvasi c’è la disperazione di Max Blecher, rumeno morto a 29 anni, nel 1938, dopo averne passati dieci di totale immobilità. Nella prosa di Darvasi ritroviamo le voci di Magda Szabó e di Sándor Petőfi, ma sono echi lontani, distorti, anneriti e dall’aspetto macabro. Puzzolenti. Sembra che siano stati filtrati nei bucherelli delle parole di Emil Cioran, altro illustre rumeno la cui voce suona come un brontolio cavernoso, un brusio molesto proveniente dalle macerie di un manicomio.
Ho cominciato a leggere Cuori cicatrizzati (Keller, 2018) di Blecher la sera stessa in cui ho terminato Mattina d’inverno con cadavere e mentre scrivo queste righe non riesco a non pensarci, quando chiacchiero non riesco a non parlarne. Ed è lo stesso effetto che mi ha fatto il libro di Darvasi: come un richiamo forte, interiore, che ti rapisce l’anima: un patto con Satana. Ecco, se vogliamo, László Darvasi è uno degli ultimi esponenti di quel branco di diavoli, dalla cui penna maledetta sgorga sangue nero, raffermo, che ribolle di cattiveria fredda, di cinico odio; un groviglio di cadaveri immobili stesi per le strade.
Ora, mentre continuo a cercare su internet informazioni su László Darvasi senza fortuna, né in italiano, né in inglese, spagnolo o francese, mi soffermo sull’unico dato che m’interessa davvero: il Saggiatore ha già comprato i diritti per il suo romanzo A könnymutatványosok legendája [La leggenda di giocolieri di lacrime - trad. mia]. E non vedo l’ora di leggerlo, di seguire le sue parole sporche, i suoi racconti putridi, di rovistare nel suo cadavere, ancora pulsante di vita, in cerca di qualche documento, qualche pagina, qualche oggetto, qualche brandello d’informazione che mi faccia finalmente capire, o comunque intuire, chi sia. So da dove viene, conosco alcuni tra i suoi fratelli, riconosco i nomi dei suoi personaggi perché vengono da lì, sono ungheresi anche loro. È importante, è molto importante il posto da cui si proviene. Specialmente quando parliamo di un demone che se ne va in giro come un afflato di vento freddo che sa di smog e di morte, il cui corpo, però, seppellito sotto migliaia di altri corpi putrefatti, si trova ancora – e di nuovo – in patria. Il cui alito sa ancora di gulasch e birra, nonostante la sua voce provenga dal nulla e nel nulla risuoni, «tra la terra grigia e il cielo grigio».
La morte e i morti
«Nessuno gli chiese cosa volesse, dove stesse andando lungo quel corridoio semibuio e gremito di morti. Il silenzio risuonava più stancamente, questa volta non avvertiva nemmeno i propri passi.» («Cornelia Vlad»)
Non c’è dubbio: Mattina d’inverno con cadavere è un libro sui morti, esattamente: un «corridoio semibuio e gremito di morti». I personaggi di Darvasi muoiono continuamente come mosche (attenzione, tenete a mente questo insetto) senza che questo costituisca alcun avanzare della narrazione, senza che questo abbia un’importanza cardine, maggiore o minore del grigiore del mondo che Darvasi dipinge nel primo racconto, «Fiore». La morte è il fulcro stesso della vita, dell’esistenza. Quindi, come l’aria, esiste ed è indispensabile, ma non possiamo vederla.
«L’uso parossistico della scrittura filosofica in Nietzsche, spinto costantemente al confine dell’inesprimibile, ci aiuta a oltrepassare questo strumento, a guardarlo dall’alto. [...] Il demone della scrittura, nella figura di tensione estrema, inappagata e tragica che assume in Nietzsche, ci mette in crisi dinanzi alla scrittura stessa».
Giorgio Colli, «Al di là della scrittura», Dopo Nietzsche (Adelphi, 1974)
I morti però, sono anche una provocazione, un’istanza filosofica che vuole metterci in crisi. Troviamo, per esempio, in uno dei racconti della raccolta, un personaggio che di mestiere brucia tutti gli oggetti appartenuti ai cari dei suoi clienti, dopo la loro morte. A prescindere dal percorso narrativo che segue il racconto, questa immagine, molto d’impatto, mi sembra nasconda, su un piano di riflessione più profondo, una sequenza di domande esiziali che si concatenano in una trama di questioni imprescindibili.
Attraverso i cadaveri disseminati nel libro, usati a mo’ di sacrifici votivi al Male stesso, Darvasi evoca «il demone della scrittura» di cui parla Giorgio Colli, «nella figura di tensione estrema, inappagata e tragica» che «ci mette in crisi dinanzi alla scrittura stessa». Non c’è mai un tentativo esplicito di costruire una spiegazione di quello che l’autore vorrebbe dirci e significare. Tutto è immagine e scrittura. Tutto è misterico e volatile. Lento e ostinato, pesante anche quando è ormai ridotto in cenere.
«Per esempio, spesso si aveva a che fare con oggetti che andavano avanti ad ardere nel calderone per giorni, roba che non riusciva ad andarsene, che non voleva volare via, che desiderava rimanere, fatta di materiali lenti e ostinati, pesanti anche quando erano ormai ridotti in cenere». («Màrta era stata in Asia»)
L’ambiguità delle mosche
Leggendo Darvasi mi è venuto in mente Dopo Nietzsche di Giorgio Colli perché, giustamente, dedica – in questo libro che risplende sull’opera dell’immenso filosofo tedesco – un intero capitolo alla sua «scrittura» e alla potenza che le parole riescono a sprigionare attraverso l’ambiguità. L’ambiguità dell’aforisma, la perturbante incompletezza della prosa nietzschiana. Un periodare che sgomenta e che può spaventare, che provoca. Che provoca una reazione sostantiva, qualunque essa sia.
In Mattina d’inverno con cadavere Darvasi costruisce un sistema di simboli, d’immagini oscure, nascoste o invisibili. Richiami, giochi di specchi, urla grottesche la cui eco si riversa da un racconto a un altro. La morte è la mosca e la mosca è la morte. C’è questo insetto iconico che svolazza da un cadavere all’altro come se venisse da una dimensione altra, ulteriore rispetto alla nostra –come a quella della narrazione – e contemporaneamente è come se, seguendo la mosca, essa ci conducesse verso un altrove sconosciuto, per guardare a ciò che ci viene raccontato da un punto di vista diverso: dall’alto (cosa che – in termini diversi – anche Colli segnala nell’analisi della scrittura nell’opera di Nietzsche).
«Il tamburino estrasse il tamburo da sotto il corpo senza vita del trombettista, fece un gran sospiro: era intatto. Ritrovò anche le sue bacchette. Pulì il sangue dalla loro custodia. In mezzo ai morti vagavano galline sotto shock. Il camion che trasportava le galline si era scontrato frontalmente con il loro autobus. La struttura deformata del sistema di gabbie sembrava un occhio gigantesco, il cui sguardo era venato da centinaia e centinaia di fessure nere. Il tamburino si guardava intorno stringendo gli occhi. Chissà dove era finita adesso la mosca?» («Rullo di tamburo per i pazienti»)
L’autobus su cui viaggia una banda musicale, diretta a un manicomio per un’esibizione, si schianta frontalmente su un camion che trasporta galline. Ne esce vivo soltanto «Il tamburino», ovvero il suonatore del tamburo. Incurante della situazione recupera il suo strumento, «intatto», e si dirige al manicomio dove esegue la sua parte, da solo, davanti al pubblico ristretto dei pazienti.
Non so proprio cosa voglia dire Darvasi. Non sono sicuro voglia dire qualcosa di specifico ed esatto. Non credo ci sia un solo modo di interpretarlo, e nemmeno che ci siano uno o più modi per farlo. E lo stesso penso degli aforismi di Nietzsche. Però c’è qualcosa che mi turba, che mi mette a disagio. Ho bisogno di parlarne con qualcuno, a qualcuno. Sembra un po’ come la sensazione inspiegabile di malessere che ci porta ad andare da uno psicoterapeuta – o anche semplicemente che ci induce a sfogarci con un amico, a parlarne, ma è un sentore più intenso e costante. Come quando Max Renn tiene in mano la cassetta di Videodrome: la realtà si deforma, l’addome si spalanca, si fa voragine. E da quel momento – come stesse giocando a tranCendenZ – mette in dubbio la sua stessa percezione del mondo. Il mondo intero è messo in dubbio. La differenza tra reale e virtuale si assottiglia.
«Ehi tell me the truth. Are we still in the game?».
Ecco, in questo caso non siamo dentro una realtà virtuale, siamo dentro un incubo. L’incubo del demone scaturito dai sogni di Darvasi. (Per i lettori di Antoine Volodine che hanno letto Terminus Radioso (66thand2nd), sì, sembra di trovarsi nel mondo onirico di Soloviei, dentro quel kolchoz grottesco e insussistente, che però è materiale, corporeo; sentiamo che può torturarci e ucciderci in mille modi, e che l’effetto si riverserà in quello che consideravamo, prima, l’unico mondo reale).
E le mosche, il comunismo, i fiori, la kocsma sono i simboli: le porte che ci risucchiano in quest’incubo in decomposizione, giusto il tempo di dare uno sguardo e poi bisogna scappare via, tornare alla realtà, toccare delicatamente il legno levigato della scrivania, per rendersi conto di esistere, di essere tangibili e di essere sfuggiti a quel cunicolo di disperazione efferata e stravolgente.
«Mentre da lontano ascoltavamo il suono fiabesco del tamburo, il cui rullare era rivolto anche a noi, io raccontavo questa storia alla mia donna. E a lei non dispiaceva, anche se tra una parola e l’altra le nostre salive colavano e si mischiavano, e la mosca si posava ora su di me, ora su di lei. Girava sul suo viso la mosca, sul mio, ma non ci disturbava, perché rullava il tamburo, e noi non eravamo da nessuna parte, ed eravamo ovunque, perché stavamo scopando». («Rullo di tamburo per i pazienti»)
Dio, patria e famiglia
Una cosa che ho molto apprezzato – e che, verso la fine, mi ha permesso di smetterla di parlare ossessivamente di questo libro con chiunque mi stesse vicino per più di un tempo ragionevole perché mi distraessi e tornassi a pensarci – è la struttura complessiva del volume. Che tra l’altro, secondo me, ripercorre un po’ anche il concetto che ho cercato di descrivere nel paragrafo precedente. Mi riferisco al modo in cui Darvasi ti prende per i capelli con rabbia e ti scaglia nel più orribile degli inferni o in un manicomio inconsistente: nell’invisibile ospedale psichiatrico immaginato da uno dei suoi stessi pazienti. Ma la cosa straordinaria è che poi Darvasi viene a recuperarti, ti riprende delicatamente per mano – già sapeva che saresti rimasto lì, catatonico, a quel punto, e che avresti avuto bisogno di qualcuno a guidare i tuoi passi verso l’uscita e la libertà. Darvasi è un narratore cattivo, che pretende uno sforzo e una dedizione fuori dal comune. Però non è un narratore egoista alla Karl Kraus o alla Raymond Roussel. Desidera immergerci la testa nell’acqua stagnante, come in un battesimo macabro, fino al punto di farci quasi svenire, ma non cala la sua mano sul nostro capo (come la mano di Killerino nel racconto «La caduta») per ucciderci, ma per proteggerci, in qualche modo. Da cosa non saprei, non credo che lo sappia nemmeno lui, forse non lo sa nessuno. Forse, al massimo, lo aveva capito Nietzsche, oppure qualche mistico di chissà dove. Oppure nessuno, mai. Non è questo il punto, il punto è che c’è qualcosa nascosto tra le pieghe della realtà che ci racconta.
La finzione in questo libro è dichiarata, spiattellata fin dal principio: il fatto stesso di rendere i suoi personaggi delle silhouette, nominandoli con nomi-bozza (tamburino, killerino) ne è un’indicazione. E la finzione è la chiave di tutto, degli strati più profondi della narrazione. Tuttavia il libro va avanti e affronta questioni di ordine più puramente sociale e personale. Sfocia nell’intimità più limpida e toccante, si amplia verso tutte le diverse sfaccettature della complessità dell’uomo e del mondo.
Mattina d’inverno con cadavere è diviso in tre sezioni: Dio, Patria e Famiglia. Il punto di vista resta quello che ho fino ad ora presentato, ma è come se a ogni sezione cambiasse filtro, materia, direzione dello sguardo. Uno sguardo – una voce – che spazia con grande intelligenza analizzando tutto: il sopra, l’attorno e il sotto. Io, voi, noi. Ed è qui forse ciò che rende questo libro speciale: il modo di comunicare che hanno tutti i racconti della raccolta: tra di loro; le sezioni, tra di loro e al loro interno; e i racconti, tra una sezione e l’altra, mantenendo una propria luce intrinseca e un tono specifico caratterizzato dalla sezione in cui sono collocati. In parole povere: ogni racconto ha un suo peculiare senso d’esistere, ma acquista ulteriori sensi, man mano che si naviga il libro e si accostano i racconti fra loro. A un certo punto iniziamo a riconoscere i vari Béla e Márta e János e il ragazzo e il padre e le mosche e ci chiediamo chi è stato comunista e chi no. Lo facciamo ascoltando voci molto diverse, provenienti da differenti bocche, ma non potremmo non sentire quella voce unica che collega, unisce e riempie tutto. Riempie tutto di cosa? Della maestosa luce dell’intimità e della fiducia, quando László Darvasi ci racconta di sé, della sua Ungheria, della sua famiglia, di suo padre; quando, tra gli aculei taglienti della narrazione, vediamo il fiore nascosto nel suo bocciolo: «Chestolcesomotea», il fiore della Verità.
«– Perché... – pensai un poco a quale espressione usare, e alla fine optai per questa – gli hai fatto del male, perché hai fatto del male a quell’uomo? – chiesi.
– Alla fine si era avvicinato molto – disse mio figlio.
Si era spinto con la faccia quasi completamente davanti alla sua, alla faccia di mio figlio. E parlava, parlava. E gli aveva anche strattonato la spalla, il braccio.
Adesso la faccia di quell’uomo non si vedeva più, disse mio figlio, ma tutto a un tratto si era reso conto di quanto mi assomigliasse. Per questo l’aveva fatto». («Mattina d’inverno con cadavere»)
Di sogno e pazzia
«Perciò, se il nostro compito terapeutico consiste nel riaccompagnare l’Io all’altro capo del ponte, nell’insegnare al sognatore a sognare, non possiamo usare questi termini per parlare del lavoro onirico. Dobbiamo invertire il nostro consueto procedimento, che traduce il sogno nella lingua dell’Io, e tradurre invece l’Io nella lingua del sogno. Questo significa applicare una sorta di lavoro onirico all’Io, farne una metafora, vedere in trasparenza la sua cosiddetta «realtà».»
James Hillman, Il sogno e il mondo infero (Adelphi, 2003)
Il caro vecchio Hillman trova sempre le parole giuste per darci una direzione chiara, comprensibile, nell’esplorazione dei meandri più oscuri e irraggiungibili. Senza prenderci in giro, lasciandoci magari pensare che ci possa essere una luce alla fine, o almeno una finestra dalla quale farla entrare. No: per guardare nel buio non bisogna cercare una fonte luminosa, ma serrare le pupille e, pazientemente, soffermarsi sull’ombra, dapprima imperscrutabile, per svelarne un’ulteriore e più profonda oscurità. Occorre cambiare il modo in cui guardiamo e non quello che stiamo guardando. Così, per confrontarci con il mondo onirico, non possiamo cercare di decifrarlo, tradurlo nella lingua dell’Io, ma lavorare sul nostro Io interiore per riuscire a concepire il pensiero del sogno nella lingua del sogno stesso.
«L’uomo strinse gli occhi, fissando lo sguardo nella loro direzione, soffiò fuori il fumo. Accese un’altra sigaretta, diede un’altra sorsata alla birra. Scosse la testa. Non si rimise seduto, restò in piedi a scrutare la superficie dell’acqua. Ma non vedeva nulla, a parte l’infinito. Accanto ai suoi piedi si accumulavano le bottiglie vuote. Le campane della chiesa suonarono diverse volte. Si sentì l’urlo di una sirena». («Gli scalini di pietra»)
E così funzionano i racconti di Mattina d’inverno con cadavere. Sembrano dei sogni, o meglio: la realtà vista dagli occhi di un sonnambulo che sta ancora dormendo. Appaiono come quadri veristi (bell’intuizione, in questo senso, usare un titolo che rimanda palesemente al tono che potrebbe avere il titolo di un’opera pittorica: es. natura morta con teschi) raccontati dalla voce di un pazzo proveniente da chissà dove. E d’altronde sono tanti i pazzi che popolano le storie di László Darvasi, ma c’è un’unica voce, folle, che sovrasta tutte le altre voci: la sua. Ecco, forse László Darvasi è un pazzo. Questo posso dirlo con una pressoché assoluta certezza, e resterei parecchio sorpreso se si offendesse per questa mia affermazione. Secondo me avrebbe un moto d’esultanza. Mi abbraccerebbe, penso. Sì, secondo me ne sarebbe orgoglioso.
«Se fai spesso una cosa, ti sembra che sia permessa. Ti sembra che sia giusta. Falla più volte, ti ci abitui, andrà bene. O meglio, non è che vada bene, ma diventa naturale. Non smettere. Non arrenderti. Falla ancora e ancora. Segui il ritmo». («Il papà torna a casa») Esatto: la pazzia – la scrittura – per Darvasi è una forma di ripetizione patetica (nel senso di pathos) una reiterazione ossessiva che alla fine da senso alle cose, disvela un significato che prima era nascosto, misterioso, inaspettato (e qui, sulla ripetizione, ci sarebbe da fare un elenco di grandi maestri che ne hanno fatto il fulcro della loro letteratura: da Bernhard a Bolaño). E la cosa davvero interessante è che Darvasi lo dice palesemente: «Non è una cosa giusta» (nel racconto il protagonista prende a calci il padre ubriaco mentre lo riporta a casa trascinandolo su una carriola). A cosa si riferisce? Al picchiare il proprio padre? All’uccidere? Al sogno? Alla letteratura? Bè, sinceramente, lo sanno anche i bambini: sicuramente la letteratura – in generale: l’arte – non è una cosa giusta, è una cosa insensata. Fare letteratura, effettivamente, equivale a prendere a calci tuo padre.
«Diciamo che hai, giusto per fare un esempio, un colbacco. Ma ciò di cui ti occupi non è vedere come ti sta, decidere in quali occasioni infilartelo, come e perché e quando portarlo, bensì del fatto che tuo padre sparisce sotto un fumigante cielo di guerra, che muore tua madre, che si impicca tuo fratello, che ti amano, ma invece no, non ti amano. Passo. Ti occupi di come sopravvivere, come sopportare, come tollerare, eppure quante altre cose ti verrebbero in mente. Come fa, tra tutto questo ciarpame, a venirti in mente Dio? In fondo è una cosa sorprendente». («E per dire qualcosa anche a proposito di letteratura»)
Leggendo Hillman che ci dice di fare una metafora dell’Io, onestamente, non ho potuto non pensare a Dio. Dio come metafora dell’Io. E questo lo dice anche Darvasi: in mezzo al «ciarpame» della vita, in questo groviglio inestricabile di dispiaceri ai quali dobbiamo necessariamente sopravvivere – o morire – Dio – l’Io – si manifesta. Con ciò si consuma l’allucinazione.
Da una condizione metaforica, in cui l’Io diventa propriamente onirico, surreale, si può arrivare a «vedere in trasparenza la sua cosiddetta “realtà”» e sconfinare nell’intimità più recondita dell’autore e, di conseguenza, di noi stessi.
«– Dov’è il colbacco? – mi ha chiesto mio padre, spingendo davanti a me un altro bicchierino di vodka.
Mi ha guardato con odio. Questa cosa, il suo odio per me, il fatto che in fondo si dispiacesse della mia esistenza, era una cosa interessante. Non è un tipo come me che lui avrebbe voluto. Non saprei dire che tipo di discendente volesse, ma sicuramente non uno così. Non come me». («E per dire qualcosa anche a proposito di letteratura»)
Il modo in cui, in questo racconto, Darvasi racconta di sé e del suo rapporto col padre, specialmente in questo frangente, mi ha ricordato intensamente la Lettera al padre di Kafka. La disperazione che provoca quel senso d’inferiorità che può produrre l’«odio» – anche semplicemente supposto, proiettato – di nostro padre verso di noi. Un odio che è inadeguatezza, che è insicurezza, che si manifesta e vive esclusivamente dentro chi lo prova, che non esiste, a volte, se non in un patologico specchiarsi nelle paure altrui. Eppure esiste ed è un sentimento puro, che proviene da un’ammirazione profonda, da un’invidia sconfinata. D’altronde questo è uno degli archetipi di tutto il pensiero occidentale: «l’uccisione dei padri». In Mattina d’inverno con cadavere sono tanti i padri – simbolici o meno – che muoiono e che vengono uccisi. In questo libro, è vero, ci sono un sacco di temi e sotto-temi, c’è il sogno, la politica, la pazzia, la morte, l’attesa e l’azione. Ma, soprattutto, più di ogni altra cosa, ci sono i padri. C’è il padre. C’è Dio. C’è l’Io che si denuda svelando la propria fulgente verità. Vediamo lo scrittore nudo, nel quale ci specchiamo per vederci finalmente, nudi noi stessi.
Eppure ancora non sono sicuro, ancora non lo so: Chi diavolo è questo László Darvasi? Qual è il suo segreto maledetto?
Bè, proviamo a rispondere: di sicuro László Darvasi è uno di quegli artisti rari, che con una generosità spontanea, quasi innaturale, sanno mostrare il loro cuore spoglio di carne e sangue, ancora pulsante ma totalmente immateriale. Il suo segreto: darsi completamente al lettore. Succhiarci il sangue dal corpo, fino a quasi morire, per poi tagliarsi le vene e lasciarci bere il suo, direttamente alla fonte, per tornare a vivere – o non-vivere – totalmente cambiati, rinati. Iniziati al culto misterico del Male. László Darvasi è un vampiro. Uno stregone oscuro che, nel silenzio e nel freddo invernale ungherese, bofonchia formule arcane invocando i diavoli e l’apocalisse e spegnendo la luce del sole. Regalandoci, prometeoticamente, la capacità di guardare nel buio mortifero che sta dentro lo specchio, e aldilà della fine...
«Sono tornato a casa. Ho annaffiato le piante. Ho chiuso dentro gli uccelli, ho dato un calcio al pavone. Avevo del vino. Ho bevuto. Ho osservato il giardino, la mia fattoria, ho alzato lo sguardo fino al confine dei terreni, dove gli alberi si slanciano verso l’alto, scricchiolando, danzando, nelle mie orecchie risuonava ancora la musica dei galli che si fottevano tra loro. Più tardi ho provato il colbacco davanti allo specchio. Penso mi stesse bene. Ho pensato, già che ero arrivato fin lì, che forse sarebbe stato bello uccidere. Ma chi, se sono già morti?» («E per dire qualcosa anche a proposito di letteratura»)