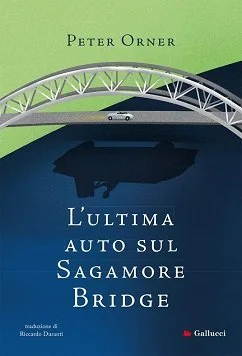Autore: Peter Orner
Editore: Gallucci
Traduzione: Riccardo Duranti
pp. 336 Euro 16,50
di Fabrizia Gagliardi
Le raccolte di racconti sono animali strani e rischiosi: concertano una complessità di storie diverse tra loro, le conducono sotto la rassicurazione di un filo comune, misurano i pesi dello stile per aspirare all’equilibrio, preparano il lettore a storie perfettamente riuscite da sole senza il bisogno delle altre, o forse sì.
È come se chi legge avesse a disposizione una doppia visione divisa tra tanti piccoli lungometraggi, tutti mossi a ritmi diversi ma sempre armonici tra loro da una parte, e, dall’altra, è come se stesse scoperchiando una scatola di fotografie, una di quelle disperse nella soffitta dei genitori, popolate da volti ignoti protagonisti di storie che vibrano singolarmente e riverberano nelle vite altrui.
Sono queste, a grandi linee, le sensazioni prodotte da L’ultima auto sul Sagamore Bridge di Peter Orner, pubblicato da Gallucci con la traduzione di Riccardo Duranti. L’etichetta di “uno dei maestri della short story americana” appare fuorviante – o forse bisognerebbe dire che ogni autore americano di short stories è speciale a modo suo –, ma non è un caso che Peter Orner era già entrato nel radar delle scoperte di minimum fax agli inizi degli anni Duemila con Esther Stories, la sua raccolta d'esordio segnalata dal New York Times come uno dei “libri da ricordare” del 2001, e poi con il romanzo Un solo tipo di vento (entrambi tradotti da Riccardo Duranti).
L’ultima auto sul Sagamore Bridge racchiude cinquantadue storie attraversate da fili invisibili e costanti: racconti lunghi e toccanti si alternano a vicende di una sola pagina che a loro volta lasciano spazio a storie in corsivo in prima persona. Arrivati alla fine, quando si uniranno i tasselli all'ultima pagina, le quattro sezioni del libro riveleranno il mosaico completo: la prima parte, Superstiti, ascolta le testimonianze di quello che rimane dopo un amore passato o dopo una perdita; la Normalità tra storie di divorzi atipici, tornei tra ergastolani e impiegati silenziosi della nettezza urbana, si interroga sulla reale esistenza di una regolarità nella vita umana; la terza parte, A Mosca sarà tutto diverso, il procedimento del ricordo si avvicina alla possibilità di originare un rimpianto inascoltato e prosegue anche nella quarta parte, Il Paese di noialtri, che chiude la raccolta.
Sebbene il Sagamore Bridge suggerisca il radicarsi nelle atmosfere del Midwest, la raccolta viaggia continuamente da Chicago, città di origine dell’autore, al New England fino a una prigione sovietica e altri soggiorni occasionali, non così significativi da occupare la caratterizzazione dei protagonisti.
A muovere la narrazione di Orner è una sincera curiosità per le conseguenze più disparate del peso delle circostanze. I racconti più devastanti nascondono, nella loro lunghezza, un avvicinamento metodico all’apice e lo affrontano da diverse prospettive come, ad esempio, il racconto di un testimone, la distanza della terza persona che viene diluita mano a mano col procedere dei ricordi o, ancora, lo strappo temporale che dal passato riporta, all’improvviso, al presente.
Nel Lamento di Pumpkin una campagna elettorale seguita dal padre del protagonista segue le vicende del candidato governatore. La cronaca delle elezioni passerà gradualmente in secondo piano al momento di una dolorosa confessione: la moglie del candidato è innamorata di un altro. Qualche sospetto su chi sia il colpevole, ma quello che è stato immaginato si scoprirà solo alla fine:
Osservarono il vapore del fiato l'uno dell’altra nell’aria gelida. In confronto a lei, avvolta nel dolore e nella larga tesa del so cappello nero, l’aspetto di mio padre appariva glaciale e sparuto. Lui distolse lo sguardo da lei solo dopo che erano arrivate altre persone che le si erano accostate per porgere le condoglianze di rito. Non ho idea di quanto fosse durato il loro rapporto. Non sono neanche tanto sicuro che la cosa abbia importanza. Oppure sì? Ora so che allontanarsi da quello che si credeva fosse impossibile fare a meno è più facile di quanto immaginassi.
La scrittura di Peter Orner ha cura di essere essenziale, evita di perdersi nelle metafore ma ama definire i particolari in rapide pennellate descrittive. Tutto miscela abilmente vite e destini traghettando il clima del racconto dall’iniziale leggerezza a una recondita saggezza che arriva solo dopo aver attraversato gli stadi di bellezza e dolore.
Ne Lo stagno di Foley la spensieratezza dei giochi da ragazzi si incupisce quando uno di loro salta una settimana di scuola dopo che la sorellina annega nello stagno, passando sotto il recinto come lui le aveva insegnato. Horace e Josephine racconta l’intera parabola di una coppia di zii, uniti fino alla fine da una tenerezza profonda e reciproca.
L’intreccio è un uso sapiente di analessi e prolessi per muoversi sui binari della memoria. Non è detto però che il bagaglio emotivo dei salti temporali suggerisca uno stimolo per un’azione risolutiva: molto spesso tutto si riduce alla contemplazione della contraddittorietà umana, al fine di restituire lo strano alla sfera del familiare.
E così in Affittuari Frank salta dal presente al passato per un viaggio nei ricordi nella casa dove lui e la compagna abitavano prima della malattia di lei; in Al Fairmont Bernice rievoca il tempo in cui accoglieva le attenzioni di uomini sconosciuti in attesa del ritorno del suo marinaio; Il divorzio è la storia così poco ordinaria di due coniugi rimasti in contatto perenne anche dopo essersi lasciati.
Lei lo amava. Certe persone che s’incontrano al mondo si finisce per amarle. Ce ne sono altre che proprio non ci si riesce. A tante non diamo neanche una seconda possibilità. Perché a Gary sì? Non c’era nulla di particolare che minacciasse il loro matrimonio e forse era stato proprio questo a far loro decidere di eliminarlo formalmente davanti allo Stato del Michigan, prima che avessero un motivo reale e quantificabile nel loro intimo più profondo.
Nei racconti di una pagina o poco più verrebbe la tentazione di chiamare in causa Lydia Davis, solo che l’incisività e la capacità di fulminare in poche righe in Orner spesso si perde preferendo una direzione non ben precisa e un finale che, in compenso, fa collezionare una serie di mantra per la vita.
Quando chiedeva: Perché mai i nostri sogni non si accontentano della realtà? (da Il poeta)
Non capite? Il movimento è dove avviene la perdita. Se solo riuscissimo a star fermi. Ma allora come si farebbe a cercare? Come si farebbe a trovare? (da Hotel Grand Pacific, Chicago, 1875)
Altre volte il monologo interiore ricorda gli intrecci di Grace Paley, soprattutto nel capolavoro di stile che è L’ultima auto sul Sagamore Bridge. Qui Walt Kaplan, personaggio che appare anche in Esther Stories, inciampa e ingarbuglia il ragionamento in uno splendido avvicendarsi di ironia e suspense.
Tornare più volte su temi e argomenti già affrontati nel corso di altre opere o, addirittura, all’interno della stessa raccolta è la vera e propria sfida lanciata dall’autore. Il lettore potrebbe percepirsi come un osservatore invisibile all’interno di una casa degli specchi: continuerà a contemplare la stessa sensazione riflessa su ogni superficie. In realtà, proprio quando Orner sembra aver esaurito tutte le sfumature possibili, ecco che è in grado di presentare tutto da capo, da una prospettiva diversa.