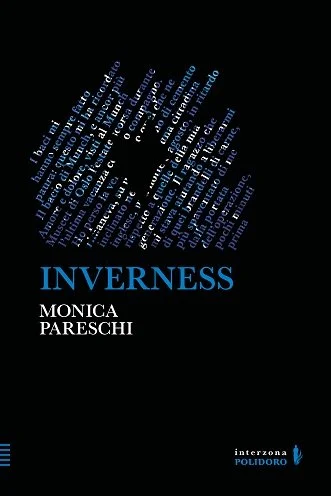di Debora Lambruschini
Per leggere Monica Pareschi ho bisogno, innanzitutto, di allontanarmi. Di provare a far tacere la voce della traduttrice amatissima per onorare stavolta la scrittrice. O, almeno, queste erano le intenzioni. Dopo una sola manciata di pagine di Inverness, la raccolta di racconti che di recente ha pubblicato per Polidoro, era già chiaro che le due voci sono indissolubilmente intrecciate, che l’una non fa alcun torto all’altra, e che pezzi della scrittrice sono sempre stati lì, tra le pagine di altri autori. Me lo conferma proprio Pareschi, nel dialogo intercorso tra noi nelle scorse settimane, quando le chiedo direttamente se il mestiere di traduttrice influenza in qualche modo quello di scrittrice:
Sì, ed è sicuramente vero anche il contrario: sono una scrittrice anche quando traduco. Ogni scrittura contiene un movimento traduttivo, in particolare ogni scrittura onestamente letteraria, e che quindi si proponga di indagare e “tradurre” ciò che è altro, difficile, paradossalmente indicibile, persino osceno nell’esperienza umana. Naturalmente la pratica quotidiana del tradurre affina gli strumenti artigianali della scrittura: si è particolarmente attenti alla lingua nel suo farsi, al suo andamento ritmico, al peso delle parole sulla pagina. Ma forse l’aspetto più evidente è che chi traduce è portato a “dire l’indicibile”: è in quel solco di difficoltà che la scrittura acquista un senso.
La fascinazione per il mestiere della traduzione esercita su alcuni lettori un potere molto forte, simile a quello stesso nei confronti della scrittura, e riconoscere, dunque, quanto l’una si intrecci all’altra significa onorarle entrambe.
Inverness è una raccolta eterogenea ma allo stesso tempo coesa, una raccolta di racconti pura, arrivata a distanza di tempo da quella precedente, È di vetro quest’aria, che ha visto la luce anche grazie alla sinergia tra Pareschi e Orazio Labbate, direttore di Interzona, la collana di narrativa italiana di Polidoro.
Il nucleo di alcune storie risale a molto tempo fa. Altre sono state scritte più di recente. Il libro, nella sua unità, è il frutto di una richiesta. Nell’autunno del 2022 mi ha contattata Orazio Labbate, spiegandomi il progetto di Interzona, la collana di Polidoro che cura e per cui è uscito Inverness. Orazio conosceva il mio libro precedente, È di vetro quest’aria, che gli era piaciuto. Mi ha chiesto se avevo qualcosa da fargli vedere, perché sarebbe stato felice di esaminarlo per la collana. Ci siamo visti, io un po’ titubante, perché qualcosa avevo ma per pigrizia, mancanza di tempo e determinazione, non ne facevo niente. Orazio mi ha aiutata a mettere a fuoco il desiderio che avevo di dare una forma unitaria al materiale che c’era, e ad aggiungerne di nuovo. Il suo è stato un intervento forte dal punto di vista motivazionale, diciamo pure maieutico, delicatissimo invece per quanto riguarda la scrittura: tanto che abbiamo scartato quasi subito l’ipotesi di trasformare i racconti in una narrazione più unitaria e più appetibile dal punto di vista editoriale. Io ogni tanto gli mandavo qualcosa, dubbiosa, e lui trovava sempre il modo per dirmi di andare avanti. Mi scriveva un commento, anche poche righe, sui miei racconti – le sensazioni che gli creavano, anche molto primarie, immediate, fisiche – che me li faceva vedere con occhi nuovi, e quello che vedevo mi piaceva, mi sembrava degno di essere raccontato. Credo che ci completiamo molto: io ho un’indole dubitante, a volte un po’ (auto)distruttiva, lui invece è molto determinato, estremamente empatico anche con scritture lontane dalla sua. Così ho sistemato o completato le storie vecchie, trovato un finale per storie che non ne avevano uno, scritto nuove storie. Man mano diventava chiaro che c’era un motivo comune che legava le storie: insomma, che c’era un libro.
Il rapporto tra lo scrittore e l’editor è fatto di equilibri delicati ed è davvero interessante questa dinamica raccontata, anche perché apre una finestra non solo sul mondo editoriale ma anche sulla sua identità di scrittrice e spinge a riflettere su quanto lo sguardo esterno, accogliente e professionista, possa nutrire la scrittura, mettere le cose in una nuova prospettiva. Da questa sinergia, dunque, nasce Inverness, frutto di una scrittura che si è presa il suo tempo, in cui è la lingua a fare il racconto. E, dato il mestiere primario di Pareschi, non poteva essere altrimenti. Se c’è come sostiene lei stessa un «motivo comune» a legare le storie, ancora prima di temi, occorrenze, suggestioni, a farlo è prima di tutto la lingua con cui decide di raccontarle: ogni parola e ogni spazio bianco sono scelti e lavorati con cura artigiana, omissioni e sottesi sono dosati con attenzione nel lasciare al lettore un ruolo attivo nella comprensione delle storie; la narrazione si compie anche attraverso il dispiegarsi di immagini, di simboli, rimandi, i racconti si aprono spesso in media res e sono attraversati da un certo grado di tensione che riesce a non venire mai meno. Colpisce, dunque, il contrasto ideale tra le parole selezionate con cura, uno stile sinuoso ma privo di orpelli inutili, e la brutalità di certe scene, la “carnalità” delle storie. Un processo che per Pareschi è difficile da spiegare ma che ha a che fare con la propria voce autoriale:
È come se la crudezza del reale si potesse rappresentare, per me, solo con una lingua controllata, distaccata, “fredda”. Riconosco in me scrittrice il desiderio, o forse dovrei dire l’impulso, a mettere ordine nel caos del reale attraverso un certo tipo di scrittura. Sì, pensandoci, la scrittura per me è proprio questo: un’attività ordinatrice.
Cercò l’odore ruvido di fumo e cuoio che chiamava maschile, e quel fondo dolcemente stomachevole di pelle attaccato alla stoffa dei vestiti che da anni l’accoglieva nell’intimità di lui. Lo trovò, e ne fu nauseata. Con la sua bella voce bassa lui le parlò di sé e del lavoro, i progetti e le attese, niente che già lei non sapesse. Mentre la luce calava un poco dietro le foglie, si lasciò cullare in una tristezza senza rimedio. (“Fiori”, p. 36)
C’è qualcosa del feroce incanto di Fleur Jaeggy, delle sue increspature minime sulla superficie che lasciano intravedere gli abissi della narrazione, la scrittura mai consolatoria o salvifica che è anche di Pareschi. Sono i rapporti umani quel motivo che si diceva lega le storie: le relazioni affettive, il corpo, le ambiguità, il desiderio, le ombre, la morbosità, sono i fili che legano gli otto racconti, le profondità del cuore in cui l’autrice si cala. Osserva, con lo sguardo di chi è allenato a scandagliare le parole e comprenderne ogni movimento minimo e implicazione, senza giudicare, senza condanna o assoluzione, qualcosa da cui la letteratura, è la stessa Pareschi a sottolinearlo, deve stare attenta a non cedere: «Se c’è una cosa che la letteratura non deve fare, è proprio questa. Sogno un reale più etico, e una letteratura meno bigotta».
Nello scandagliare le relazioni affettive, dunque, lo sguardo dell’autrice non si tira mai indietro, i sentimenti si legano anche alla carne, alla materia, alla fisicità, perché ogni cosa viene esplorata nella sua autentica brutalità, in quel contrasto ideale tra la scrittura chirurgica, controllata, “fredda”, e quanto viene narrato. I personaggi di queste storie fanno i conti con le umane debolezze, proprie o delle persone che stanno loro accanto, con la complessità dei rapporti affettivi – sentimentali e non – , del crescere, dell’invecchiare, i cui effetti sono tanto emotivi che fisici.
In “Troppo amore uccide” assistiamo al disfarsi di un matrimonio – anzi, più propriamente di due – , la rete di bugie e omissioni dietro le apparenze, che cosa si sceglie di sapere «o di sospettare». Ma a interessare è soprattutto la banalità di certe scelte che portano alla rovina.
Quell’estate il furor destruens li aveva posseduti. Alberto aveva tradito Laura, Laura aveva tradito Alberto: nessuno dei due per vera voglia, più per ingordigia, smania di potere e ripicca. Ciascuno si sentiva in diritto di essere felice, rozzamente, smodatamente, rapinosamente felice. (“Troppo amore uccide”, p. 50)
Un incidente fa venire a galla segreti che forse non si teneva poi così tanto a mantenere tali, l’ordinario scosso da qualcosa di incontrollabile che svela rapporti già irrimediabilmente incrinati.
Su queste piccole fini, disincantate e inevitabili, Pareschi costruisce alcune delle storie di Inverness, il tono dolceamaro che cola da ogni parola scelta:
Cercò l’odore ruvido di fumo e cuoio che chiamava maschile, e quel fondo dolcemente stomachevole di pelle attaccato alla stoffa dei vestiti che da anni l’accoglieva nell’intimità di lui. Lo trovò, e ne fu nauseata. Con la sua bella voce bassa lui le parlò di sé e del lavoro, i progetti e le attese, niente che già lei non sapesse. Mentre la luce calava un poco dietro le foglie, si lasciò cullare in una tristezza senza rimedio. (“Fiori”, p. 36)
I sentimenti svicolano da troppo definiti contorni spazio temporali per trovare casa in una dimensione altra, in cui il richiamo al mondo entro cui sono calati è delineato per qualche dettaglio ma quasi mai riferito alla contemporaneità più prossima. Abitano dunque uno spazio sospeso che contrasta con l’urgenza della letteratura, specie quella in lingua inglese, di raccontare la contemporaneità quasi in presa diretta: i racconti di Inverness si collocano invece in una dimensione altra, ma questa sorta di atemporalità non le rende astratte o artificiose, tutt’altro.
Come scrittrice non mi interessa particolarmente “raccontare la contemporaneità”. Voglio dire che non lo faccio programmaticamente. Immagino che, mio malgrado, le mie storie in parte lo facciano, e questo è inevitabile, visto che nella contemporaneità ci vivo. Ma se è così sono i testi, che naturalmente ne sanno sempre più del loro autore, a farlo. Non ho alcun interesse a parlare, nelle mie storie, di temi caldi, questioni dibattute quotidianamente sui giornali: per quello ci sono i giornalisti e gli opinionisti. A me interessa altro. Anzi: mi interessa soprattutto quello che non so. Forse è di questo che trattano le mie storie. Forse, se arrivano a toccare una qualche verità, è proprio questa: ciò che non sappiamo. Il mistero che ci sfiora di continuo, lasciandoci intravedere, se va bene, qualche sprazzo nel buio in cui siamo tendenzialmente immersi.
Il tempo, dunque, si compie e scorre dentro le storie, mentre poco peso ha al loro di fuori. Questo tempo interno che Pareschi sa dilatare e percorrere attraversando all’occorrenza molti anni, una vita intera, sempre senza venire meno alla frammentarietà dello spazio racconto. Un’immagine, un’increspatura, danno l’avvio al racconto che sembra compiersi come atto davanti al lettore e talvolta intraprende una strada diversa da quella che ci si sarebbe aspettati.
La solitudine della protagonista di “Un bacio, ancora” avvolge ogni parola ma non c’è pietismo, solo realtà, ed è una vita che si dispiega quasi interamente davanti al lettore, su piani temporali diversi, nel racconto di una bambina che si sforza per compiacere il padre con ogni mezzo a sua disposizione, attenta a non essere mai meno di perfetta perché dopotutto «a cosa serviva quella perfezione, se non a farsi amare?». Ma non esiste perfezione, non sulla pagina, di sicuro non nella vita e ci si accorge qualche volta troppo tardi che non può essere la chiave per farsi amare.
Papà, penso. Poi lo ripeto forte, papà. Le volte che non mi hai amata, le volte che non sono riuscita a farmi amare da te. (“Un bacio, ancora”, p. 132)
Amiamo tutti di un amore imperfetto come tali siamo in quanto esseri umani. Di queste mancanze, di una perfezione impossibile da raggiungere e che sfugge sempre sono intrise le storie talvolta molto amare di Monica Pareschi, scaturite da un’immagine che spesso si lega al mondo animale, in una simbologia molto cara all’autrice:
Gli animali sono molto importanti nei miei racconti. Per come la vedo io, loro abitano il mistero di cui ti dicevo sopra, e lo fanno, a differenza degli umani, con un grande agio. Spesso, come nei racconti “I gabbiani” e “Primo amore”, costituiscono la prima immagine, il nucleo che da quell’immagine si espande e diventa racconto. Anzi, il racconto si fa proprio coprendo la distanza che si apre tra l’animale e l’umano.
Otto storie come lampi di bellezza abbagliante, che scorticano, di sentimento ma anche e soprattutto di carne e materia. Una voce che ha trovato la sua dimensione e che possiamo riconoscere.