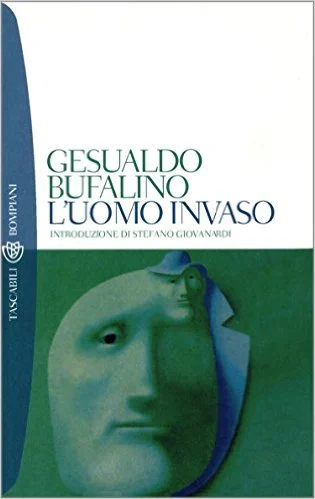Lacrime, si va in scena: Gesualdo Bufalino, Il ritorno di Euridice
di Alessandro Abbate
In un racconto che pure ha nel crudele sconcerto della sua frase di chiusura un capolavoro di beffardo scintillio narrativo, l'incipit non è meno folgorante. Per la ragione opposta; per la sua dimessa prosaicità: "Era stanca" dice Bufalino di Euridice, immediatamente introducendo il suo progetto di riduzione del mito a cose terrene, il cui obiettivo ultimo è quello di strappare il velo dell’idillio favolistico da uno scenario che invece abbonda di frustrazioni e meschinità.
Questa stanchezza non è soltanto fisica (che pure non manca: “si guardò i piedi, le facevano male”), causata dal malagevole tragitto inverso in direzione della seconda e definitiva sepoltura. Riguarda soprattutto lo sfibramento di un cuore di donna spossato dai faticosi equilibrismi della vita matrimoniale, dagli amari bocconi ingurgitati per esistere e resistere all’interno di un sodalizio così palesemente inadeguato alle sue più intime aspirazioni, dai piccoli e grandi dispiaceri quotidiani, dalle ondivaghe successioni di delizie e delusioni - tutte cose che rendono stancante anche una storia d'amore che si vorrebbe esemplare nella sua tragica tenerezza, come quella fra la più famosa delle driadi e il figlio della musa Calliope.
Stanca, dunque, e aspettando presso una sponda dello Stige l’arrivo di Caronte, in un’attesa che alla lugubre ambientazione infernale unisce le dinamiche incerte e turbolente di un comune servizio di trasporto pubblico (“Erano mille e mille, le anime, e aspettavano tremando di freddo e starnazzando, con una sorta d'impazienza affamata. [...] Anche a mettersi in fila, sarebbero passate ore prima che giungesse il suo turno”), ha tutto il tempo che le serve per riflettere, Euridice; per ricordare; per cercare di capire cos'è il "curioso agrume" che le duole in petto più del rammarico per la fallita resurrezione; quel "presagio, sospetto, vergogna" o chissà cosa, "incapace per ora di farsi pensiero, ma ostinato a premere dentro in confuso"; e che da ultimo, chiarito finalmente, la condurrà alla disastrosa consapevolezza che suo marito, se solo i casi che avvengono nell'Ade facessero giurisprudenza, sarebbe incriminabile di uxoricidio (con l'aggravante dei futili motivi, se è sostenibile la tesi che l'applauso dei tanti non valga l'abbraccio di una).
Rivive con la mente le sue vicende coniugali; s'inoltra in una meticolosa reminiscenza che occupa gran parte del racconto (da L'uomo invaso e altre invenzioni, edito da Bompiani nel 1986), e che si rivela tutt'altro che romantica. Ammette innanzi tutto d'essersi innamorata controvoglia, nel disagio di cedere a un uomo troppo celebre, troppo esposto agli appetiti delle altre donne: a "un seduttore d'orecchi", a "un accalappiatopi da non fidarsene".
Certo, almeno per i primi tempi, non erano mancati "giorni e notti celesti", il vertiginoso coinvolgimento dei sensi, il languido abbandono a quelle frasi di inimitabile dolcezza che soltanto la bocca di Orfeo era capace di sussurrare, fra un bacio e l'altro. Ferma sulla riva sulfurea a riposarsi, aspettando d'essere ricondotta nel grigio regno degli spettri, le ritorna in mente la visione di un'edenica Tracia, di un luogo di vita e di amore inesauribili, sterminati come il cielo, "solo nuvole in corsa sulla sua fronte e manciate di petali, quando li strappava dal terreno coi pugni, nel momento del piacere".
Ma tutto questo non era stato sufficiente a renderla pienamente felice, se non nei fugaci frangenti dell'estasi. Euridice voleva un marito, non un poeta. "Poeta" lo chiamava nell'intimità, fra motteggio e adulazione, con la sottile abilità muliebre di farlo innervosire e di blandirlo allo stesso tempo, ovvero di conservare sempre desta la cognizione del problema, l'origine della sua insoddisfazione, l'ineluttabile intrusione del terzo incomodo fra loro.
Bufalino tratteggia una psicologia femminile di mirabile e verissima complessità. Gli slanci sentimentali, così come le voluttuose concessioni ai lirici incantesimi di cotanto sposo, confliggono col richiamo alla praticità domestica, al desiderio di una solida normalità, al buonsenso delle piccole cose quotidiane, che in questa Euridice che avrebbe letto più volentieri Daniel Defoe che Lord Byron sembrano essere la reale sostanza della sua carne, e che ella conserva anche quando svaporata in gelida ombra. Terminata la lunga attesa, mentre la barca di Caronte la sta già traghettando verso l'ultima dimora, l'occhio le cade sulla vela logora, maldestramente rammendata: "Ero più brava io, a cucire” non si trattiene dal rivendicare. “Sono stata una buona moglie". Così come ammette di "non avere mai creduto sul serio di poterne venire fuori": rivelazione, questa, di un assennato e disilluso pronostico che sembra afferire non tanto alla debolezza di Orfeo (a quella sua fatale, involontaria esitazione), quanto alla vanità dell’irresistibile seduzione esercitata dal suo canto.
Avesse cantato un po’ di meno, il poeta, e badato maggiormente al sodo delle cose, al nutrimento della pancia come del cuore, all’amor proprio di una donna che necessitava sentirsi desiderata nei fatti, prezioso gioiello da custodire attentamente e preservare dagli sguardi altrui. E invece egli viveva così, travolto dal distratto egotismo delle sue rime ("quante arie si dava"), ebbro di un’insensibilità edulcorata ad arte, “senza dire mai dove andava, senza preoccuparsi di lasciarla a corto di provviste, deserta d’affetto, esposta ai salaci approcci di un mandriano del vicinato. Si fosse degnato di andontarsene, almeno, di fare una scenata. Macché. Si limitava, tanto per la forma, a intonare un lamento dell’amor geloso, di cui, dopo un minuto, s’era già scordato”.
Eppure lei lo aveva amato; in ogni cosa di lui; anche e soprattutto per il semplice fatto che "non sapesse cucinare un uovo": erano in mancanze come queste che ella avrebbe voluto realizzare se stessa, ansiosa di assurgere a una felicità matrimoniale in cui la padella sarebbe stata più importante della cetra. Scomoda e infelice sulla vetta del Parnaso, l’Euridice di Bufalino aspirava a un più umile paradiso fatto di omelette da portare in tavola al suo "adorabile buonannulla".
E invece c'era sempre stata la poesia d'intralcio; e alle belle chiacchiere non avevano corrisposto i fatti. Da ultimo, era subentrato il dubbio di non essere amata altrettanto; se non come disincarnato simbolo di ispirazione poetica, magari il più sublime, quello più intriso di patetico struggimento, purché definitivamente morta e irraggiungibile, anziché compagna di (seconda) vita. Ed è proprio portando a termine questa amara riflessione sullo svilimento strumentale della sua persona, mentre già l’approdo sulla riva opposta dello Stige s’intravede fra i pestilenziali vapori, che Euridice sente infine sciogliersi “quell’ingorgo nel petto” con cui s’è cimentata durante tutto il corso della traversata, e “trionfalmente, dolorosamente” capisce: “Orfeo s’era voltato apposta”.
Rielaborando lo stesso mito, quarant'anni prima di Bufalino, Cesare Pavese, in uno dei suoi Dialoghi con Leucò, aveva già introdotto lo scandalo del gesto volontario. Dando voce, però, a un Orfeo che ha riconosciuto per tempo l'inutilità e l'errore di un canto che impietosisce fino all'oltraggioso sovvertimento delle regole naturali; a un uomo, prima che poeta, il quale, fra saggezza eraclitea e suggestioni proustiane, rifiuta l’abbaglio di ciò che non può essere una seconda volta, inconsolabilmente offrendosi al rimpianto di un tempo perduto che eccede la scomparsa della donna amata, ma che riguarda in primo luogo se stesso, “non più sposo né vedovo”, la propria giovinezza, e un comune destino di fugacità che non si può né si deve sconfiggere.
Ne Il ritorno di Euridice, Orfeo ha ben altro spessore: ben più misero, gretto, emotivamente ottuso. Fra tutti gli uomini diversamente “invasi” che popolano il volume di Gesualdo Bufalino, nell'unico racconto declinato al femminile, egli ruba la scena con lo squallore di un guitto professionista: “L’aria non li aveva ancora divisi che già la sua voce baldamente intonava ‘Che farò senza Euridice?’, e non sembrava che improvvisasse, ma che a lungo avesse studiato davanti a uno specchio quei vocalizzi e filature, tutto già bell’e pronto, da esibire al pubblico, ai battimani, ai riflettori della ribalta…”.
Quale maldestro sciupio di un preziosissimo dono! E non s’intende, qui, il suo raffinatissimo canto.