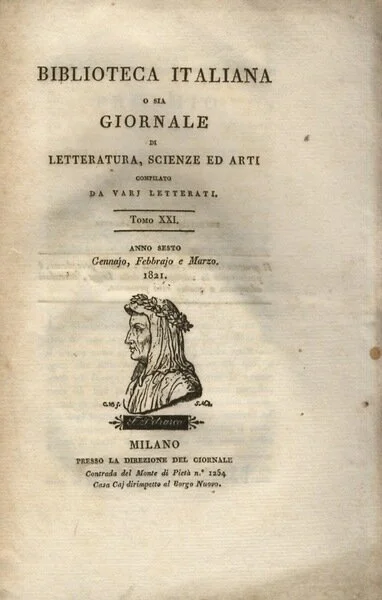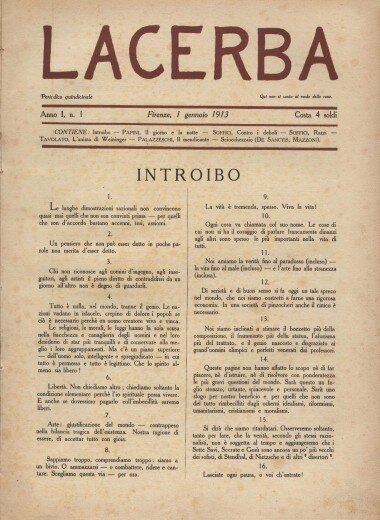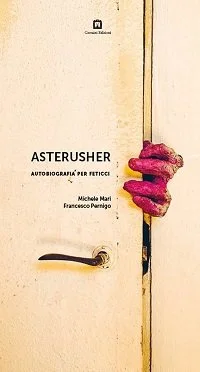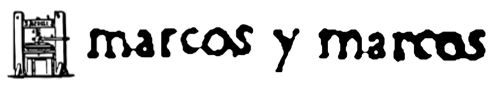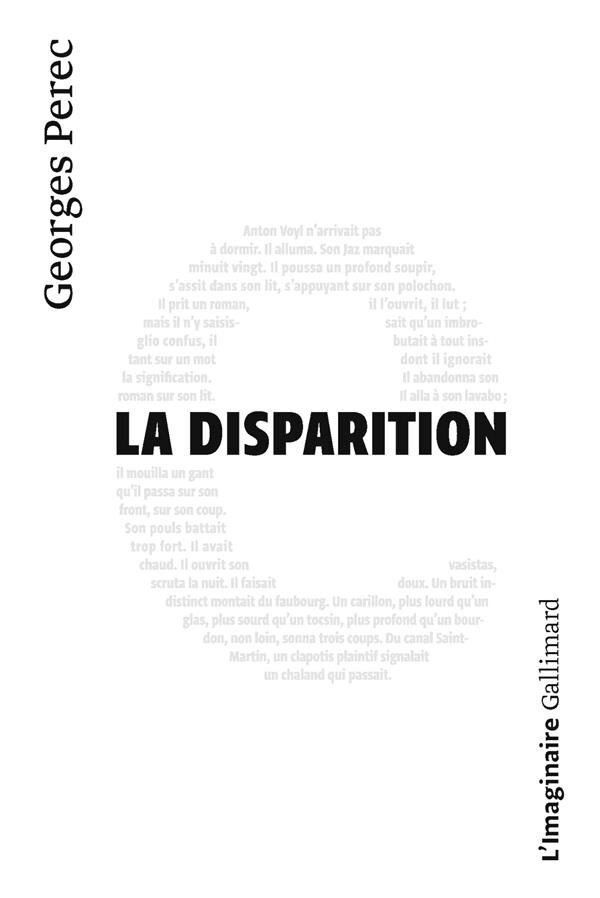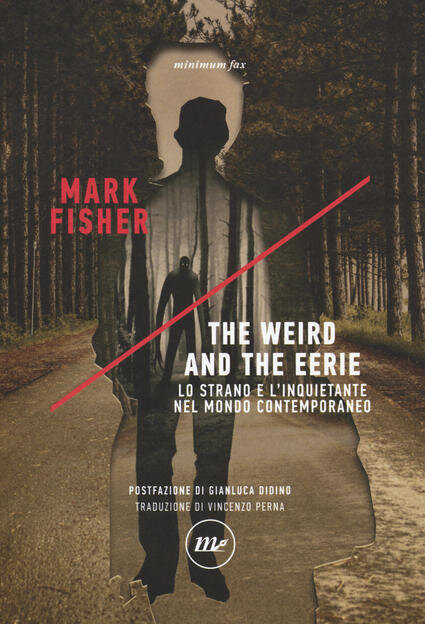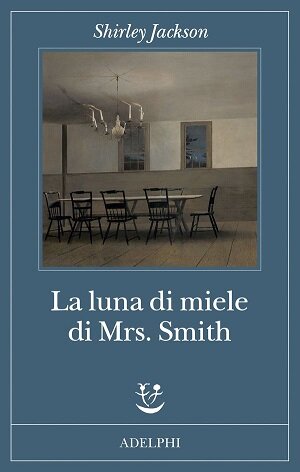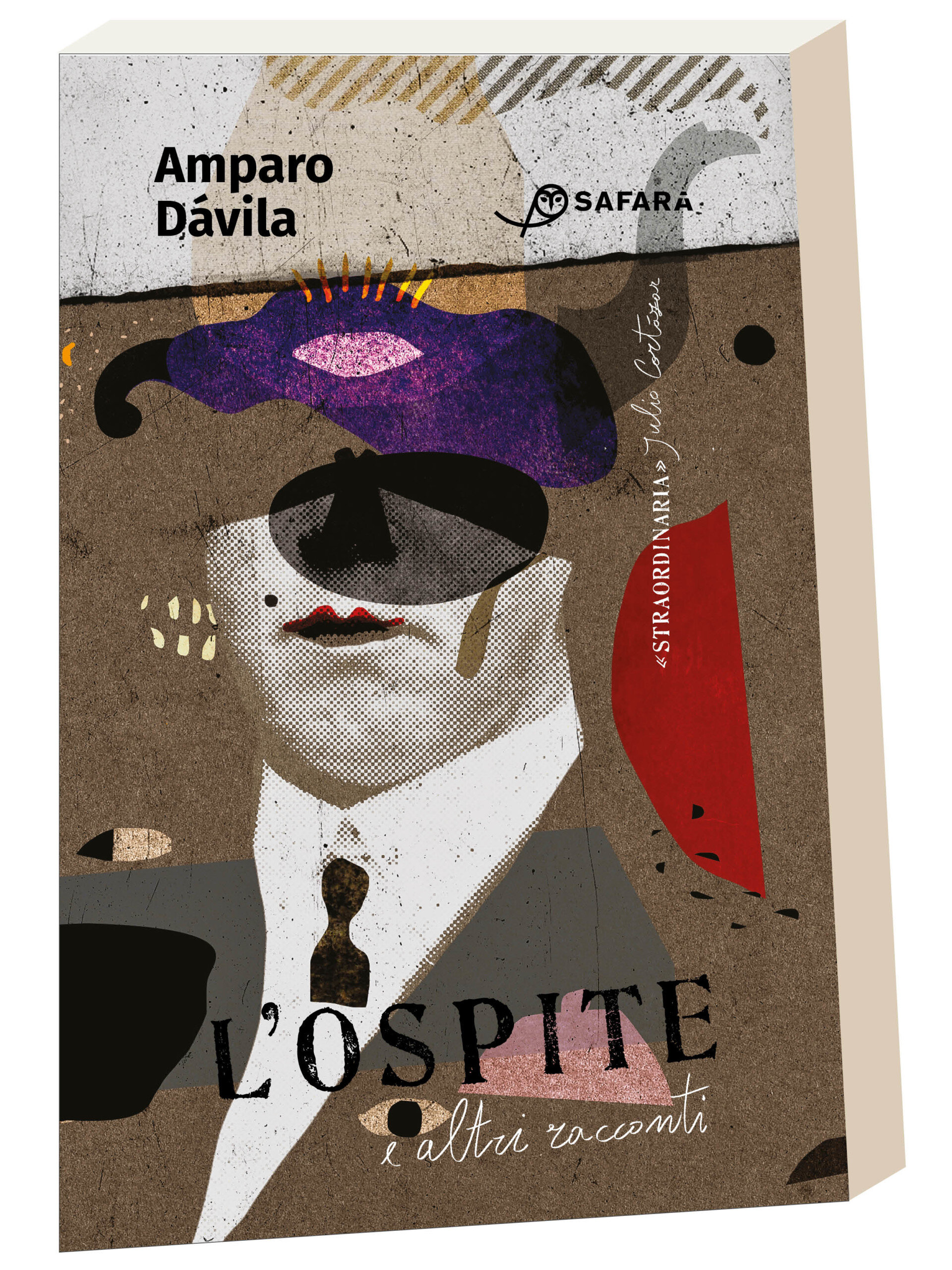di Modestina Cedola
In rete grazie alla digitalizzazione degli archivi di alcune biblioteche è possibile sfogliare vecchie riviste letterarie. Il numero è ampio e gli argomenti di cui trattano anche. Nelle prime pagine dei numeri iniziali ogni rivista riporta una sorta di dichiarazione di intenti sul proprio ruolo. Pur conservando le loro specificità quasi tutte sono accomunate dalla volontà di raccontare la realtà. Attraverso editoriali, approfondimenti, racconti e conversazioni tentare di raccontare il mondo da cui sono emerse (la rivista letteraria come isola era un concetto caro a Alba De Cespedes fondatrice di Mercurio). Il racconto della realtà è mestiere assai complesso e pretende idee chiare e voce decisa. Narrare il presente significa anche scegliere. Spostare lo sguardo dove nessuno lo posa, portare a galla situazioni scomode, dare voce a chi non ne ha, rompere tabù e liberare dalle maglie strette.
Qual è la realtà che ci viene raccontata oggi attraverso le riviste letterarie? In quale mondo ci inoltriamo leggendo i loro racconti?
Sbirciare l’idea di mondo che ha ogni rivista è cosa da fare principalmente su internet dove le riviste (anche le cartacee) presenziano. Siti, blog e social sono diventate una vera e propria appendice da usare per lanciare idee e linguaggi. A differenza dell’editoria le riviste letterarie hanno da subito trovato nelle nuove tecnologie un alleato dimostrando la rara capacità di reinventarsi e adattarsi totalmente. Non solo racconti ma anche grafica e illustrazioni, post, meme e dirette come strumenti preziosi per veicolare storie e coinvolgere direttamente i lettori.
La forma breve è la più utilizzata. Ci si muove indicativamente tra le seimila e le venticinquemila battute. È un numero di battute più ridotte di quelle che canonicamente si associano alla forma breve, forse è dovuto alla diffusa riduzione di attenzione per la lettura. Racconti brevissimi richiesti espressamente come nel caso di Pastrengo o Narrandom. Qualche tentativo di flash fiction c’è stato negli anni ma senza continuità (In una scatolina impolverata giaceva Pizzaballa[1]). Anche le forme lunghe sono più rare e nella maggioranza dei casi si sceglie di pubblicarle a puntate.
Il mondo raccontato dalle riviste è un mondo visto in soggettiva. Predomina l’uso della prima persona. Come a dire: lettore, la mia vita è la tua vita. “Sono seduta scomoda di fronte a lei, al tavolo del salotto, col busto inclinato di lato, una gamba che piomba dritta al pavimento senza arrivarci mai, l’altra sotto al sedere. La maestra Franca mi brontola se lo faccio a scuola, una volta l’ha scritto sul mio diario e la parola ‘scomposta’ mi ha fatto sentire un numero che invece di crescere diventa piccolissimo”[2]
L’editing è un campo minato per le riviste. Due macro schieramenti contrapposti e nel mezzo una folla che non si pronuncia espressamente. Riviste letterarie che non fanno editing o un editing leggerissimo e scelgono racconti che per loro sono già pronti per la pubblicazione (‘tina, Malgrado le mosche e per una serie di ragioni da qualche tempo anche La Nuova Verdə) e riviste che hanno più persone che se ne occupano e più livelli di editing. Leggenda vuole che Narrandom abbia l’accortezza di inviare un editing dei racconti scartati agli autori e alle autrici che ne hanno piacere.
La relazione con se stessi e con gli altri è il centro di molti dei racconti pubblicati dalle riviste letterarie. Un rapporto conflittuale tra le proprie aspirazioni e la vita che ci si trova a condurre. Sogni infranti, ricordi di infanzie scombussolate. Un corpo sfatto che si muove a passi lenti. Non cadere come massima ambizione. “Quella sera avverti una fitta di solitudine e incertezza. Il pensiero d’aver sbagliato ti raggiunge. La tua vita deve ancora cominciare, eppure è già pronta a sbandare al primo bivio. Ti domandi se altri, nel palazzo, condividano un’ansia simile, sempre in agguato. Pensi che, in fondo, non lo scoprirai mai, perché non conoscerai nessuno, potresti crepare e saresti licenziata prima del ritrovamento del corpo”[3]
Le relazioni familiari quasi sempre sghembe poche volte davvero in armonia. Una famiglia disfunzionale si direbbe oggi. Padri assenti, madre assillanti, fratelli stronzi e sorelle lontane. Adulti diventati involucri di bambini infelici e spaventati. “Mia madre mi diede una spinta. Quella fu la prima e ultima volta che mi toccò”[4]
L’amore non è mai romantico, poche volte erotico, quasi sempre sordo alle esigenze dell’altro. L’innamoramento, invece, è puro. La fine della relazione disastrosa ma tra le più raccontate in varie declinazioni. La coppia come incontro di solitudini che si accompagnano tra le brutture quotidiane. Un sentimento raccontato con molta tenerezza e poca passione. “Ti ho chiesto di sposarmi, dici, e invece niente, era per comprare un vibratore. Vorrei dire non mi hai chiesto di sposarti, mi hai detto un giorno che ci avevi pensato, ma non me lo stavi chiedendo, sapevi che mi sarebbe venuto il panico. Eravamo naufragati già sei o sette volte, vorrei dire, non mi pareva che ci fossero i presupposti per rilanciare. Vorrei dire che non avrei preso il tuo cognome in ogni caso, sono finiti gli anni Cinquanta”[5]
Chi ne esce meglio è l’amicizia che pare porsi esattamente al centro tra amore e famiglia. Rapporti liberi e paritari dove ognuno può essere quel che è, dove ci si accoglie e si perdona quando si ferisce o si è feriti. “Per fortuna, il dolore tra noi non ce lo dobbiamo spiegare. E dentro questa cosa, io e Andrea, ci possiamo sentire finalmente vincibili. Nella pancia, i nostri due buchi prendono aria, si tengono in vita. Lascia fare Lara. Lascia fare Andrea.”[6]
Cade il tabù dei disturbi mentali. L’ansia, la depressione, il disturbo ossessivo compulsivo, l’anoressia, il comportamento suicidario, l’autolesionismo e i vari disturbi di personalità vengono raccontati dal punto di vista interno. “se chiudo gli occhi, il mio cervello guasto mi presenta soltanto randomiche istantanee raffiguranti mutilazioni, violenze efferate inenarrabili e volti non umani, mostruosi, deformi maschere mortuarie, figure lugubri provenienti dal mio essere perennemente in affanno durante il giorno, sotto stress, paranoico, tormentato, perennemente sull’orlo dell’attacco di panico, che arriva facendosi strada dal braccio destro per espandersi nel petto e immobilizzare il corpo dal terrore”[7]
I disturbi di ansia e la solitudine trovano nel lavoro un alleato perfetto per continuare ad alimentarsi. Il lavoro è meschino, ripetitivo, logorante, giudice e carceriere di recluse esistenze. Non c’è gratificazione né ambizione, nessuna solidarietà tra colleghi né umanità da parte dei superiori. Tanti piccoli pezzi di un ingranaggio dove ognuno può essere facilmente sostituito da chiunque. Ambienti ostili in cui passare la maggior parte del tempo. A fine mese pochi soldi e tanta frustrazione da riversare su chi sta intorno. La rabbia prende poco spazio tutto occupato dalla rassegnazione. Subire, eternamente subire per poi scoppiare all’improvviso e diventare mille scintille. “Di nuovo al suo posto di lavoro, seduto, in una pausa analgesica. Quel lavoro umiliante, che un cugino di Agata gli ha offerto per solidarietà cristiana, come l’ha definita lui stesso. Prepara le buste di coriandoli per il carnevale, in un ingrosso di giocattoli, guadagnando quattro centesimi al pezzo. Prende un pugno di quei dischetti colorati da un gigantesco sacco di diversi chili, li inserisce in un sacchetto trasparente, lo pesa con accuratezza (tra i novanta e i centodieci grammi), lo sigilla sprigionando una puzza di plastica bruciata che gli invade le narici e avanti così per sette ore al giorno, cinque giorni a settimana; per soli due mesi di stipendio. Quando chiude gli occhi vede ammassi vorticosi di coriandoli”[8]
Una rivista è anche il luogo in cui allargare la prospettiva. Allargare lo sguardo da noi a chi ci cammina accanto. La stramberia diventa il punto di osservazione privilegiato. La devianza raccontata per interrogare un nuovo pezzo di mondo. Il giudizio crolla inesorabilmente per lasciare il posto alle storie.
Rispetto alle proprie antenate, le riviste letterarie attuali hanno messo completamente da parte lo scopo politico, sono poche e isolate le riviste che parlano espressamente del loro impegno in tal senso. Riescono comunque a farsi portatrici di un disagio generazionale che invade ogni spazio vitale. È il singolo a prendersi tutto lo spazio. Un individuo mai pago e perennemente sulle spine. Un diffuso senso di malessere e precarietà che aleggia sui nostri tempi e che accomuna tutti. Voci aperte e libere in cerca di un proprio posto nel mondo. L’equilibrio vacilla, tutto può cambiare da un momento all’altro. Non c’è sogno. Non c’è speranza, solo l’illusione di poterne uscire seminando leggerezza. Una bizzarra nostalgia che non guarda indietro né avanti ma che resta bloccata qui nel presente.
La realtà raccontata dalle riviste appare complessa e sfaccettata composta da micro mondi che potrebbero anche non entrare mai in collisione tra loro. Muoversi nello stesso spazio, nello stesso tempo, senza mai sfiorarsi. Il ritratto fedele di una società in cui la parola futuro è scomparsa dal vocabolario.
[1] Figurina di Mario Greco su Tuffi, link: https://tuffirivista.com/2018/01/09/figurina/
[2] Muffa di Barbara Guazzini su micorrize, link: https://www.micorrizelitlab.it/2020/10/27/muffa/
[3] Le cose che capitano di Matteo Pascoletti su L’Inquieto; link: https://www.linquieto.it/le-cose-capitano/
[4] Benzina di Federica Rigliani su Risme La rivista che non devi spolverare, link: https://506c881a-a5fc-4b79-925b-e60b08bf27fe.filesusr.com/ugd/e1f9c4_0b424a005a4e479c94f16af1b6d7da06.pdf
[5] Kaboom di Stella Poli su Narrandom, link: https://narrandom.it/2020/06/17/kaboom/
[6] Se mi lasci fare, vale di Sara Mariotti su inutile, link: https://rivista.inutile.eu/2017/09/mi-lasci-vale/
[7] Il nuovo vicino di casa di Paolo Gamerro su La Nuova Verdə, link: https://verderivista.wordpress.com/2018/02/05/il-nuovo-vicino-di-casa/
[8] Scarpe Strette di Marco Corvaia su Altri Animali, link: http://www.altrianimali.it/2020/12/01/scarpe-strette-2/