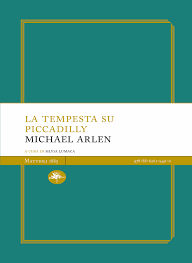di Debora Lambruschini
Se il ruolo primario delle case editrici indipendenti è recuperare gemme letterarie nascoste, Mattioli editore assolve decisamente bene a questo compito. Oltre a nuove preziose edizioni di classici della letteratura inglese e angloamericana (uno su tutti il monumentale lavoro di ritraduzione dell’opera omnia di Dickens, in corso) e la scoperta di voci contemporanee come Rick Bass, Charles Baxter, Andre Dubus, Larry Watson, James Still, Gina Berriault, l’editore si mette in cerca anche di autori e autrici del passato un tempo molto noti e finora inediti in lingua italiana. È stato per esempio il caso di Dorothy Johnson e Sarah Orne Jewett, è adesso il turno di Michael Arlen, approdato nella collana Light, dove trovano spazio sia voci conosciute con testi meno celebri ma di indubbio valore, che scritture meno note. Libretti brevi e dal formato agile, contenitori di piccoli tesori. È sempre curioso come un autore tanto popolare tra i suoi contemporanei finisca nel giro di qualche decennio nell’oblio, schiacciato dal peso di altre scritture, di altre urgenze, di nuove tendenze letterarie. Non tutto riesce a superare la prova del tempo, una società che si rinnova, gusti letterari che cambiano. Ma qualcosa vale la pena ogni tanto di essere salvato e di arrivare al lettore contemporaneo, che certo saprà contestualizzare l’opera, la poetica su cui si regge, il mondo letterario sul quale si fonda. La riscoperta di Michael Arlen, dunque, si colloca in questo solco e se pure non stravolgerà il mercato editoriale odierno e forse non darà nuovo lustro all’autore, saprà certo farsi apprezzare dai lettori per quella prosa mirabilmente restituita dalla curatrice, Silvia Lumaca, il wit che attraversa i cinque racconti selezionati, la leggerezza mai superficiale.
Mattioli dunque presenta per la prima volta al pubblico italiano una selezione di racconti di Arlen, tratti dalla più ampia raccolta The Crooked Coronet and other misrepresentations of the real facts of life, del 1937: cinque racconti che ben rappresentano una parte specifica dell’universo letterario dello scrittore, accomunati dal gusto per l’ironia e la rappresentazione della società inglese di inizio Novecento.
Nato nel 1895 da una famiglia di mercanti a Ruse, in Bulgaria, all’età di sei anni Arlen si trasferisce con la famiglia nel regno Unito, per sfuggire al terribile genocidio perpetuato dagli ottomani contro la minoranza armena, adottando dunque la cultura e la lingua del paese che divenne il suo. Dopo una bizzarra parentesi a Edimburgo dove sceglie di studiare medicina rifiutando di frequentare Oxford, lascia presto il mondo universitario per dirigersi a Londra e tentare la carriera letteraria. Questi anni a Londra coincidono anche con lo scoppio della prima guerra mondiale e la posizione di Arlen è comune ad altri autori del tempo tra cui Aldous Huxley, D. H. Lawrence e George Moore: nonostante sia arrivato nel Regno Unito con la famiglia ad appena sei anni, Arlen infatti non è ancora cittadino britannico e l’alleanza della Bulgaria con la Germania crea una situazione particolarmente complessa per lo scrittore che non può prestare servizio militare nell’esercito inglese ed è guardato con sospetto per le sue origini. L’identità divisa caratterizza le prime esperienze letterarie di Arlen che inizia a collaborare – firmandosi con il nome di nascita Dikran Kouyoumdjian – con un periodico armeno con sede a Londra e con una rivista britannica che si occupa di letteratura, politica, arte. Affascinato dal mondo letterario dove iniziano a circolare le sue prime opere, adotta dunque il nome Michael Arlen, viene naturalizzato cittadino britannico e adotta anche legalmente il nome scelto.
Elegante nei modi e nell’abbigliamento, Arlen diventa una celebrità a seguito della pubblicazione del suo romanzo The Green Hat (1924), poi adattato da lui stesso per Broadway e per il West End di Londra e dal quale pochi anni dopo viene tratto un film con Greta Garbo, censurando le parti del romanzo ritenute più problematiche (omosessualità e malattie veneree).
Romanziere e autore di racconti, saggista, sceneggiatore, attraversa dunque con successo i primi decenni del Novecento, finendo anche sulla copertina di Time Magazine nel 1927; il suo nome si rincorre sulle pagine delle riviste, non solo letterarie: frequentatore del bel mondo e dell’ambiente intellettuale, viaggia tra Europa e Stati Uniti. Allo scoppio della seconda guerra mondiale torna in patria e la sua scrittura si fa sempre più attenta alla situazione politica; riceve anche un incarico ufficiale dalla Corona, ma ancora una volta la sua fedeltà è messa in dubbio e decide dunque di lasciare per sempre il Regno Unito e trasferirsi a New York, dove rimane fino alla morte, nel 1956. Già da qualche tempo esaurita la vena creativa smette del tutto di scrivere e si dedica al matrimonio e alla vita famigliare, dopo che nel 1928 aveva sposato la contessa Atalanta Mercati e dalla quale ha avuto due figli.
Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale e archiviato il ruolo di scrittore, il nome di Arlen viene gradualmente dimenticato dal mondo letterario e questa piccola ma molto interessante selezione operata da Mattioli è al momento l’unico testo disponibile per i lettori italiani (se si esclude la sola versione ebook del suo romanzo, Il cappello verde, per StreetLib). I cinque racconti riuniti in La tempesta su Piccadilly sono dunque la lettura ideale per conoscere una parte dell’universo creativo dello scrittore inglese e scoprirne l’ironia ancora pungente, raffinata, le svolte impreviste della trama. La penna di Arlen dà forma alla buona società inglese di inizio secolo svelandone al lettore vizi e – qualche rara – virtù, con uno spiccato gusto per ciò che si cela appena oltre le apparenze di rispettabilità. È proprio questo in fondo il fil rouge che lega le cinque storie o, dovremmo forse dire, il filo di perle (al lettore scoprire il riferimento): cambiano i toni e i personaggi, ricorrono tra le pagine inganni, apparenze da mantenere, sotterfugi, accordi matrimoniali, irreprensibili apparenze. Arlen gioca amabilmente con il lettore attraverso storie dove difficilmente il mistero viene svelato del tutto o, quantomeno, non come ci si aspetterebbe e pur mantenendo lo spirito che ne caratterizza la scrittura i racconti si muovono su piani diversi e aprono a spunti interessanti. A partire, per esempio, dal tema matrimoniale, che l’autore disvela da angolature sempre diverse e intrecciandolo a ulteriori questioni sotto l’apparente leggerezza. Nel racconto che apre la raccolta, “Quella canaglia di una cameriera per signora”, lo sguardo di Arlen entra nelle stanze private di una donna, Porzia, e la storia si compie nei fitti dialoghi con la propria cameriera personale, l’unica in apparenza a conoscere il segreto della vera età della donna. Bellissima ed elegante, più volte divorziata, ha intrecciato ora una nuova relazione con un uomo molto più giovane di lei e sul punto di chiederle la mano. Porzia gli rivelerà il suo segreto o lo sposerà lasciandolo all’oscuro? Tra vestiti da sera, telefonate, mezze verità e ripensamenti, scorre il tempo di una storia piccola ma non banale, da cui oltre il gioco e l’ironia c’è anche spazio per qualche considerazione più in profondità.
Porzia era un ornamento che era stato indossato, con vari gradi di piacere e rassegnazione, da tre mariti. Con ognuno di questi tre gentiluomini si era comportata con la più grande cortesia e gentilezza, ma ognuno di loro, a suo tempo, aveva deciso che Porzia, per quanto donna bellissima e ornamento senza eguali, forse non era esattamente quanto richiesto per scopi puramente domestici.
Sarà la rilettura de La casa della gioia di Edith Wharton casualmente seguita a questi racconti di Arlen, ma non posso fare a meno di considerare la questione dell’età femminile – e andando avanti con questi racconti altre questioni che seppur in modo profondamente diverso legano le due letture – e della sua percezione sociale, anche questo esempio di un doppio standard di giudizio che il cambio di secolo non ha davvero cancellato. Porzia, sottolinea Arlen ironicamente e più volte, è un bellissimo ornamento, ma ben oltre la soglia anagrafica accettabile per il matrimonio con un uomo tanto giovane. Anche di Lily Bart, protagonista del romanzo di Wharton poc’anzi citato, l’autrice sottolinea fin da principio il ruolo che la società si aspetta da lei e il pericolo di una gioventù che la straordinaria bellezza non potrà fingere ancora a lungo. Lily, Porzia e le donne come loro (ma la signora di Arlen ha un bel patrimonio a sostenerla ed è una differenza fondamentale) sono state cresciute per questo, per essere dei meravigliosi ornamenti in società, raffinate nei modi e poco altro. Non sappiamo quanto questo sia vero nel caso di Porzia, ma la vivacità degli scambi con la cameriera lasciano intuire una certa consapevolezza e meno ingenuità di quanto si potrebbe pensare. Poco o nulla contano i sentimenti – e infatti non sono nemmeno oggetto di discussione in queste storie, non del tutto almeno – di Porzia, del potenziale nuovo fidanzato: contano le apparenze e il giudizio della società cui si appartiene. È qui che lo sguardo di Arlen si posa senza sosta, mai maligno ma attento a raccontare ciò che si nasconde dietro le facciate, dietro apparenti ritrosie e immacolate reputazioni.
Signora, noi inglesi siamo snob, ma siamo anche puritani. Riveriamo le nostre tradizioni, lisciamo gli strascichi dei nostri superiori – ma Dio gli aiuti, signora, quando portano i loro diademi ricurvi sulla pubblica piazza. (“Il diadema ricurvo”, p. 78)
Ecco, dunque, che quando la reputazione irreprensibile viene messa in dubbio, quando «i diademi ricurvi» mostrano la realtà dietro la maschera, l’equilibrio si incrina. La rispettabilità di Lady Quorn, al sicuro in «uno dei più importanti matrimoni d’Inghilterra» viene dunque messa in dubbio da un uomo che l’avvicina in St. James Street e inizia a ricattarla, minacciando di svelare le sue abitudini amorose alle spalle del marito. Ancora La casa della gioia, mi perdonerete: pure nel romanzo di Wharton c’è una donna che protetta dall’apparenza di rispettabilità data dal ruolo di moglie vive la propria vita piuttosto liberamente, laddove tutti sanno – a eccezione dell’ingenuo marito – e fanno finta di niente; essere sposata le consente una libertà di movimento e la salvaguardia delle apparenze, cosa che non è concessa a Lily Bart e sarà proprio il pettegolezzo – insieme a qualche scelta avventata – a causarne la rovina. La gentildonna di Arlen, dunque, è come le altre ben consapevole del proprio ruolo in società e della posizione privilegiata che occupa e disposta a usare ogni arma in suo possesso per mantenerli. Quello tra lei e l’uomo che vorrebbe ricattarla è un gioco raffinato e dalle svolte inattese e da questa parte della storia ci ha permesso ancora una volta di ampliare lo sguardo oltre la manciata di pagine di cui si compone.
Sulla protezione che deriva dall’essere coniugata si fonda anche il racconto L’asino d’oro, che è tanto ritratto ironico delle convenzioni matrimoniali quanto dell’incalzare delle giovani americane ricchissime protagoniste di rotocalchi, romanzi e racconti del periodo. La giovane americana qui presentata è tutt’altro che ingenua e per liberarsi dal peso di corteggiatori che mirano soltanto al suo cospicuo patrimonio e alle rigide regole cui una donna nubile deve sottostare decide di prendere in mano la situazione e proporre a un giornalista di poco conto un ben preciso accordo matrimoniale che possa soddisfarli entrambi, garantendo agio all’uno e libertà all’altra. Anche qui al lettore il gusto di scoprirne le svolte inattese. L’asino d’oro nella sua leggerezza non manca di ironia intelligente sui già citati temi che si rincorrono in questa raccolta e che, mutati, ci danno ancora modo però di ragionare sui doppi standard di giudizio, la protezione e la libertà che derivano dall’indossare la maschera che risponde perfettamente alle aspettative della società, i giochi di forza dentro le relazioni.
Leggere questi cinque racconti esemplari è gettare uno sguardo sul mondo di Arlen, quello rappresentato e quello reale, finendo per comprendere la fascinazione suscitata nei suoi contemporanei e le parole di ammirazione che lo stesso Fitzgerald gli tributò (almeno in una fase della sua vita, poi ne mise in luce più la natura commerciale dei suoi scritti e le debolezze). Silvia Lumaca cura dunque un’edizione che riporta abilmente la voce di Arlen al lettore italiano e verso la quale muovo la mia solita critica per la scarsità degli apparati critico-bibliografici necessari per presentare l’autore a un pubblico che generalmente gli è estraneo. C’è, almeno, una breve ma puntuale introduzione alla raccolta, che permette di inquadrare il contesto in cui questi racconti si muovono.
Sotto sotto sono storie di inganni, ognuna a suo modo. E ognuna lascia un buon grado di ambiguità, tanto caro a noi lettori di racconti, inarrestabili indagatori del mistero.