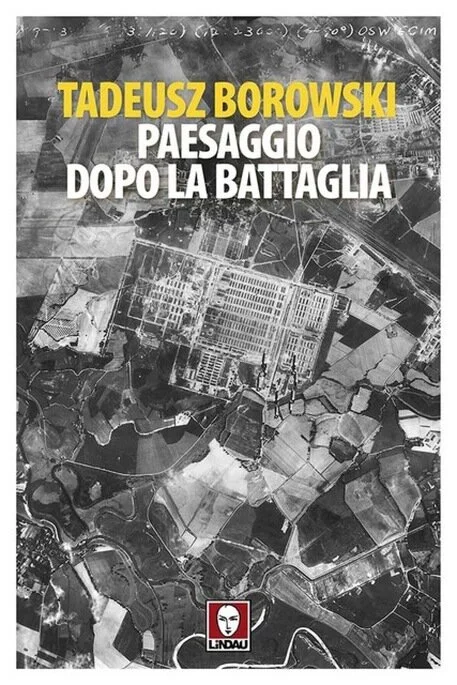Paesaggio dopo la battaglia è la raccolta con cui Tadeusz Borowski affonda il suo sguardo sui sofferenti, sui vinti, e con oggettiva spietatezza mette a nudo la crudeltà e il cinico egoismo che prevalgono nell’animo dell’uomo in lotta per la sopravvivenza. Lindau lo ha dato alle stampe, con la curatela di Roberto M. Polce, di cui vi proponiamo la postfazione per gentile concessione dell’editore.
Auschwitz come specchio del mondo
di Roberto M. Polce
Colui che cammina sulla testa vede il cielo sotto di lui come un abisso.
Paul Celan
Quando nel 1971 il critico e storico della letteratura polacco Andrzej Werner pubblicò zwyczajna Apokalipsa forse nessuno immaginava che questo libro dal titolo emblematico dedicato a Tadeusz Borowski avrebbe segnato una svolta fondamentale nella valutazione sia della produzione letteraria di questo scrittore, sia, più in generale, della più vasta produzione letteraria polacca sul tema dei campi di concentramento nazisti. Werner per primo infatti intuì non solo e non tanto l’alta qualità letteraria della narrazione di Borowski, ma soprattutto la peculiarità del suo punto di vista, l’originalità della sua visione dell’universo «concentrazionario», contrapposta a tutto il resto delle testimonianze dei sopravvissuti ai lager nazisti, per definire le quali egli introduce il concetto, decisamente sminuente, di «letteratura martirologica», vittimistica, che in nessun modo aiuta a comprendere ciò che veramente accadde in quegli anni tragici nel «cuore di tenebra» dell’Europa. Da quel momento, e sempre di più negli anni successivi, quando crescono e si moltiplicano gli apprezzamenti e gli studi dedicati alla sua opera, la letteratura polacca sui campi di concentramento è senza mezzi termini quella di Tadeusz Borowski, perché, come afferma Dariusz Kulesza, «nessuno ha detto sui campi di concentramento nulla di più utilizzando soluzioni letterarie più originali e adeguate». Al cospetto di Borowski, insiste Kulesza, «tutta la letteratura polacca sui lager è o di secondo piano, o ripetitiva». (E non solo quella polacca, aggiungeremmo noi.) E oggi ormai i racconti di Tadeusz Borowski vengono unanimemente annoverati fra i risultati più alti e pregnanti della letteratura «concentrazionaria» a livello mondiale, accanto alle opere di Primo Levi, Elie Wiesel, Jean Améry, Imre Kertész, per fare solo qualche nome. E la sua testimonianza è ancora più significativa in quanto mette a nudo, in modo dolorosamente onesto e brutalmente disincantato, il funzionamento quotidiano e i meccanismi dei lager nazisti vissuti dalla peculiare, e in generale più rara, prospettiva di un internato «ariano». Per convenzione si usa suddividere la biografia artistica di Tadeusz Borowski in tre fasi. La prima, che va dal 1942 al 1946, è caratterizzata da una produzione prevalentemente in versi. Nel corso della seconda, dal 1946 al 1948, Borowski, che pure fino ad allora aveva ritenuto sé stesso soprattutto un poeta, chiude con la poesia, scrivendo e pubblicando quasi solamente racconti. Infine, la terza fase, all’incirca dal 1949 fino al 1951, in cui, con una clamorosa autocritica, rigetta tutta la propria produzione precedente, accoglie i dettami del realismo socialista e mette la sua penna esclusivamente al servizio del partito e della propaganda politica. Con il suicidio, commesso enigmaticamente proprio in un momento in cui aveva ormai raggiunto un’invidiabile posizione di onorato e temuto apparatčik, rimise in discussione, per non dire negò, tutta la produzione ultima, vale a dire la sua pubblicistica più rozzamente agitatoria. «Borowski divorava sé stesso incessantemente». Tadeusz Borowski, nel corso della sua brevissima esistenza (nel momento in cui si tolse la vita non aveva ancora compiuto 29 anni), a più riprese aveva spiazzato gli amici e le persone a lui più vicine non meno degli avversari con le sue decisioni imprevedibili e i suoi mutamenti di rotta repentini e radicali e a prima vista del tutto incomprensibili. A Monaco di Baviera, per esempio, nel 1946, quando decise di tornare nella Polonia già attratta nel campo socialista che lo affascinava e lo spaventava a un tempo. O quando, nel febbraio 1950, pubblica l’articolo Rozmowy sulla rivista «Odrodzenie» in cui procede a un’impietosa quanto incondizionata autocritica con la quale distanzia di gran lunga anche i suoi più acerrimi e maldisposti detrattori per quanto concerne la valutazione negativa dei racconti da lui scritti in precedenza, definendoli «un’oggettiva alleanza con l’ideologia fascista». O ancora, infine, con il proprio suicidio. Per non accennare che ai fatti più vistosi. Ma di questi, l’avvenimento che ancora oggi appare maggiormente difficile da comprendere, addirittura più che il suicidio, è l’adesione senza riserve alla nuova politica culturale del partito al potere sancita dal congresso di Stettino del 1949 e il rinnegamento dei suoi «racconti del lager», questa parte sanguinante che in un sol gesto tranciò via da sé stesso. Czesław Miłosz nel suo saggio su Borowski sostiene che all’origine della sua «conversione» ci sarebbe stato un «amore deluso per l’uomo e il mondo», rovesciatosi in odio e «repulsione per l’uomo in quanto essere fisiologico determinato dalle leggi della natura e della società», odio che sarebbe stato infine manipolato e convogliato dal partito nella direzione desiderata. Sempre secondo Miłosz, per Borowski, che aveva visto «nei campi di concentramento i filosofi venire alle mani per qualche avanzo trovato fra i rifiuti», «il pensiero umano non aveva significato. […] Ciò che contava davvero era solo il movimento della materia. Beta [Borowski, N.d.R.] assorbiva il materialismo dialettico come una spugna l’acqua». Miłosz azzarda perfino un collegamento fra il percorso di Borowski e l’iter presunto che poteva aver condotto altri ad aderire al nazismo: Il tedesco che aveva rinchiuso Beta in un campo di concentramento forse un tempo aveva anche lui nutrito un amore deluso per il mondo, prima che la propaganda del partito ne facesse una bestia. Aspirava all’ordine e alla purezza, alla disciplina e alla fede. […] Anche Beta nei suoi articoli vedeva a portata di mano un ordine nuovo e migliore. Credeva nella salvezza terrena e la desiderava. Provava odio per i nemici, colpevoli di ostacolare la felicità dell’umanità. Gridava che bisognava distruggerli. […] Il grande talento e la superiore intelligenza di Beta non bastavano a far sì che prendesse coscienza dei pericoli che nasconde l’esaltazione della marcia.
Questa analisi, anche se non priva di una sua forza di suggestione e in generale di una parte di verità, se riferita a Borowski tuttavia a tratti lascia anche un po’ perplessi. Sono ancora troppo scarsamente studiati i materiali privati dello scrittore di quel periodo (appunti, lettere) che potrebbero gettare un po’ più di luce sulle ragioni profonde della sua scelta – se di vera scelta si trattò – nonché sul suo grado di consapevolezza circa quanto stava effettivamente avvenendo intorno a lui. Molti altri intellettuali di rispettabilissima intelligenza, e ai quali non sempre si poteva imputare sprovvedutezza o malafede, abbracciarono a quell’epoca in Polonia il marxismo dogmatico con fervore e nel pieno delle proprie facoltà mentali, vedendovi un’autentica promessa di riscatto per l’umanità. Inoltre, che in Borowski rapidamente si facesse strada il forte sospetto, quando non già la certezza, che anche entro quella diversa cornice il mondo stesse cominciando a farsi «di pietra», lo dimostra in modo inoppugnabile un racconto pubblicato nel giugno 1950, in cui pur se in uno stile ormai pesantemente socialrealista – denuncia l’innato spirito rapace dell’uomo che anche nell’ambito della nuova struttura fa bellamente carriera camuffandosi sotto spoglie politiche. Il suo stesso suicidio, del resto, costituirebbe la prova più inconfutabile di questa coscienza giunta in lui ormai come a maturazione, gesto peraltro preceduto, secondo alcune testimonianze, da discorsi «strani» e«confusi» fatti negli ultimi mesi prima della morte. Può essere invece molto verosimile che «nell’esaltazione della marcia» trovasse, o quantomeno cercasse, una sorta di stordimento, di oblio, e che scrivere quei violenti e sovreccitati articoli di propaganda, come suggerisce ancora Miłosz, agisse su di lui come un narcotico. Su un particolare infatti concordano più o meno tutti: e cioè sul fatto che Borowski fosse animato da un bisogno ardente di credere, da un desiderio feroce di lasciarsi trascinare via da una fede cieca e assoluta nel cui vortice frastornarsi e dimenticare.
Molto è stato scritto sulla cosiddetta «sindrome del sopravvissuto al campo di concentramento», sull’impossibilità di dimenticare quella massima degradazione dell’essere umano di cui si è stati spettatori e attori, sull’impossibilità di recuperare una piena fiducia nell’uomo e nell’umanità, e sul senso di colpa che accompagnerà per sempre, fedele come un’ombra, il sopravvissuto. Borowski nemmeno ne era rimasto immune. Era tormentato angosciosamente da ciò che aveva vissuto, da ciò che aveva visto. Provava quel senso di colpa «assurdo, incomprensibile» di cui è piena tutta la letteratura su questo argomento: il senso di colpa per il semplice fatto di essere scampato. Lo perseguitava quella domanda senza risposta di cui parla Bettelheim: «Perché, fra milioni, proprio io mi sono salvato?». Le immagini del campo straripano dalla memoria e si sovrappongono ossessivamente alla nuova realtà. Passeggiando per le strade di Monaco dopo la liberazione, capita che scorga fra la folla qualcuno dei vecchi «colleghi» del lager, che riconosca scarpe, vestiti, gioielli provenienti da là, oggetti un tempo appartenuti a coloro che andavano alle camere a gas. In una poesia, i bambini, registra uno di quegli improvvisi, involontari pensieri sfuggiti al controllo di un cervello i cui tessuti quell’esperienza-limite doveva aver smagliato forse per sempre e irrimediabilmente: «Me ne vado per la città / e fisso i bambini, / pupettini rosatini – / chissà, a tirarli fuori dalla carrozzina / ruotarli per un piedino / e sfracellarli contro il marciapiede, / scrocchierebbero o non scrocchierebbero?». Tornano i morti: «Cammini con me, escresci in me, / mi ti configgi nel sangue. / Come attraverso un vetro nell’oscurità vedo / il tuo viso dall’oltremondo». E nella Preghiera di dimenticare implora: «Dio Vendicatore degli Assassinati, fai la grazia / di Dimenticare morti e vivi…». Grazia che però su Borowski non discese mai. Non si può nemmeno escludere che un ruolo rilevante, nella sua decisione di rigettare tutto quanto aveva scritto fino a quel momento e di abbracciare con fervore e zelo il nuovo corso, fosse stato giocato sotterraneamente anche dalla tensione generata in lui dalla pressione sociale che, col passare dei mesi, si era andata facendo sempre più gravosa. Già nei primi due anni dopo il suo rientro in patria – anni pur ancora di notevole libertà e pluralismo culturale, caotici ed effervescenti, euforici e appassionati – l’apparire dei suoi racconti veniva accolto quasi di regola da salve di violente e infiammate critiche. Nel migliore dei casi, le riviste li pubblicavano facendoli precedere da una nota in cui prendevano le distanze dai loro contenuti, pur lodandone eccellenza letteraria e originalità di prospettiva e d’espressione, come fece «Twórczość» nell’aprile del 1946. Le accuse, provenienti all’inizio soprattutto dall’area cattolica, vennero per un certo tempo controbilanciate da prese di posizione a favore, o se non altro più possibiliste, meno categoriche, da parte di intellettuali dell’area di sinistra.
È nel 1947 che l’«affaire Borowski» si surriscalda assumendo le proporzioni e l’aspetto di un vero e proprio scandalo. Ad accendere la miccia fu, paradossalmente, Borowski stesso. Nel gennaio di quell’anno pubblica su «Odrodzenie» una recensione (intitolata Alice nel paese delle meraviglie) a un libro di memorie del lager fresco di stampa, in cui confessa di avercela, e molto, con l’autrice non tanto «per essere sopravvissuta al lager» in modo eticamente non irreprensibile, quanto per non aver avuto proprio lei è sopravvissuto(a)? […] Nulla da eccepire – raccontate finalmente come vi siete acquistati il posto in ospedale o in un buon kommando, come avete sospinto al camino i «musulmani», come compravate donne e uomini, cosa facevate negli unterkunft, nei Canada, nei krankenbau, nel campo zingaro, raccontate questo e ancora molti altri particolari, raccontate la vita quotidiana al campo, il modo di «rimediare», la gerarchia del terrore, la solitudine di ognuno. Ma scrivete che proprio voi lo facevate. Che una particella della lugubre fama di Auschwitz la si deve anche a voi. O forse no?
Si scatena l’inferno. Borowski viene accusato di cinismo, di falso, e di essere nemico di tutti i valori, di quelli cristiani non meno che di quelli sorti dalla resistenza e dall’insurrezione. Ma ci si spinge ben oltre, rovesciando i dati della questione. Si identifica Borowski con la propria opera, interpretando alla lettera la sua narrazione in prima persona, e lo si incolpa di aver compiuto egli stesso tutto ciò che aveva descritto, si minaccia addirittura di trascinarlo davanti a un tribunale che giudichi i presunti crimini da lui commessi ad Auschwitz. Viene senza complimenti messo nel novero delle «iene del lager» e si conclude dicendo che gli altri «suoi simili» avevano se non altro avuto il buonsenso e la decenza di non scrivere memorie. Credo sia sufficiente pensare come ancora a distanza di decenni azzardarsi a mettere in dubbio tutta la retorica martirologica possa nuovamente sollevare ondate di indignazione per immaginare cosa dovesse significare allora, in una Polonia dove non esisteva quasi famiglia non visitata dalla morte in una forma o nell’altra, proclamare una verità così poco edificante come andava facendo Borowski. Il quale non solo non si univa al coro unanime di condanna della bestialità hitleriana e di autocommiserazione, ma osava sostenere e mostrare che «il male non era appannaggio solo degli aguzzini» né l’antisemitismo era prerogativa solamente nazista, e d’altro canto che molti ebrei pur di sopravvivere non avevano esitato a mandare al gas altri ebrei, e finanche i propri familiari, e insomma a farla breve, che fra i prigionieri, più che le leggi della solidarietà e della compassione, vigevano le regole ferree di una spietata e sorda lotta per l’esistenza. Il dramma reale del lager per Borowski non consisteva tanto nelle privazioni, nella fame, nella tortura, e neppure nella morte – l’autentica tragedia non si svolgeva fra gli spietati aguzzini e le deboli vittime indifese, ma riguardava unicamente queste ultime. Borowski si rendeva perfettamente conto che in quel mondo, per lo schiavo, non c’era possibilità di una scelta dignitosa: l’unica alternativa era fra una morte ignominiosa e una non meno ignominiosa sopravvivenza entro quel sistema criminale, arrendendosi alle sue regole e prosperandovi. Non c’era un modo moralmente ineccepibile di sopravvivere. E perciò chiunque fosse sopravvissuto al campo «non poteva non esserne rimasto lordato. Già solo per il fatto che si era visto, che si era stati testimoni, si era colpevoli!». Mentre quasi tutta la letteratura del lager si fissava su pochi martiri ed eroi, e su un olocausto di vittime sacrificali, di agnelli immacolati e incolpevoli, Borowski più che sulle eccezioni si soffermava a descrivere la grande massa degli internati, gli «internati-medi», da cui quella «situazione estrema» scrostava via impietosamente ogni patina (quanto inauditamente sottile e caduca!) di umanità. E questo è soprattutto ciò di cui non riusciva a finire di stupirsi: a questo dunque poteva ridursi un uomo… ammesso che quel miserabile ammasso di sorda materia che tendeva con tutte le sue energie unicamente e ferocemente ad autoconservarsi potesse ancora avere il diritto di fregiarsi della denominazione di uomo. Per lui la goccia di colpa di cui si erano macchiate le vittime era molto più grave del mare di colpa degli aguzzini, e il proprio odio si rivolgeva con uguale intensità verso quelle non meno che verso questi. Tutti erano responsabili per Auschwitz, chi c’era e chi non c’era, chi sapeva e chi non sapeva, gli assassini e gli assassinati. Egli la sua parte di colpa se l’era accollata e altrettanto esigeva dagli altri. «Non è lecito parlare di Auschwitz in termini impersonali…». Di qui passava il profondo solco che separava i suoi racconti dal resto della letteratura sui campi di concentramento. Il mondo intero assolveva in pieno sé stesso in quanto vittima innocente o in quanto ignaro – Borowski non assolveva nessuno: tutta l’umanità senza eccezioni era responsabile per Auschwitz, dopo Auschwitz tutta l’umanità aveva perduto per sempre la propria innocenza. Tutto ciò era difficile da digerire, non si poteva tollerare un Borowski che lacerava i veli pietosi sollecitamente stesi sulla coscienza collettiva. Ma lui non accennava a demordere, o almeno non ancora. Alla fine del 1947 uscirono in volume, con il titolo di Pożegnanie z Marią (Addio a Maria) alcuni racconti in precedenza apparsi su riviste, fra i quali quello che dava il titolo alla raccolta, inedito prima di allora, costituiva un’ulteriore novità. Questo racconto era stato per Borowski forse il più difficile da scrivere, quello che gli era costato più fatica. Doveva essere il racconto di apertura del ciclo, quello in cui descriveva il «paesaggio prima della battaglia», la vita in una Varsavia già infernale e tuttavia ancora ignara del vero fondo dell’abisso. Una vita che, nonostante tutto, continua a svolgersi in modo relativamente normale e a momenti perfino con leggerezza, ma in cui già colano e si rimescolano i toni cupi, lividi, violacei di un cielo prima di una tempesta che si vada addensando proprio sul calar delle tenebre. Tutto vi è incerto, sospeso, disperso, e come privo di consistenza e di realtà. È come se Borowski avesse voluto andare a ricercare là, in un’epoca per lui tutto sommato ancora «spensierata» e in qualche modo perfino «felice», i fili che univano quel mondo – il mondo «di fuori», il mondo «di prima» – al mondo del lager. Fili che il suo io di allora doveva a malapena scorgere, o forse solo nebulosamente avvertire, senza afferrarne appieno tutto il senso e la portata che gli si chiariranno veramente solo in seguito. (Ma che ne avesse percezione, per quanto confusamente, è indubbio: Borowski non rilegge semplicemente quel passato col senno di poi, sovrapponendovi un suo sapere «concentrazionario» tutto acquisito posteriormente: la sua raccolta di poesie del 1942, Gdziekolwiek ziemia…, gronda di presagi, di intuizioni, di immagini che nel lager non faranno altro che assumere consistenza, rafforzarsi, definirsi meglio). Anche la scrittura del racconto riflette quello stato di incertezza e di sospensione: le parole vi si impaludano, si rarefanno o si raggrumano eccessivamente, rimanendo sempre come un po’ scollate dagli oggetti, o soffocandoli – quasi non riuscissero ad afferrare e delineare con precisione una realtà che all’occhio dell’io narrante fatica ancora ad acquistare una forma e un significato compiuti. Addio a Maria anche per altri motivi, potrà risultare, di tutti, forse il racconto più ostico al lettore, tanto più se straniero. Basti il fatto che Borowski dovette difenderlo persino dalle incomprensioni dei critici patrii: «A Wyka non piace la lingua insopportabilmente distratta del racconto (credo nella parte iniziale) […] Ho voluto scrivere una novella nella lingua della poesia cospirativa e alla sua luce mostrare la realtà della cospirazione». A ogni modo, difficoltoso o no, Addio a Maria segna il tracimare della concezione «concentrazionaria» di Borowski fuori del campo di concentramento, nel mondo pre- e post-Auschwitz. Infatti, contemporaneamente va pubblicando le «short stories» che costituiranno il volumetto Kamienny świat (Il mondo di pietra), l’ultimo atto della sua «prosa del lager». Con questi ventuno brevissimi racconti, ognuno in sé perfetto e conchiuso, benché vadano considerati secondo l’autore come altrettanti capitoli di un’unica grande novella, Borowski calca maggiormente la mano, come a voler far intendere che quanto aveva fino ad allora rivelato della verità del campo erano ancora bazzecole in confronto a ciò che aveva visto e taciuto. Ma Kamienny świat (Il mondo di pietra) è anche una riflessione dolorosa su sé stesso e sul mondo che dopo Auschwitz «ritorna alla vita», sulle proprie ossessioni e sull’impossibilità di dimenticare ormai non più semplicemente ciò di cui laggiù è stato testimone, ma soprattutto ciò che di Auschwitz ha capito. Vede Auschwitz riversarsi e dilagare nel mondo, scorge i primi accenni di ciò che Améry chiamerà «il trionfo postumo di Hitler», vede in modo sempre più chiaro le connessioni, gli elementi di continuità fra Auschwitz e la realtà fuori del lager, che gli apparirà sempre più inequivocabilmente come un «universo concentrazionario». Kamienny świat uscì alla fine del 1948, ma ormai il clima politico si andava già facendo soffocante. Quella parte della critica di sinistra che lo aveva appoggiato e difeso dall’attacco dei cattolici, ora non lo sostiene più e, nel migliore dei casi, tace o lo ignora: un po’ per paura, un po’ perché se ne ha abbastanza di rivangare il passato e riesumare i morti, un po’ perché si è presi dalla febbre della ricostruzione e si ha voglia di dimenticare i «tempi del disprezzo» quanto più in fretta possibile. Borowski stesso del resto attraversa in quei mesi crisi profonde e dilanianti lacerazioni. Il bisogno di liberarsi di quel peso insostenibile della memoria si fa anche in lui sempre più urgente, diventa conditio sine qua non per la propria pura e semplice sopravvivenza fisiologica. Quando vi giunse Tadeusz Borowski, nel campo di concentramento di Auschwitz era già in atto un’inversione di tendenza: da poche settimane si era cessato di mandare al gas gli ariani, ritenuti ormai sempre più indispensabili per il lavoro di ricostruzione di una Germania sempre più frequentemente devastata dalle incursioni aeree degli alleati. Auschwitz, fondata nel 1940 alla confluenza fra la Soła e la Vistola, ampliata nel 1942 con Birkenau (Auschwitz II) e ancora più tardi con altri campi satellite (Auschwitz III), era ormai una «città» che contava allora una popolazione di oltre centomila abitanti «stabili». Di Borowski, nei due anni che vi restò rinchiuso, si sa molto poco. Arrivato un giovedì notte, il lunedì lavorava già in un Aussenkommando (cioè un Kommando di lavoro esterno al campo) a Budy, a 7 km dal lager, a trasportare pali del telegrafo, e non molto tempo dopo era ad Harmenze a scavare fossati. Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno del 1943 finì, ridotto presumibilmente a un «musulmano», nell’ospedale del campo, dove, preso in simpatia, venne aiutato e curato: il capoblocco se ne lasciò commuovere al punto da assumervelo come guardiano notturno. Si rimette in forze. Poi, dopo un sommario addestramento sanitario nel marzo 1944, ricoprirà la funzione di Pfleger (infermiere): solo allora riesce, tramite un giornalista sportivo tedesco internato per reati comuni, un tale Kurt, ad allacciare contatti epistolari con la sua fidanzata Maria, anche lei internata ad Auschwitz. Sempre grazie a Kurt riesce perfino a incontrarsi con lei nell’FKL, il campo femminile, dove si recava con un Kommando addetto al prelievo dei cadaveri dei neonati. Maria è in condizioni miserevoli, lui l’aiuta come può facendole pervenire cibo e medicinali. In questi ultimi mesi la vita al campo per Borowski non è più così drammatica: nell’ospedale ha cibo in abbondanza e più o meno libero accesso ai prodotti farmaceutici, riceve pacchi di viveri da casa con una certa regolarità, può perfino scrivere, lettere soprattutto, ma anche versi che girano per tutta Auschwitz (e dei quali si salverà poco o nulla). Il periodo più drammatico fu tra il maggio e il giugno del 1944, quando i nazisti danno il via all’«Operazione Höss», nel corso della quale si mandano al gas oltre 400.000 ebrei ungheresi: arrivano trasporti in continuazione (fra cui il famoso trasporto «Będzin-Sosnowiec»), i crematori ardono senza sosta, e per un giorno Borowski si ritrova nel cuore dell’inferno, allo scalo ferroviario, fra i membri di un Kommando, il cosiddetto «Canada». Intanto il fronte russo si avvicina. Borowski rinuncia alla funzione di Pfleger e si arruola nel Kommando dei Dachdecker (riparatori di tetti) che lavora all’FKL, in modo da potersi incontrare con Maria ogni giorno. Il 12 agosto la vedrà per l’ultima volta ad Auschwitz. C’è l’evacuazione. Parte con un trasporto diretto in Germania, dove verrà sballottato da un campo all’altro ancora per diversi mesi prima della liberazione a opera degli americani, che lo terranno «in quarantena» insieme a molti altri internati soprattutto polacchi, per ulteriori cinque mesi in un campo per displaced persons presso Monaco di Baviera. «Sono passati infine tre anni da quando uscii di casa. Sarei dovuto tornare per pranzo. Eh già!», scrive alla madre alla fine del 1945. Nonostante le insinuazioni e le accuse che gli verranno mosse più tardi, dalle testimonianze degli internati sopravvissuti risulterebbe che Borowski si comportasse nel campo in modo tutt’altro che immorale e cinico. Perché allora, nei suoi racconti, si sarebbe caricato anche di quanto non aveva commesso? È estremamente illuminante in questo senso il brano della sua recensione al libro della Kossak-Szczucka citato sopra. A nessuno che semplicemente vi fosse stato e fosse sopravvissuto, era lecito ritenersi immacolato, indipendentemente da ciò che aveva o non aveva commesso. A Monaco, mentre stava terminando di lavorare al libro collettivo Byliśmy w Oświęcimiu (Eravamo ad Auschwitz), confessava all’amica Zofia Świdwińska di aver scritto quei racconti per mostrare «la vita quotidiana del campo e strappare via dall’uomo il cosiddetto martirio, e infine – per mostrare che il male non era appannaggio solo di una parte. Il libro […] è molto crudo e pieno di stridii […], contrariamente alla moda in esso non ci sono quasi SS né troppo filo spinato nella notte». L’io narrante è il vorarbeiter Tadek: Tadek è il diminutivo di Tadeusz, mentre vorarbeiter vuol dire caposquadra, capolavorante. Perciò, il vorarbeiter Tadek è un ariano e un privilegiato del campo, un cosiddetto «prominente». Il campo di concentramento dunque è visto con gli occhi di un ariano che ricopre varie «funzioni» che gli permettono di «organizzare», o di «rimediare», cioè di procurarsi, più o meno illecitamente, ciò di cui ha bisogno per poter resistere più a lungo e di conseguenza nutrire maggiori speranze di sopravvivenza. «Organizzare» o «rimediare» spesso vuol dire commerciare con altri prigionieri le loro razioni di cibo, contribuendo così a che i meno previdenti e i meno abili deperiscano sempre di più scivolando così progressivamente e inesorabilmente verso la condizione di «musulmani», che preludeva quasi sempre alla camera a gas. Il vorarbeiter Tadek, perciò, pur non macchiandosi di delitti particolarmente nefandi, contribuisce indirettamente a che altri internati, i più deboli, diventino sempre più deboli e soccombano. Borowski, tralasciando, come si diceva, i casi sporadici dei martiri e degli eroi, troppo poco rilevanti dal punto di vista numerico per poter incidere sulla sostanza di quella «società concentrazionaria», preferisce appuntare la sua attenzione sull’internato medio che cerca di adattarsi a quella situazione estrema, con il puro e semplice intento di sopravvivere a ogni costo e con ogni mezzo. L’internato medio ha la sua parte di colpa unicamente per essersi lasciato prendere e inserire in quel meccanismo, in quel sistema criminale e immorale. L’osservazione lucida e distaccata di questo povero essere umano – che, posto in una situazione estrema, si degrada a tal punto da perdere in un sol colpo tutto ciò di cui era andato così fiero per secoli, civilizzazione, buoni sentimenti, gusto estetico – lo porta inevitabilmente a interrogarsi più in profondità e a spingersi più lontano nelle connessioni, a guardare sotto i monumenti della cultura umanistica occidentale, sotto le piramidi e le strade romane, dietro le disquisizioni sul bello dei filosofi greci, e ovunque, dietro e sotto l’intero percorso della civiltà occidentale, gli pare di vedere i medesimi principi che governano il campo di concentramento, nei cui ingranaggi egli stesso si trova ora inserito. E questo forse è il più importante elemento di novità dell’opera di Borowski rispetto ad altre analoghe. Mentre gli altri vedevano in Auschwitz una prova tremenda cui Dio aveva voluto sottoporre l’uomo, oppure l’eccesso di menti degenerate, malate o impazzite – vale a dire un intervento extraumano o un elemento estraneo alla tradizione umanistica europea che inspiegabilmente e perversamente si era impossessato di uno dei suoi popoli – Borowski vi scorge invece una componente costitutiva, connaturata nell’anima occidentale, in tale circostanza eccezionale semplicemente venuta allo scoperto nella sua forma più «pura» e portata alle sue estreme conseguenze (in uno dei suoi appunti, lo scrittore definì il fascismo come «il trasferimento dei metodi coloniali all’Europa»). Borowski è un attento osservatore non soltanto delle dinamiche dei singoli ingranaggi e del cadere delle maschere dell’uomo civilizzato e del suo trasformarsi in uomo «lagerizzato», cioè adattatosi a quella struttura e a quelle leggi, ma anche della più generale «economia» dell’edificio nella sua interezza, delle motivazioni economiche tout court che lo animano, e tutto ciò che individua (e dissemina nei racconti) riconferma di nuovo che nessuna follia vi era dietro tutto questo, ma una logica ben precisa, un disegno che, se folle era, lo era per troppa lucidità e razionalità. Quando uscirà dal lager, come si è già accennato, Borowski non riuscirà più a liberarsi di questa visione, e tutto il mondo, prima e dopo Auschwitz, gli apparirà informato da quelle stesse leggi profonde. Per lui il velo illusorio della māyā, steso sopra i raccapriccianti e atroci principi dell’universo, si era ormai irrimediabilmente squarciato. Ciò che avrebbe dovuto rimanere celato, perché fosse possibile continuare a credere nelle apparenze e perciò a vivere, gli si era rivelato in modo irreparabile e definitivo. «Non sarò più lo stesso di prima» scriveva con parole semplici alla famiglia da Monaco nel 1946. Ma neanche il mondo sarà più lo stesso dopo Auschwitz, perché Auschwitz, come uno specchio, ha rivelato al mondo la propria vera, più profonda natura.
Certo, l’angolatura inconsueta da cui Borowski guarda il campo, le terribili verità intuite e rivelate, il fatto di essere stato forse l’unico ariano ad aver ammesso di aver occupato nel lager una posizione privilegiata con tutto ciò che ne conseguiva, l’aver mostrato l’uomo scrostato della propria umanità, l’aver osato accusare le vittime di essere state colpevoli non meno degli aguzzini, e, in generale, il non aver passato sotto silenzio nulla, tutto ciò garantirebbe a questi racconti al massimo una posizione di attendibile, veritiera e insolita testimonianza e nulla più. Ma essi costituiscono anche un altro risultato artistico. Borowski sa miscelare sapientemente le tonalità più diverse, escludendo tuttavia risolutamente dalla propria tavolozza la retorica in tutte le sue forme, l’urlo, il lamento, il pianto. Adotta una tecnica quasi behaviorista, elimina del tutto la psicologia, le motivazioni morali, le intenzioni e di conseguenza ogni forma letteraria – come il monologo interiore, per esempio – che avrebbe potuto dare loro sfogo. Il mondo che deve rappresentare è qualcosa di inaudito, di mai visto prima, e nessun concetto preesistente sarebbe in grado di renderlo adeguatamente. Categorie conoscitive già date rischierebbero anzi di inquinarlo, di travisarne il senso, di ricacciarlo nell’inesplicabile o di relegarlo nel convenzionale: che è quanto effettivamente accade con la maggior parte della letteratura del lager. Borowski storna da sé ogni tentazione di commento, di intervento: di sé, in sé, fa tabula rasa, e registra tutto con occhi ben spalancati, sì, ma tuttavia impassibili, imperturbabili. Abbassa tutto di molti toni, attenua, smorza – si rende conto che perfino l’urlo è privo d’efficacia di fronte a tanto orrore, senza contare che, come dice Bettelheim: «Due o tre grida ci angosciano e ci risvegliano l’impulso di correre in aiuto. Grida che si protraggono per ore ci lasciano solo il desiderio che chi grida la smetta una buona volta». Questo urlo protratto è proprio ciò che, ahimè, rende insopportabile la quasi totalità della letteratura sui campi di concentramento. Invece Borowski, col suo tono pacato, a volte ironico, a volte perfino scherzoso, ci fa entrare con dolcezza in questo mondo terrificante, impercettibilmente e proditoriamente ce lo rende familiare. Ci ritroviamo anche noi assuefatti e «lagerizzati», anche noi a pensare secondo la mentalità degli integrati del lager, e, alla fine, forse, perfino un po’ colpevoli.
Mentre procedeva il lavoro di traduzione immaginavo, anzi registravo a più riprese, le possibili reazioni di molti: ancora un altro libro su Auschwitz!? Già, perché? Perché – al di là del valore letterario e dell’inconsueto particolarissimo sguardo gettatovi da Borowski, il quale ci presenta quel mondo che ormai ci sembrava risaputo fino alla nausea come se non ne avessimo mai sentito niente prima – proporre un ulteriore libro su Auschwitz? Günter Grass, a un forum evangelico tenutosi a Berlino Ovest nel 1970, in un intervento dal titolo Come parlare di Auschwitz ai bambini, disse:
I nostri calendari dopo quegli anni non ricominciarono propriamente da zero, ma un qualcosa sul genere di una nuova era si è impresso nella mente di ciascuno di noi, a dire il vero di rado con la partecipazione di una piena coscienza, ma inconsciamente senza ombra di dubbio. Dopo Auschwitz l’uomo intende sé stesso diversamente. Auschwitz lo costringe in generale a ragionare diversamente, ogni qual volta il modello di Auschwitz si ripete da qualche parte, si deve pensare a esso unitamente alla pietra di paragone dell’originale. […] Ritengo che Auschwitz debba essere inteso come passato storico, che debba essere riconosciuto nel presente e che non sia lecito escluderlo ciecamente dall’orizzonte futuro. Auschwitz non è solo dietro di noi.