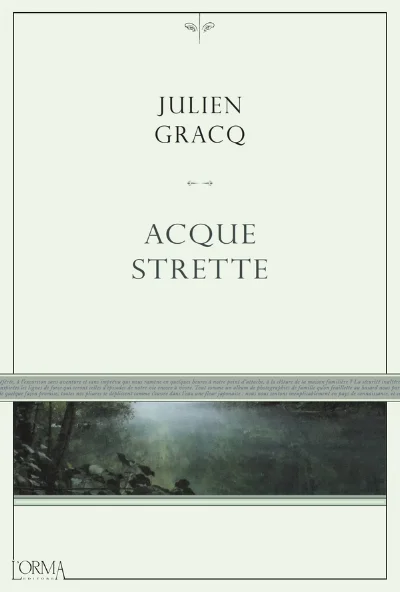Julien Gracq
L’Orma Editore
Traduzione di Lorenzo Flabbi
pp. 80 Euro 13
In libreria, il piccolo gioiello di Julien Gracq pubblicato da L’Orma Editore, Acque strette. Né romanzo, né racconto, ma una fantasticheria che accompagna il lettore lungo una narrazione densa di fascino.
La vicenda narrata in questo libro è semplice: un’escursione in barca sull’Èvre, piccolo fiume che si getta nella Loira. Paesaggi, campi, scogliere, boschi, ginestre accompagnano un tragitto familiare, ripetuto nelle diverse stagioni della vita, che qui trascende in viaggio iniziatico nel cuore stesso della creazione letteraria.
E a pelo d’acqua si attiva la memoria, si accendono fantasticherie associative che collegano in un’unica costellazione i diversi astri del personale firmamento artistico di Gracq: il profilo di un castello sulla riva richiama alcuni versi di Nerval, e su quelli si innerva l’immaginario poetico di Rimbaud, e poi Balzac, Poe, Valéry, Wagner e molti altri in un magistrale mescolarsi di ricordo e percezione, esperienza e chimere.
Sono pagine esigenti, che subito ripagano con l’ineffabile bellezza di un tramonto dopo un giorno di pioggia, di un odore terroso, di un vento d’aprile. La prosa vi scorre sinuosa, ora limpida ora più torbida, sempre incantatoria come le acque dell’amato Èvre. Forse mai quanto in questa densissima rêverie il grande scrittore francese si è rivelato così compattamente pervaso dalla sua caratteristica ispirazione, tanto umile quanto ambiziosa, in grado di fermare il tempo con la limpida forza dello stile.
Cattedrale pubblica un estratto del testo, per gentile concessione dell’editore.
*
Per quale motivo si è presto radicata in me la sensazione che, se soltanto il viaggio – il viaggio che non preveda l’idea di un ritorno – è in grado di aprirci le porte e cambiarci davvero l’esistenza, un altro tipo di sortilegio, più nascosto, come originato da una bacchetta magica, si leghi invece alla passeggiata prediletta fra tutte, all’escursione senza avventure né imprevisti che dopo poche ore ci riconduce all’attracco da cui partimmo, alla cinta familiare di casa? L’inalterabile certezza del ritorno non è garantita a chi s’arrischia tra i campi di forze che la Terra conserva in tensione per ciascuno di noi; c’è da credere che da essi, più ancora che dal «saluto dei pianeti» caro a Goethe, la nostra linea della vita risulti confusamente illuminata. A volte si direbbe che una griglia dentro di noi, di noi più antica, ma lacunosa e come bucata, decifri nell’alea di queste ispirate escursioni le linee di forza di esperienze ancora da viversi. Proprio come un album di fotografe di famiglia che si sfoglia senza un ordine preciso ci parla del nostro passato – ma di un passato orbato dei suoi vivi avvenimenti e al contempo indicibilmente personale, che ci comunichi tuttavia il sentimento vitale del contatto con lo stelo madre e la tonalità squisita, e ancora debolmente sorridente, propria di ciò che è ormai sforito –, così tali luoghi sollevano enigmaticamente un velo sul futuro: offrono un anticipo, un’anteprima, dei colori che assumerà la nostra vita; al contatto con questa terra che ci è stata in qualche maniera promessa, ogni nostra piega si distende come si dischiude nell’acqua un fore giapponese: inspiegabilmente ci sentiamo in un territorio di conoscenza, come circondati da volti di una famiglia di là da venire.
È così che la valle dormiente dell’Èvre, fumiciattolo sconosciuto che sfocia nella Loira a un chilometro e mezzo da SaintFlorent, recinge nel paesaggio della mia giovinezza un cantuccio privilegiato, più sontuosamente e segretamente colorato degli altri, una riserva chiusa che resta legata per nascita e statuto alle sole idee di passeggiata, di svago, di festa agreste. Ciò che lo rendeva per me tanto speciale, mi pare, era soprattutto il fatto che, come di alcuni fumi leggendari dell’antica Africa, dell’Èvre non si potessero visitare né la fonte né la foce. Sul versante della Loira, la risalita era ostacolata da una diga sommersa, composta di ciottoli grezzi sparsi alla rinfusa, che riaforava durante le secche estive permettendo di raggiungere l’Île aux Bergères; poco più in là, aggrovigliate cataste di frassini, pioppi e salici si allungavano in un intrico di rami che scoraggiava l’esplorazione a valle. Cinque o sei chilometri più a monte, la diga del mulino di Coulènes impediva alle barche di procedere oltre. Andare sull’Èvre implicava così un cerimoniale piuttosto impegnativo che bisognava pianifcare con un paio di giorni d’anticipo: il tempo di avvisare la titolare di un bar di Le Marillais afnché ci tenesse da parte l’unico scalcinato burchiello centenario, un barchino traballante, tarlato, scatramato, a volte anche privo di timone, che lei conservava vicino alla diga, debitamente legato con un catenaccio, per ofrirlo in prestito agli avventori del cafè. Le aste dei remi spaiati scorrevano in nodosi viluppi di giunchi con funzione di scalmi. Nel mio ricordo, i preparativi per il disormeggio restano inscindibili dall’acre, bruciante arsura della limonata tiepida: me la ritrovo intatta sulla lingua quando rileggo il racconto del picnic sulle rive dello Cher, nel Grande Meaulnes. In quelle pagine, come a Le Marillais, mi esplode contro il palato un indefnibile gusto esotico e perduto, di giovedì scampananti, di festività modeste.