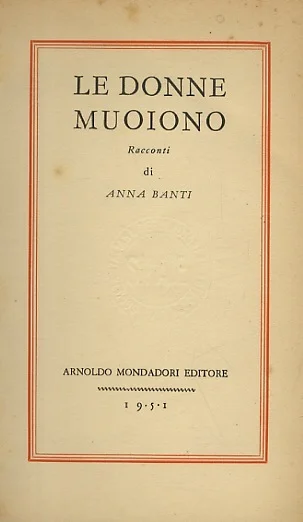Questo articolo è comparso nella rubrica Il Racconto dei racconti, in collaborazione con Minima&Moralia
Anna Banti
Lavinia Fuggita
di Rossella Milone
Ho letto questo racconto di Anna Banti, per la prima volta, moltissimi anni fa. Si chiama Lavinia fuggita, ed era inserito nella raccolta di racconti Le donne muoiono pubblicata nel 1951 da Mondadori (riedito da Giunti nel 1998), che le valse il Premio Viareggio nel 1952.
Secondo Emilio Cecchi, questo è il componimento in cui si ha «la piena, splendida misura del talento della Banti»; mentre per Cesare Garboli era addirittura il racconto più bello di tutto il Novecento. Comunque, per quanto possano tornare utili le affermazioni assolutistiche e definitive dei critici letterari, in effetti questo tra i racconti – ma direi tra l’intera opera della Banti – è il più significativo, complesso, riuscito della produzione della scrittrice fiorentina, tanto è vero che è anche il più noto. In una parola, questo racconto è semplicemente bello.
Poiché ho letto e leggo moltissimi racconti, e di racconti semplicemente belli per fortuna ne esistono moltissimi, mi sono chiesta da dove derivasse questa bellezza propriamente bantiana; cosa generasse in me lettore una specie di incantamento; come mai mi regalasse una piena sensazione di appagamento come solo una sorsata d’acqua dopo una corsa può fare.
Allora ho cominciato a compiere un percorso a ritroso nel mio rapporto con questo racconto – con Lavinia – e nella mia memoria mi è apparsa chiara subito una cosa: che questo era un testo diverso ogni volta che tornavo a rileggerlo. Che Lavinia, e tutta la vicenda in cui si trova coinvolta, mi raccontavano sempre una storia differente e ogni volta sempre più articolata, pur rimanendo la stessa storia sempre, fissata sin da quando la Banti ha messo mano alla penna.
La storia racconta di Lavinia che, come molte altre orfane, agli inizi del Settecento, viene raccolta dall’Istituto della Pietà di Venezia, in cui le giovani imparano a suonare e a cantare. Lavinia, infatti, è maestra di coro ma a differenza delle sue amiche Orsola e Zanetta, è scossa da un’irresistibile istinto per la composizione, spinta da una scellerata, invincibile, quasi dolorosa forza creatrice che la porta a sostituire le partiture che le danno da copiare con le sue invenzioni musicali. Una di queste è L’Ester, che sostituirà proprio una delle esecuzioni del maestro Don Antonio Vivaldi, precettore presso l’Istituto. Scoperto il fatto e il quaderno che contiene tutte le composizioni della ragazza – forse proprio perché Lavinia lo confessa al Don, istigata dalla sua amica Orsola – viene pesantemente punita e umiliata durante un giorno in cui sono in gita alle Zattere.
Quel giorno, Lavinia scompare e di lei nessuno saprà più nulla. La vita all’Istituto continua, ma per molte le cose sono cambiate. Orsola smetterà di suonare l’oboe e si cercherà un buon partito da sposare. Il giorno del suo matrimonio le compagne della Pietà la festeggeranno con allegri schiamazzi, mentre lei , quasi sposa, salirà sulla gondola guidata da Iseppo Pomo – futuro marito, invece, di Zanetta. Quel giorno sarà Zanetta a gettare per aria i fogli del quadernino di Lavinia, e sarà proprio Iseppo a raccoglierli e salvarli. In seguito, Orsola e Zanetta si trasferiranno a Chioggia; si ritroveranno tutti i pomeriggi a casa di Orsola a cucire e a ricordare ciò che è davvero accaduto, ciò che non hanno mai davvero compreso, fino a quando Orsola non morirà.
***
Ecco, diciamo che questo è più o meno ciò che succede nel racconto. Però non è il racconto che leggerete. Nel senso che il racconto non comincia con Lavinia. Né con Orsola, né con Zanetta. Lavinia compare all’ottava pagina; mentre il fatto cruciale, la fuga – ciò che potremmo chiamare l’evento scatenante della storia – avviene a metà racconto. A dare inizio alla storia è Iseppo Pomo, proprio nel momento in cui si trova a salvare i fogli della giovane compositrice, di cui lui – tantomeno noi poveri lettori – non sa ancora nulla. Noi, al momento, crediamo che siano solo fogli. Mentre a Iseppo, nella nebbia, gli fanno un effetto strano: Curioso e sveglio, il ragazzo si volta in su e davvero come di uccelli smarriti remiga per la nebbia rarefatta un volo di fogli che l’aria conduce lentamente.
Iseppo è un personaggio che rimarrà lì, nelle prime pagine, come un amo che abbia tirato su un grosso pesce luccicante, e che ritornerà soltanto a tratti, senza che nessuno gli dia troppa importanza fino a quando non si capirà, alla fine, il disegno intricato che ha composto la Banti. Saranno dedicate a lui, infatti, le ultime parole della vicenda: [Orsola] voleva chiederle un regalo, quel loro feticcio, il quaderno strapazzato che affronta il tempo nella casa di Iseppo fornaio.
nel perfetto incastro di questo racconto geometrico, che si chiuderà sfericamente sull’unica persona che ha salvato il quaderno di Lavinia fuggita. L’unica che, in realtà, non ne sa davvero niente.
L’inizio e la fine. È da qui che bisogna partire per capire cosa ci sta in mezzo. Perché la fabula che compone il racconto, così lineare, con gli eventi disposti in ordine cronologico come ve li ho raccontati io, non è il racconto della Banti. Il racconto della Banti più che della storia in sé, vive del suo intreccio. Il racconto della Banti è una perfetta, raffinatissima, quasi miracolosa coesione di forma e di contenuto.
Un contenuto aulico, aderente allo sguardo coinvolto dell’autrice sulla condizione del genere femminile quando si fa artista; sulla voluttà e la potenza di una forza creatrice che impone a chiunque – maschi e femmine – di rompere le regole, di forzare l’ordine delle cose, di superare il limite. E una forma – quella che per Kundera, nella narrativa, è libertà illimitata – a matrioska, in cui ogni evento viene preceduto o anticipato da un altro, che le serve per esaltare, come un pezzetto di vetro nella sabbia, ciò che Lavinia fa, ciò che Lavinia è.
La Banti costruisce questo intreccio per piccoli blocchi narrativi, ognuno dei quali sfocia nell’altro in un silenziosissimo, quasi impercettibile sconfinamento.
Parte, appunto, con Iseppo Pomo che conduce la sua gondola per recuperare la sposa. Presso la banchina la Banti sposta il punto di vista dall’uomo a un’onniscienza più allargata e ci dirotta negli occhi di Zanetta, che vede per la prima volta il ragazzo, ma lui non vede lei. Solo qualche paragrafo più avanti, mentre già voleranno per aria i fogli del quadernetto, Iseppo resterà stregato dal sorriso di Zanetta, che dalla grata della finestra della Pietà ha già visto il suo futuro sposo raccogliere alcuni di quei fogli preziosi. Ma questo – ci dice un’onniscienza ancora più allargata – se lo racconteranno solo più avanti; e la Banti compie il primo flashforward che serve a farci comprendere, nello spazio di pochissime righe, solo due cose: come andrà a finire la storia tra Zanetta e Iseppo e, cosa più importante, che questa è una storia secondaria, di contorno alla principale, che per ora rimane segreta. Insinuazione e indicazione che obbliga il lettore ad essere un partecipante attivo alla lettura, un salto in avanti (il lettore lo intuisce, lo sa) che comporterà un salto all’indietro rispetto al quale deve prepararsi, sentirsi assolutamente pronto.
Questo blocco si chiude (e quando dico si chiude intendo sempre con le parole, perché in tutto il racconto la Banti non inserisce alcuno spazio bianco) con Orsola che sale sulla gondola e in un approfondito flashback in cui ci viene raccontata più dettagliatamente la sua storia; tutto ciò confluirà senza interruzione di sorta, ma solo attraverso un flusso linguistico pieno di grazia, in una piccola magia stilistica in cui l’autrice racconta, in un ritmico, poetico sommario, tutto ciò che la storia ha di nascosto:[…] Iseppo Pomo che da battellante si fece fornaio il giorno che la prese in moglie. Zanetta fresca sposa, Zanetta in duolo perché Orsola è morta senza riveder Venezia […] Zanetta madre e nonna di bambini petulanti, custodì sempre il quaderno di musica come il Bambino di cera, di faccia al letto nuziale.
Fino a questo momento noi crediamo che il tempo presente, quello in cui ci viene mostrato Iseppo gondoliere che raccoglie la sposa, sia il tempo del racconto in cui si susseguono i vari salti temporali avanti e indietro rispetto al tempo della storia. E invece la Banti ci stordisce con un’altra, sorprendente verità: il tempo presente, il tempo del racconto, è quello di un’altra scena, in cui vediamo Zanetta e Orsola – già spose, già madri, già avanti negli anni (ma prima che Orsola muoia – e in questo la Banti dimostra una sopraffina arte dell’intendimento coi suoi lettori, perché sa che noi già sappiamo) – cucire beatamente all’ombra di una lampada fievole, a casa di Orsola. Un passatempo, comprendiamo, quasi giornaliero, che le due donne condividono per rispettare e conciliare un altro bisogno di condivisione più urgente: quello del ricordo della fuga della loro amica Lavinia, una vicenda che non hanno mai davvero compreso ma in cui, soprattutto Orsola, si sente troppo coinvolta. È una condivisione, questa, fatta di silenzi, pensieri taciuti svelati solo al lettore, piccole domande che non vogliono ricevere risposte, allusioni, supposizioni dolorosissime, oppure liberatorie.
Da questo terzo blocco in avanti, il lettore sa che è quella stanza lì il tempo del presente da cui nasce tutto il racconto, tanto è vero che questa immagine comincia a essere raccontata attraverso il passato remoto, per poi trasformarsi, mano mano, in un presente indicativo che non dà scampo. In questo modo la Banti, traslocandoci dall’immagine di Iseppo sul canale, alla reale situazione da cui nascono i ricordi dentro quella stanza del cucito, da cui sarà possibile scaturire il ricordo di Lavinia fuggita, ha inserito noi lettori, noi osservatori, nel ricordo stesso, costringendoci ad agire in un tempo che non esiste più nemmeno per i personaggi, ma facendoci complici di una storia di cui ancora non ne sappiamo nulla.
***
È solo da questo momento che la Banti comincia a raccontare del giorno in cui Lavinia è fuggita, pur restando nel ricordo delle due amiche. Ci trasferiamo così nella storia passata in cui le tre amiche – finalmente Lavinia compare, finalmente la Banti le dà un volto (quel suo magro profilo aquilino e le corde del collo tese come una vecchia, eppure era giovane ma si vedeva che non era una delle solite e sapeva quel che diceva) – condividono la gita alle Zattere, giorno in cui Lavinia viene convocata nel capanno con i direttori della Pietà e il Don, da cui uscirà piangendo. Capiamo che ci troviamo dinanzi a un nodo narrativo importante, anche se non ne conosciamo ancora la causa. La Banti ci ricorda che a raccontarci la storia sono Orsola e Zanetta, attraverso l’incursione di piccole battute fugaci (Cosa le avranno fatto?), che se per un verso ci rassicurano (ok, siamo in un ricordo), da un altro punto di vista ci destabilizzano perché ci fanno intuire che Zanetta e Orsola sanno qualcosa che noi ancora non sappiamo. Sappiamo che una storia segreta si sta aggrovigliando a quella visibile, ma ancora non riusciamo a individuarne un sentiero chiaro.
Durante il ritorno alla banchina, Lavinia si imbatterà in un turco (L’avrà riconosciuta il turco?), e pochi attimi dopo Lavinia scompare.
Da questo ulteriore blocco narrativo, e solo da questo, viene a galla il fatto principale: cioè che Lavinia è fuggita. Ma alla Banti non interessa raccontare la fuga; non le interessa muovere il racconto intorno a un fatto, diciamo, di cronaca, dal facile intreccio. Tanto è vero che sin dal titolo, senza che la Banti abbia pudore a nasconderlo, noi sappiamo che una certa Lavinia fuggirà. Come a dire che l’evento principale, il segreto di una storia, è già da subito svelato.
Alla Banti, infatti, interessa raccontare altro: non il fatto in sé ma come si arriva a quel fatto; quali sono le dinamiche umane, e narrative, che portano una vicenda a costruirsi in quel modo preciso, e cosa ciò comporta in termini emotivi e psicologici in uno o più personaggi. Direbbe Cortázar che la Banti costruisce questo racconto per intensità, più che per tensione, proprio perché attraverso la forma vuole sgranare le maglie di una specifica umanità e per farlo ha bisogno di una struttura che le consenta di accumulare densità, di riempirla di senso.
Da questo nuovo dramma narrativo – in cui la storia segreta viene lentamente svelata – parte la vera storia di Lavinia, in cui viene sviscerata la sua tormentata passione per la composizione, preclusa, o, quantomeno, avversa a qualsiasi comportamento decente, a qualsiasi forma di logica del tempo. La donna esegue la musica, ma non sia mai detto che possa crearla, che possa generare altro che non sia un figlio. La forza creatrice della donna deve riporsi lì, nell’utero, non nelle mani, non nella testa e nell’anima; e la sola idea che Lavinia abbia potuto non solo creare l’Ester, ma addirittura sostituirla a un’opera di Vivaldi, getta la direttrice della Pietà – e l’istituto intero – in una disperazione e in una vergogna indicibili (Così tante innocenti pagheranno per una sola scellerata).
Il lettore sa – perché la Banti glielo ha fatto intuire tenendolo stretto per mano – che tutto questo avviene prima rispetto alla fabula, cioè rispetto all’ordine cronologico della vicenda: nel tempo della storia ci troviamo in un tempo antecedente al giorno delle Zattere, anche se nell’intreccio noi veniamo a saperlo solo dopo.
È proprio questo spostamento a permettere il delicatissimo equilibrio architettonico del racconto, e a rendere edificabile quella che Ricardo Piglia chiama storia segreta: cioè una seconda storia che il racconto nasconde rispetto alla prima. Perché, come dice lui, un racconto narra sempre due storie.
La seconda storia, la storia segreta di Lavinia, viene così a galla da un gioco complicatissimo di incastri e rimandi temporali, e tale segretezza permette alla Banti di fornirle tutta la forza emotiva e di senso che il tormento della ragazza – più che la fuga – comporta.
In tutto il racconto Orsola è forse la voce a cui il lettore si affida di più: è dietro il suo sguardo che si camuffa l’onniscienza del punto di vista, proprio perché è Orsola la testimone delle segrete scritture di Lavinia. Sarà lei, infatti, ad avere il privilegio di eseguire un’aria composta dalla sua amica -esperienza che la rende complice, e che un giorno – nella sua camera del cucito, ormai vecchia – la porterà a chiedere alla sua amica Zanetta: Cosa le abbiamo fatto? Trasformando la domanda iniziale (Cosa le avranno fatto?) in una colpa comune che accusa la società tutta, che si prende il peso di un misero fallimento collettivo.
In dirittura di arrivo, la Banti, attraverso il ricordo di Orsola, insinua una supposizione. Lavinia le parlava dell’Oriente, delle terre del levante da cui era convinta fosse venuta; perché, in realtà, la vicenda, tutta la vicenda, ha a che fare con lo sradicamento, con la forza distruttrice dell’abbandono – quelle delle orfane –che rende quasi vana qualsiasi possibilità di adattamento: Devo tornare laggiù, qui non c’è posto per me, e ho bisogno di spazio. Mi vestirò da uomo, farò il pastore, all’aperto, sotto il sole e la luna.
Una supposizione che non vuole risolvere nulla, che lascia sospeso un epilogo e che intende solo consegnare nella mano del lettore una specie di regalo, di cui sarà compito suo prendersi cura.
Lavinia tornerà da dove è venuta: dal nulla. La chiusura del racconto si consolida intorno alla figura iniziale di Iseppo che conserva e custodisce il quaderno con le creazioni di Lavinia. Al lettore non serve sapere nulla di più. Nulla di meno. Né dove è fuggita, né se tornerà.
Leggere e rileggere questo racconto, significa rileggere ogni volta una storia diversa, perché cambiano le angolazioni, i tempi si schiariscono di continuo, la segretezza della storia sotterranea si fa ogni volta più cristallina e lucida.
Ecco, da cosa deriva questa bellezza propriamente bantiana. Dalla complessità.
La bellezza è la complessità. E raccontare una cosa complessa come la realtà, significa fare i conti con uno strumento – quello della letteratura – che non può, non deve cedere a uno sguardo esemplificativo, che non deve trovare il compromesso con un lettore pigro che si accontenta di uno scrittore pigro.
Nella sua carriera di autrice, spesso incompresa soprattutto dai critici, Anna Banti ha fatto i conti con questa zona d’ombra e molto ambigua che sta a metà sulla strada che fa incontrare un lettore con lo scrittore: una zona in cui ci si chiede, a vicenda, di fare uno sforzo, perché vivere richiede uno sforzo.